
La fontana rotta di Thomas Belmonte è un libro singolare, difficile da incasellare in un genere. Saggio antropologico, autobiografia, romanzo etnografico, la sua unicità non è tanto nel carattere ibrido, e nemmeno nel punto di vista scelto dall’autore – il tentativo di comprendere Napoli osservandola dal basso, indagando la vita quotidiana dei poveri che la abitano –, quanto in una sorta di anacronismo, che la colloca su un binario parallelo rispetto alle cronache e allo spirito del tempo che descrive.
Negli stessi anni in cui lo scrittore newyorchese ripercorre le costanti ancestrali, i caratteri all’apparenza immutabili del popolo napoletano, rappresentandolo senza altro orizzonte che la lotta per la sopravvivenza, quegli stessi poveri di cui parla Belmonte prendono in mano il loro destino, diventando per la prima volta protagonisti della storia della loro città.
Quel che descrive Belmonte dal suo osservatorio non sembra avere molti punti di contatto con la combattività, il desiderio di cambiamento che emana dalle lotte per il lavoro, per la casa, per i servizi sociali, che rompono le barriere tra le classi e si diffondono nei diversi quartieri fin dai primi anni Settanta incoraggiando a ipotizzare un nuovo ruolo degli ultimi nella loro stessa città. I poveri che descrive Belmonte sono invece ancora sulla soglia della storia, e non è scontato che vi possano entrare a breve termine. Nascono poveri e non sperano di sollevarsi da tale condizione. La precarietà economica ne determina ogni passo. Dominati dal potere della ricchezza e della forza, in politica sono cinici e individualisti. Si uniscono per lottare con i loro simili solo in modo saltuario, e secondo umori imprevedibili. Il loro rapporto con le istituzioni è fondato sulla diffidenza e sul parassitismo.
Di origini italiane – i nonni erano della provincia di Bari –, il giovane antropologo americano arriva a Napoli nel ’74, stabilendosi quasi subito in un appartamento in affitto a palazzo Amendola, cinquecentesco edificio incastonato tra i vicoli scoscesi che conducono a via Sedile di Porto, un luogo che nel libro viene indicato con il nome di Fontana del Re. Le vicende degli abitanti di quel posto, trasfigurati dall’autore ma assolutamente reali, costituiscono il fuoco della sua ricerca. Belmonte rimane a Napoli per un anno, tornando a più riprese negli anni successivi. Il suo libro esce negli Stati Uniti nel ’79. Dieci anni dopo sarà riedito con un’appendice che comprende il resoconto del suo viaggio di ritorno nell’83. La fontana rotta verrà tradotto in italiano solo nel ’97, diciotto anni dopo la prima edizione, due anni dopo la morte dell’autore. Da allora non è mai stato ristampato.
Le premesse teoriche della ricerca sono le indagini sulla “cultura della povertà” di Oscar Lewis, anche se Belmonte giunge a considerare questa nozione limitativa rispetto alla “pienezza dei modi di vivere dei poveri di Napoli”. Come per Lewis, la sua attenzione si concentra su un settore della vita sociale, con l’ambizione di risalire ai modelli culturali di un’intera classe. Il suo campo d’osservazione è la famiglia, anzi una famiglia in particolare, quella di Stefano, robivecchi, padre di sei figli, che lo invita a casa sua la sera dopo il lavoro o negli interminabili pranzi domenicali.
Intorno alla tavola, Stefano, la moglie e i figli drammatizzano i conflitti e le tensioni della vita familiare. Nei quartieri poveri, scrive Belmonte, dove la vita si svolge come su un palcoscenico, l’ambito familiare è più intimo e raccolto. La famiglia assimila il male – debolezze, vergogna, paure – ma anche il bene, e lo tiene per sé. La famiglia di Stefano diventa così un archetipo. È organizzata per sopravvivere instillando nei suoi membri l’egoismo e l’astuzia, ma anche lo spirito di sacrificio e di cooperazione. La struttura nucleare è basata sulla comunanza delle risorse. Si mettono in comune le entrate che provengono dai lavori di madre, padre e di tutti i figli sani e non sposati. La madre converte le risorse in cibo e in amore, redistribuendole equamente – almeno in teoria. Tutto sembra ruotare intorno alla sua persona, ma questo non comporta, secondo Belmonte, una struttura matriarcale. La donna può dividere il potere col marito e perfino avere più prestigio di lui, ma non è il capo. Belmonte definisce “matricentrato” questo modello.
Elena, la moglie di Stefano, nonostante si ammazzi di fatica viene spesso lasciata con meno degli altri. È ammirata, autorevole, indispensabile, ma non ha un potere effettivo. Stefano e i figli sono economicamente essenziali. Elena lavora fuori casa solo quando loro non guadagnano abbastanza. La centralità della madre nelle famiglie povere è di solito considerata inversamente proporzionale alla degradazione degli uomini. Lo aveva osservato Maria Antonietta Macciocchi qualche anno prima, durante i suoi giri elettorali nei quartieri del centro. Nell’opinione comune, donne forti e intraprendenti mantengono le famiglie, mentre i loro demoralizzati mariti ciondolano per strada. Ma questo non è vero, dice Belmonte. Gli uomini non sono disoccupati ma temporaneamente occupati. La matricentralità non è il risultato della decadenza del marito, ma del modello radiale e distributivo dell’economia familiare. Le madri insegnano l’amore per la casa e la tenacia alle figlie, la rapacità e l’orgoglio fallico ai figli. Ma l’idea del potere è legata a tutti gli ambiti maschili.
“Ho capito i napoletani del basso ceto vivendo con loro – scrive Belmonte nella prefazione –. Sono arrivato lentamente a conoscerli e quanto più si fidavano di me, tanto più mi permettevano di conoscerli meglio. Il mio approccio non è stato quello di andare a cercare informazioni in modo strutturato, metodico, ma quello di stare attento e di aspettarle, mentre mi muovevo in un ambiente sociale fondamentalmente estraneo. L’osservazione partecipante è stata un mezzo per raggiungere un fine, ma anche un fine in se stessa. Un’immersione nell’alterità, un prolungato ascolto, un’alterazione del sé”.
Il metodo di Belmonte non contempla quindi l’intervista formale o la raccolta di biografie, privilegiando il colloquio libero, il dialogo. L’antropologo non è ossessionato dal resoconto letterale di questi scambi, ma si concentra sui contenuti essenziali, seleziona e utilizza il nocciolo dei discorsi dei suoi interlocutori. L’autore fa inevitabilmente capolino nel racconto, invade il campo dell’osservazione, si fa personaggio tra gli altri, contaminando con la sua presenza, e con una lingua letteraria e sentimentale, le pretese di neutralità e di scientificità della sua disciplina, consapevole che chi osserva è a sua volta modificato dal contatto con gli osservati.
“Le persone che conoscevo a Fontana del Re lottavano per sopravvivere. Spesso combattevano al di fuori delle regole; ne uscivano sempre sconfitte”. Nella sua indagine per decifrare le forme di vita determinate dalla povertà nel contesto napoletano, Belmonte individua due tratti preminenti, che condizionano tutti gli altri: l’instabilità dell’impiego e l’insufficienza dei capitali. I poveri sono preoccupati del denaro fino all’ossessione. Ma il denaro va speso e convertito in vita. È strumento di sopravvivenza, del corpo e dello spirito. Una cronica insicurezza mina le fondamenta della comunità e tormenta gli individui. Per Stefano ed Elena, la coppia che l’ha quasi adottato nel suo soggiorno napoletano, tutto ruota intorno al timore di una vita precaria. L’imprevedibilità della vita economica, per il napoletano povero è il fatto più importante dell’esistenza.
Questa scarsezza di risorse produce competitività sfrenata e sfruttamento reciproco, ma valorizza anche le spinte alla collaborazione e la generosità. La realtà sociale è percepita come uno scenario di battaglia, in cui il benessere può essere raggiunto solo con il sostegno della comunità.
La violenza è endemica a Fontana del Re. Il debole subisce la prepotenza del più forte e allo stesso modo si comporta con quello più debole di lui. Chi non è violento o non ha un parente maschio senza scrupoli, a Fontana del Re è senza difesa. L’uomo ideale è colui che detiene la forza e la ricchezza. A Fontana del Re la dignità del denaro è più grande della dignità del lavoro.
“Il grande anarchico, Mikhail Bakunin – scrive Belmonte –, sosteneva che la gente povera, come quella di Napoli, ‘essendo quasi del tutto estranea alla civilizzazione borghese’, portasse il mondo al vero socialismo. Ma i poveri non sono, ahimè, ‘estranei’ all’incivilimento borghese. Scambiano con la sua moneta e ne accettano le condizioni come servi o imbroglioni. In altre parole, sono seriamente compromessi e non sono in grado di mettere in campo quell’armamentario organizzativo che caratterizza ogni socialismo”.
La paura della fame appare all’antropologo come il principale sentimento che può scuotere i napoletani poveri dal torpore politico, dallo stato di ipnosi indotto dal calcio e dai media. Ma la loro unità non può essere basata sulla condivisione dei rapporti produttivi bensì sulla comune miseria. A differenza degli operai, scrive Belmonte, essi non hanno referenti nelle correnti politiche e ideologiche della cultura di massa. La loro azione politica si manifesta attraverso scoppi improvvisi, la loro forza consiste nella rabbia cieca. Invidiano la ricchezza perché sentono il peso del potere altrui, ma raramente si interrogano sulla legittimità di quel potere. In realtà, quel che più desiderano è l’accettazione delle classi superiori. Per questo ricercano l’eleganza nel vestire, un aspetto dell’identità sociale che può essere manipolato, al contrario del saper leggere e del saper scrivere. I rappresentanti del potere, dagli esattori ai poliziotti, sono per loro persone sospette. Contro maestri e psicologi esercitano almeno il diritto alla protesta verbale. Ma l’istituzione politica che gli abitanti di Fontana del Re conoscono meglio è il carcere, dove molti sostengono di aver trascorso una buona parte della propria vita.
Solo una caratteristica esprime in loro un vero sentimento comunitario, che trascende i confini di classe. Belmonte la definisce “patriottismo urbano”. È il contrario del provincialismo, e viene loro dall’abitare da secoli nei quartieri di una grande città. Questo carattere urbano, insieme ad altre caratteristiche come la socievolezza, l’ospitalità, l’ironia, l’alto senso dello stile, che pure appartengono loro, non sono però il frutto della povertà come viene descritta da Lewis. La loro cultura, scrive Belmonte, “è contro la povertà, abituata alle tensioni della povertà, straziata dalla povertà ma […] è stata anche foggiata dalla grande tradizione mediterranea, nel crogiuolo di una grande città mediterranea. […] Gradualmente diverranno parte di un’unica eredità nazionale. Ma la povertà non è il perno del loro mondo. Ne farebbero volentieri a meno”.
Quanto sono lontane le vite degli abitanti di Fontana del Re da quelle dei disoccupati napoletani che nello stesso momento, sul finire del ’74, scendono quotidianamente in piazza organizzandosi in un movimento autonomo e che Fabrizia Ramondino raccoglie scrupolosamente in un volume del ’77, lasciando che quelle voci le “passino attraverso” per arrivare fino a noi. La distanza non riguarda tanto le esperienze di vita – ché i risvolti picareschi, la lotta per sopravvivere, la ricerca di un ancoraggio solido contro la precarietà (il “lavoro stabile e sicuro”) emergono anche nelle storie dei disoccupati –, quanto un diverso ardore, una speranza nel futuro, l’orgoglio di esibire una coscienza politica di fresca acquisizione, che filtrano dalle parole di questi ultimi. Forse qualcosa sta cambiando davvero, i processi sociali che hanno preso avvio nel secondo dopoguerra e che maturano nei primi anni Settanta cominciano a influenzare il modo in cui i poveri guardano al loro posto nel mondo. Ma si tratta di potenzialità che andrebbero sostenute con impalcature più solide, che le avanguardie politiche e sociali – che questi processi hanno contribuito a mettere in moto – non sono in grado di assicurare con le sole forze di cui dispongono. Il mutamento auspicato non si realizzerà; ne arriverà un altro, di segno inverso, una repentina deriva verso l’annullamento e l’autodistruzione.
Il fascino della Fontana rotta risiede allora in questa collocazione sfasata, nel modo in cui lo sguardo dell’antropologo si posa su un mondo arrivato al capolinea senza averne il sospetto. Perché la stagione dell’impegno e dell’emancipazione si rivelerà illusoria e le conquiste dei disoccupati, delle donne, dei loro figli verranno deluse e rinnegate nel giro di pochi anni, ma anche i caratteri di quel microcosmo cristallizzato che aveva alimentato le analisi di Belmonte, subirà dagli effetti del terremoto dell’80, dalla diffusione delle droghe pesanti, dalla dispersione fisica della comunità, un impatto che lo renderà, nel giro di pochi anni, irriconoscibile agli occhi del suo stesso cultore.
Quando torna a Napoli nell’83, sia l’autore che la città sono infatti molto cambiati. La fontana rotta ha avuto un insperato successo. Recensito due volte dal New York Times, viene candidato per il premio Pulitzer. Belmonte è diventato docente alla Hofstra University di New York e l’obiettivo del suo ritorno è continuare la ricerca per conto della fondazione National Endowment for the Humanities. Lo scenario in cui ricomincia a muoversi è segnato dalle conseguenze del terremoto, ma in un’intervista al Mattino del novembre ’83, Belmonte elogia la capacità dei napoletani di superare le difficoltà, “di difendere la loro umanità, il che testimonia la vitalità di una cultura, che non è semplicemente di povertà, ma al contrario di grande ricchezza umana”.
L’appendice che compare nella seconda edizione del libro è una sorta di malinconico reportage in cui Belmonte mette da parte bibliografia e citazioni per lasciar emergere il malessere degli ambienti in cui ha svolto il suo apprendistato della città, insieme ai crescenti dubbi sulla legittimità del proprio ruolo, sull’incapacità di instaurare uno scambio sincero e non strumentale con le persone con cui è venuto in contatto. E lo fa raccontando la sorte dei numerosi componenti della famiglia di Elena e Stefano, da lui conosciuti durante il periodo dell’infanzia e della prima adolescenza: Giuseppe, che ha vissuto in collegio dai dieci anni fino alla maggiore età, è diventato tossicodipendente; Ciro, il secondogenito, è in carcere, catturato in flagrante durante un’estorsione per conto della camorra; Pasquale, il capro espiatorio della famiglia, quello che dopo tanti maltrattamenti aveva provato a suicidarsi ingoiando il veleno, lavora in una pizzeria in Germania e pare a suo agio nello stile di vita tedesco; Nina, l’unica femmina, è diventata cantante, neomelodica si direbbe oggi; Gennaro, il primogenito, fa lo spazzino, è molto religioso e ha acquisito fama di esorcista; infine Robertino, l’ultimogenito, un tempo iperattivo e viziato, lavora in una fabbrica di lavorazione pelli nello stesso edificio dove abita la famiglia.
Nel giro di dieci anni, scrive Belmonte, la vendita e l’uso di stupefacenti sono diventati un tratto onnipresente della vita a Fontana del Re. Gli antichi scippatori sono aumentati di numero e adesso sono armati, il crimine organizzato riempie il vuoto politico e imprenditoriale creato dal fallimento delle istituzioni. La famiglia sembra l’unica istituzione sopravvissuta.
In preda alla febbre, l’autore si aggira di notte per una città che non sa più riconoscere. I riferimenti di un tempo sono scomparsi; le automobili, rumorose e aggressive, hanno preso il sopravvento, mentre nei vicoli il dialetto si mescola ai suoni delle soap americane e dei cartoon giapponesi sparati a tutto volume. In una taverna incontra Leah, prostituta danese conosciuta nel suo primo soggiorno, ostinatamente legata alla città nonostante la vita tribolata, o forse solo un alter ego femminile dell’autore. “È tutto finito Tommaso – gli dice la donna in lacrime –. Niente tornerà più com’era. Napoli mia… C’era una cultura qui, no? Una cultura popolare? Sei tu l’antropologo! Una cultura, durata per secoli, ora distrutta per sempre. Finito! Morto! Tutto ciò che ho amato qui, ciò che una volta era così vivo, ora è morto”.
L’ottimismo che aveva manifestato al suo rientro in città svanisce con il passare dei giorni, e con esso le sicurezze riguardo a quello stile di ricerca su cui aveva basato la sua carriera di professore e scrittore. “Nel 1974 – scrive – come studente laureato alla Columbia mi era stato insegnato di fare domande su altri, ma mai a chiedermi se avessi una ragione plausibile o il diritto di porre innanzitutto le domande e in secondo luogo di pubblicare le risposte. […] Quando ritornai a Napoli non ero più lo studente idealista di dieci anni prima, sicuro che i miei amici avrebbero apprezzato la mia ricerca per i suoi argomenti e per gli stessi motivi per cui l’avevano apprezzata i miei colleghi e i lettori. In realtà sapevo che scrivendo La fontana rotta avevo commesso un tradimento, ma speravo di farla di nuovo franca”.
Il nuovo progetto, infatti, consiste nella registrazione accurata delle vite delle persone descritte nel primo libro. Tutti i materiali sarebbero stati ordinati e commentati in modo da comporre un intreccio di biografie di persone povere, a testimoniare “la capacità umana di trasformare la sofferenza in saggezza”. Ma Stefano, la sua fonte privilegiata, quello a cui confida per primo il suo intento, si rifiuta in maniera netta di raccontargli la sua vita. Il progetto resterà tale. Almeno per un po’ l’urgenza delle vite che lo circondano prenderà il sopravvento sull’esigenza di comprendere, di interpretare, forse assecondando il segreto desiderio che quella cultura che l’aveva interrogato tanto a lungo, “rimanesse inafferrabile e misteriosa anche all’analisi più accurata”.
Thomas Belmonte morirà per un tumore al cervello nel 1995. Le sue ceneri verranno disperse dalla figlia nel golfo di Napoli. (luca rossomando)



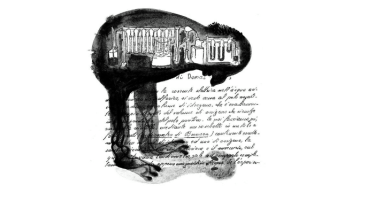

Leave a Reply