
Da oltre un mese molti hanno preso la parola sul tema della violenza giovanile – che in breve è diventato emergenza nazionale – portando così alla ribalta le paure che prima appartenevano solo ad alcuni pezzi di città. Nel crescere i figli in alcuni quartieri si convive con la paura, fa parte del gioco. Ma se arrivi a pensare di non poterli lasciar andare significa, per noi adulti, rimanere prigionieri del terrore e, per loro, non riuscire a vivere quel meraviglioso tempo della scoperta che è l’adolescenza.
Mentre scrivo anche il presidente della Cassazione ha usato quelle due parole in inglese: non c’è un’espressione della lingua italiana per sostituirle? Io invece mi rifiuto di pronunciarle. Qualche esperto potrebbe dire meglio di me quanto peso ha nelle dinamiche cognitive il fatto che queste parole vengono diffuse migliaia di volte al giorno. Il linguaggio ci forma, il linguaggio ci guida. Parlare nei toni e con le parole di vittime e carnefici con l’ormai grottesca autoreferenzialità con cui Napoli continua a darsi in pasto alla cronaca non fa avanzare di un passo il pensiero di una comunità che appare sconfitta e che non può lasciar passare questo momento semplicemente rimuovendolo.
Ho letto gli interrogativi di Giuseppe Montesano sull’incapacità degli adulti di parlare con parole umane ai propri figli e il monito di Aldo Masullo a capire come e chi non ha avuto cura di questi giovanissimi oggi. La genitorialità è un tema che sta alla base della povertà educativa delle ultime generazioni. Molti di questi genitori lo sono diventati loro malgrado e spesso provenendo da famiglie in cui loro stessi, come figli, erano un problema. Quale umanità, quale cura, quale amore sta in molte famiglie di una larga parte di città? Ci sono storie di genitori che hanno ribaltato questo destino, ma molte altre in cui il destino dei figli è perfino diventato più buio perché anche alcuni legami più antichi e tradizionali ormai sono stati spezzati. Una volta ho presentato il film Le cose belle in un cineforum del Vomero; nel dibattito finale alcune anziane signore che non erano mai state in vita loro a Ponticelli o a Giugliano, a pochi chilometri da casa loro, erano così scosse da quelle storie di figli e madri di quell’altra parte di città, da dirmi a muso duro che un film così non andava diffuso. Era evidente che di quella Napoli che non conoscevano provavano vergogna. Questo episodio mi è tornato alla mente quando ho ascoltato i tanti benpensanti che in questi mesi hanno individuato in Gomorra il vero pericolo per Napoli: è lo stesso riflesso auto-censorio.
Ma cosa serve agli adulti per fare i genitori? Il lavoro, ciò che più di tutto può darti dignità e una identità, non c’è e non sai dove cercarlo, lo sappiamo. Allora diventano ancora più decisivi i servizi e la normalità quotidiana di una città che si fa comunità: niente di così speciale, una parola semplice, tanto meravigliosa, quanto tradita. I diritti di cittadinanza come la scuola, l’ambiente, lo sport, le biblioteche, il trasporto pubblico, gli ambulatori.
La scuola a tempo pieno per i figli di tutti proprio come nel centro e nel nord Italia. Una scuola che ha la mensa colorata, il giardino curato, la biblioteca, le palestre e i laboratori sempre aperti, non solo quando arriva il finanziamento ad hoc che se parte a febbraio è una fortuna, obbligando i ragazzini a stare nelle classi a luglio per completare le ore da pagare ai consulenti. No: solo una scuola che fa la scuola, senza aggettivi. Era uno dei punti fondamentali del programma del sindaco de Magistris quando mi aveva convinto a sperare in lui (l’autrice è stata assessore comunale alla cultura dal giugno 2011 al maggio 2013, ndr). Obbligare il governo a far funzionare le scuole a Napoli in modo ordinario fino al pomeriggio. Il divario nord-sud in questo paese comincia negli asili nido, nelle scuole dell’infanzia. La scuola a Napoli: l’unico motivo per cui, come governo cittadino, sarebbe valsa la pena andare tutti i giorni a Roma. E anche rimanerci, se necessario.
Invece le esperienze positive a Napoli in tal senso si contano sulle dita di una mano: le solite eccezioni demandate alla buona volontà di qualcuno. E poi ci sono le storie tragiche. Ma forse, più che tragiche, inverosimili. Come l’esperienza bellissima dell’asilo nido al Lotto O di Ponticelli aperto e chiuso in due anni senza spiegazioni, senza qualcuno che abbia detto “ho sbagliato”, dando l’illusione a decine di mamme che fosse possibile non tenersi i bambini in casa tutto il giorno, tutti i giorni dell’anno, che fosse possibile per loro vivere la maternità non come una maledizione: cercare un lavoro, vivere la vita. Un’altra ferita, inferta sul medesimo territorio che nel 2000 ha visto la distruzione (in senso letterale) di una scuola del proprio quartiere per realizzarvi una mitologica Città dei Bambini, mai realizzata e oggi eco-mostro impunito, idea di un lungimirante assessore che gestisce le scuole private più ambite dagli intellettuali di sinistra della città.
E invece qualcuno ha idea di quanti sono i bimbi del Lotto O che nei primi anni di vita non escono mai di casa tranne che per andare dal pediatra? Non si immagina neppure di fare una passeggiata o andare al parco. Per passeggiare dove? Sugli stradoni che l’arrivo dell’Ospedale del Mare ha reso addirittura più invivibili e pericolosi? E in quale parco? Sul sito web della Municipalità (la Sesta) ne compaiono ben sette, ma fatta eccezione per il parco Troisi (che tutti chiamano “il laghetto”, anche se il laghetto è prosciugato da anni), tutte le altre aree verdi sono chiuse al pubblico, abbandonate, senza futuro. Una municipalità di centodiecimila abitanti in cui non ci sono parchi. Ve le immaginate città come Ancona o Trento senza parchi pubblici?
L’ho imparato dai miei figli: oltre la scuola, è lo sport il modo più sano per riempire la vita degli adolescenti, e con lo sport la cura di un obiettivo comune, la passione, l’amicizia, le emozioni che ti fanno crescere. Le politiche educative a Napoli dovrebbero essere rifondate mettendo al centro l’educazione fisica e lo sport per i bambini della città. Ma invece di andare avanti si va indietro. Dall’anno scorso, oltre ai casi eclatanti del Palargine o del Palastadera, molte palestre degli edifici scolastici sono state negate alle attività sportive per mancanza di attestati di agibilità o per altro genere d’incuria. Non parliamo delle decine di strutture all’aperto, molte realizzate proprio in periferia nell’ambito dell’intervento post-terremoto, tutte condannate all’autodistruzione. Chi invoca l’autorganizzazione, i percorsi “dal basso”, com’è avvenuto negli ultimi anni nelle zone del centro città, mostra di non aver capito nulla della crisi sociale che vive larga parte della metropoli. Questi genitori scassati non hanno le forze, la cultura, non hanno le energie mentali, non hanno la vitalità per crearsi – ammesso e non concesso, poi, che sia davvero la strada giusta – il proprio parco, la propria scuola, la propria palestra. Queste famiglie, queste moltitudini, che facciamo fatica a chiamare “cittadini”, neppure protestano più. A Napoli fa notizia se si ferma per due ore la funicolare, ma nessuno s’indigna se in interi quartieri il diritto alla mobilità è negato tutti i giorni dell’anno.
In questo quadro di normalità mancata c’e stato, e faticosamente resta, il lavoro prezioso di quelle persone impegnate in progetti di prossimità sociale. In uno scritto recente Luca Rossomando ripercorre la storia di quell’attivismo che guardava lontano, capace di immergersi nei territori e scoprirvi luce propria; e parla anche di chi ha saputo osservare e raccontare le “due città” attraverso il cinema, come Capuano e Di Costanzo. Sono d’accordo con lui: a molti politici, operatori della sicurezza, magistrati, amministratori varrebbe la pena far vedere qualche film per aprire loro gli occhi su una realtà che conoscono soltanto attraverso la cronaca. Perché la cronaca non è la realtà: non ne ha né lo spessore, né la profondità. E, ahimè, in questa piattezza finiscono anche tante espressioni di solidarietà, i cortei, le targhe o le lapidi-ricordo, di cui le nostre strade si riempiono giorno dopo giorno. E le tante parole.
Ma poi Rossomando scaglia un macigno. Dove sono gli operatori sociali? Perché restano in silenzio? Perché non si riuniscono ed esprimono un pensiero? Nel mio piccolo, mi sento chiamata in causa. Ho iniziato a lavorare nel mio quartiere anche, forse soprattutto, dopo un episodio luttuoso che colpì la mia famiglia, sempre pensando che nell’incontro tra i bisogni e le vocazioni delle persone si potesse trovare la speranza del cambiamento. Ed è vero: oggi sento un silenzio. Un silenzio pesante, che forse interrompe il filo dei pensieri. Si avverte il peso di questi quasi trent’anni in cui quelle cose “normali”, ma fondamentali, si sono perdute, e oggi appaiono più lontane che mai. Se una parte di città non ha più coscienza dei propri diritti, l’altra città non riconosce il problema come proprio, e accorcia le distanze solo quando ha bisogno di alleviare il proprio senso di colpa. Pesa la difficoltà a guardarsi indietro e a riflettere sugli errori commessi.
Il lavoro sociale è diventato mestiere. Sui progetti per i “minori a rischio” si sono costruite carriere burocratiche. Le stesse scuole, baluardi nel lavoro quotidiano, sono costrette alla gara per la “visibilità”, unico elemento, a volte, che sembra consentire e addirittura giustificare un’esistenza e persino un effimero successo. Così avviene che alle testimonianze delle persone, quelle capaci di stare davvero dalla parte degli ultimi, si sostituiscono i testimonial di turno.
Ma se questo vuoto dentro è comune a molti, e fa male, allora è lì che bisognerebbe intravedere un segno di ripartenza. Il ruolo dell’operatore sociale come agente di cambiamento ha senso, e lo dimostrano le tante esperienze che ancora resistono (come alcune Educative territoriali nate da quella straordinaria stagione iniziata con la Legge nazionale 285 del 1997) quando riescono a rappresentare una visione più complessa. Quello che non si può più accettare è che le azioni dello stato, inteso nel suo insieme, siano semplicemente reazioni ai fatti che avvengono. È (ovvero sarebbe stata) necessaria una linea di condotta coerente su una idea di città.
Quando ero bambina alle elementari la maestra ci faceva sedere in classe mescolando apposta alunni provenienti da diversa estrazione familiare. Oggi lo squarcio tra le “due città” si apre all’interno degli stessi quartieri, della stessa scuola. In quella stessa scuola elementare di Ponticelli dove mi ero trovata seduta a fianco del ragazzo di strada, dopo trent’anni i miei figli si sono ritrovati in classi “selezionate”. A quei tempi a scuola si andava a piedi, noi bambini da soli, mano nella mano e il vigile fermava il traffico per farti attraversare. Oggi i nostri figli la camorra l’hanno hanno potuta conoscere fin dai primi giorni di scuola: col parcheggio dei Suv in terza fila davanti ai cancelli, senza che nessuno fiatasse.
È nato un mondo nuovo in questi ultimi anni, un mondo che non ci aspettavamo e che ci ha colto di sorpresa. Cresciuti con i cellulari come protesi, i nostri ragazzi è come se vivessero più di quanto, nell’epoca non digitale, si poteva vivere nel medesimo tempo. Nella vita riflessa in uno schermo dove si può vedere il male a ogni istante, si diventa più vecchi e più cinici; tutti, vittime e carnefici. C’è qualcosa che somiglia a una sorta di “assuefazione alla morte” in queste generazioni digitali. E dunque, pensiamoci, e guardiamoli, tutti, questi ragazzi. Non ci accade forse di restare sbalorditi per la loro indifferenza di fronte a episodi gravissimi, come il suicidio del genitore di un compagno di classe, o una lite furibonda tra compagni, come se in fondo, a questo e altro gli occhi e il cuore fossero già abituati. Insomma, il male è già vissuto, sotto la pelle. Ma se alzano lo sguardo, e ci vedi l’anima, eccola lì: quanta inaudita fragilità. (antonella di nocera)



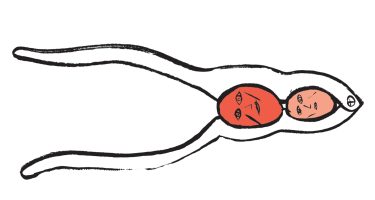
Leave a Reply