
La campagna per le elezioni amministrative a Napoli non ha dato, e non poteva dare, alcun inedito elemento di analisi né di prospettiva sui problemi più urgenti della città. Una campagna più simile a quella di un piccolo paese che non della terza città d’Italia, in cui la proliferazione di liste nate in un contesto di amicizia o di dipendenza economica o peggio ancora di soggezione politica, testimoniano il dissolvimento dei partiti e della società civile, lasciando traccia solo delle piccole carriere e dei destini personali.
In un contesto simile, poco importa chiedersi se la candidata Alessandra Clemente saprà realizzare qualcosa di diverso dal nulla messo insieme dal suo mentore Luigi de Magistris in dieci anni da sindaco; o sulla credibilità del candidato Antonio Bassolino, la cui carriera politica si è chiusa ingloriosamente più di un decennio fa e la cui ostinazione appare ormai tanto patetica quanto inopportuna; o ancora provare a stabilire se Gaetano Manfredi, il vincitore designato nel ballottaggio col candidato di destra, saprà smarcarsi dalla ingombrante tutela di Vincenzo De Luca, dal momento che se anche quest’ultimo dovesse magicamente sparire all’indomani delle elezioni, lo stesso Manfredi non avrebbe altro da proporre che una linea di governo del tutto conforme a quella del presidente regionale.
Allora possiamo tentare, sforzandoci di onorare questa imprescindibile per quanto sempre più ininfluente ricorrenza, una breve riflessione a partire dal nostro punto di vista, dai nostri strumenti e obiettivi, dalla nostra irriducibile irrilevanza ma anche dal senso di un lavoro che dura da tre lustri e talvolta, non sempre, ci sembra conservi ancora qualche ragion d’essere nonostante l’estraneità e l’isolamento crescenti.
Cominciamo allora proprio da queste ultime – come dire – sensazioni; cioè dai rapporti con chi ci sta intorno, dal momento che il nostro lavoro, pur rivolgendosi a tutti, intrattiene un dialogo privilegiato con un nocciolo duro, una cerchia abbastanza ampia e indefinita di persone, di orientamenti diversi ma in ogni caso partecipi della vita pubblica, mediamente informate, propositive, critiche sulle vicende politiche e culturali della città (questo vale anche per lettori e lettrici di altre città, ma qui parliamo di Napoli).
Durante la pandemia questo tipo di presenza pubblica si è notevolmente appannata, in parte per ragioni oggettive, in parte per una strana inerzia che ha attecchito anche negli ambienti più reattivi. A lottare in piazza perché bambini e adolescenti campani non venissero privati della socialità e di un intero anno di scuola, per esempio, sono state sparute minoranze, mentre molti di quelli che avrebbero dovuto affiancarle sono stati a guardare, se non a biasimare. E anche alle manifestazioni più nutrite che un anno fa portarono in piazza una folla esasperata dai ricatti dell’ignobile De Luca, nessun gruppo di base è riuscito a imprimere una fisionomia più stabile e duratura, insistendo magari sulle richieste economiche (“Tu ci chiudi, tu ci paghi”) laddove quel che ormai viene messo in discussione, sotto il pretesto dell’emergenza, è il senso stesso e la possibilità della vita associata.
In campagna elettorale molti hanno rimesso la testa fuori. Abbiamo ascoltato vaghi discorsi sull’importanza della scuola, sulla nocività della Dad, sulle diseguaglianze crescenti nella nostra città, discorsi pigri e a costo zero che non saranno seguiti da alcuna azione conseguente. Nella corsa alla candidatura, sempre più velleitaria, sempre più scollegata da progetti credibili e unitari, si sono distinti anche stavolta, secondo una tendenza consolidata, numerosi membri di gruppi un tempo definiti “antagonisti”.
Che cosa spinga chi fa politica di base a intrupparsi nel pantano istituzionale è un mistero che continuamente ci interroga e per il quale non abbiamo che risposte desolanti. Al netto della parabola che sempre coinvolge quella parte di “ceto politico” che si annida in ogni “gruppetto”, ciò che scoraggia è il mutamento culturale avvenuto in questi anni, lo spostamento verso parametri, obiettivi e interlocutori sempre più generici, l’assurdo credito che viene concesso a una classe politica che non ha fatto nulla per meritarselo. Come si possa pensare che degli odierni candidati a sindaco ce ne sia almeno uno che abbia anche solo la volontà, per non dire la capacità e la perseveranza, di approntare e poi mettere in atto politiche che assicurino, per esempio, una stringente lotta alle diseguaglianze, l’estensione e la manutenzione degli spazi pubblici, l’agibilità e l’efficienza degli istituti scolastici, il diritto alla casa delle famiglie povere e delle minoranze, una riconversione industriale in tempi certi e al servizio dei lavoratori e dei quartieri, il rispetto delle regole a difesa dei lavoratori e del patrimonio pubblico nelle aree sottoposte a pressione turistica – tanto per citare qualche “misura minima” che dovrebbe stare a cuore ai militanti di base –, è una domanda tanto banale quanto abitualmente elusa.
La tendenza a credere che la battaglia “dentro le istituzioni” possa portare a qualche risultato apprezzabile ha toccato negli ultimi anni il suo punto di massima estensione e, inevitabilmente, di maggiore inefficacia. Diversi quadri provenienti dai “centri sociali” (per dirla con Repubblica) si sono cimentati come assessori e consiglieri comunali, presidenti, assessori e consiglieri di municipalità. Un demagogo di talento come Luigi de Magistris, scegliendo la vernice “rivoluzionaria” per colorare la sua scalata politica, ha aperto il varco per l’incontro con le realtà autogestite. La protezione legale assicurata ad alcune sedi occupate gli è valsa un diffuso consenso in quegli ambienti, ma soprattutto l’accesso a un serbatoio di personale politico con cui alimentare le fila del suo fluttuante schieramento. Oggi possiamo dire che il sindaco uscente non ha poi mostrato grande interesse o senso di responsabilità verso la maturazione di questa possibile futura classe dirigente. Negli ultimi mesi il turn-over tra i suoi sostenitori è diventato addirittura frenetico, scatenando guerre tra fazioni sempre meno legate a concreti fattori politici o amministrativi, finché il capo non ha abbandonato tutti al loro destino per dedicarsi alla propria campagna elettorale in Calabria. Invece di scendere dal treno, parecchi dei suoi orfani sembrano ostinati a proseguire: alcuni con quel che resta della vecchia guardia; altri, per continuare il viaggio, hanno preferito cambiare vagone.
Ne è valsa la pena? Ne vale la pena? La profusione di tempo ed energie per conquistarsi una posizione di agibilità all’interno delle istituzioni è proporzionale ai risultati ottenuti per la collettività o risponde a logiche ben più ristrette? E, soprattutto, come si compensa il vuoto che si crea quando i punti di riferimento di un gruppo o di un territorio si allontanano in direzione del Palazzo? Sono vecchi dilemmi. Quel che ci rincuora, nel deserto prodotto dall’emergenza, sono gli indizi di una superstite voglia di ragionare e di organizzarsi fuori da ogni tutela, o di reagire ai soprusi senza attendere riscontri o autorizzazioni. Ma stare attivamente nei quartieri, nelle strade, negli spazi pubblici, diventa ogni giorno più complicato. A inizio pandemia c’è stata, in molte città d’Italia, un’ondata di solidarietà verso le persone in difficoltà, organizzata anche dai gruppi di base. Un movimento con potenzialità a cui oggi sembra difficile dare un seguito, anche a causa della confusione che avvolge gli obiettivi e gli interlocutori di ogni azione sociale.
Su questa confusione di ruoli e funzioni, e naturalmente sull’enorme leva della precarietà economica, si basa l’ascesa del terzo settore in città, in particolare quello più “politico” e scafato, che in queste elezioni si sta giocando la sua scommessa più ambiziosa. L’assistenza, la “rigenerazione”, la “coesione sociale”, nei quartieri sono loro a realizzarla, le grandi associazioni e cooperative impropriamente denominate “no profit”, e in nome di questa crescente assunzione di responsabilità, non più solo sociale ma anche urbanistica, economica, culturale, adesso chiedono ai governi, in maniera sempre meno velata, di avere voce in capitolo sulle decisioni politiche.
A Napoli il loro alfiere si chiama Sergio D’Angelo, emblema della trasversalità (o dell’ambiguità) del settore, il personaggio che a un certo punto della sua carriera riuniva nella sua persona tutti e tre i poli di ogni moderna dialettica tra capitale e lavoro: assessore comunale, portavoce delle richieste dei lavoratori e presidente di un grande consorzio di imprese sociali.
Anche stavolta D’Angelo si è fatto trovare pronto, allestendo una candidatura-civetta con l’obiettivo, puntualmente realizzato, di farsi inglobare come “ala sinistra” nello schieramento di Manfredi. Ma, va detto chiaramente, con i dirigenti del terzo settore la “sinistra” c’entra ben poco. Le imprese sociali sono strutturalmente incapaci di generare emancipazione, sia per i loro utenti che per i loro dipendenti, piuttosto si limitano a gestire, per conto dello stato, la grande massa dei diseredati prodotti da un sistema escludente e, a Napoli, da una città in cui l’inefficienza e il classismo del ceto dirigente riproducono e moltiplicano l’emarginazione.
Il terzo settore negli ultimi vent’anni ha incrementato il suo raggio d’azione e la sua influenza, ma non ha spostato di una virgola le diseguaglianze su cui pretende di intervenire. E non le sposterà nemmeno quando la politica gli farà spazio nei suoi organi decisionali, adeguandosi alla prassi delle “porte girevoli” tra pubblico e privato operante ormai in tutti i settori nevralgici dello stato. Non può farlo perché si fonda sulla precarietà e sullo sfruttamento della forza lavoro. Una precarietà che cresce di pari passo con i suoi profitti e con il suo peso politico. Ma finché la vicinanza con bambini, adolescenti, giovani e famiglie marginali verrà affidata a educatori, educatrici, operatori sociali precari, sottopagati, scarsamente formati e stabilmente sotto il ricatto dei datori di lavoro, non ci potrà essere prospettiva di emancipazione, né per gli uni né per gli altri.
L’emergenza vera nella nostra città, il tema di fondo che nessuno più affronta perché acquisito come un dato immutabile, è l’esclusione della maggioranza dei cittadini da ogni reale partecipazione politica. È un tema talmente drammatico e ingombrante che nessuno sembra vederlo. Nemmeno quel che resta degli intellettuali, che dovrebbero invece farsi carico di sollevarlo continuamente, in ogni sede, come premessa a ogni loro discorso; avendo cura di tenere separate le cause dagli effetti, le vittime dai responsabili, e adoperandosi per indicare gli antidoti.
Questo non accade, nemmeno per sbaglio. Ora nell’università napoletana in molti gongolano perché un ex rettore sarà il prossimo sindaco, confidando magari in un occhio di riguardo, nell’accesso a maggiori risorse per la ricerca, per la didattica, per la formazione. Ma se anche riuscissero a farle queste benedette ricerche, se mai riuscissero a formare dei giovani studiosi finalmente all’altezza, a cosa servirà se continueranno a ignorare la necessità di condividere davvero quelle conoscenze, di imporle nel dibattito pubblico, di metterle al servizio di chi potrebbe servirsene?
Il coinvolgimento, la consapevolezza, i rapporti di forza, si costruiscono nei luoghi di lavoro e nello spazio pubblico, allargando un po’ alla volta le occasioni di unità e di rivendicazione. Ci stanno provando i disoccupati organizzati – non a caso sollecitati a un incontro da tutti i principali candidati a sindaco –, che hanno saputo rinnovare una lunga tradizione di lotta riannodando il dialogo con i tanti margini della città. La sfida, anche per loro, è di mantenersi attivi in una cornice di critica complessiva al sistema, non di semplice risoluzione dei problemi.
Ogni intervento di base, anche nelle situazioni più estreme, ha la necessità di restare politico. E l’intervento sociale deve guardarsi dal diventare assistenza, assumendo su di sé responsabilità che non gli competono. Se ha il coraggio di non farsi ingabbiare dagli aut-aut del potere, se non insegue improprie espansioni, ma è capace di mettere a punto un metodo, un modello a partire dal quale estendere le relazioni, produrre conoscenza, criticare l’esistente, l’azione di base non ha alcuna necessità di cercare altrove la propria legittimazione.
Le precedenti amministrative a Napoli (2016) hanno visto l’astensione del 46% degli aventi diritto al voto al primo turno, e del 64% al ballottaggio. Ovvero, prima la metà e poi i due terzi degli elettori non hanno risposto alla chiamata. Sono percentuali che non cambieranno molto a questo giro. È un sintomo eclatante, per chi vuole vederlo, che di questo tipo di “partecipazione” i cittadini non sanno più che farsene. È allora possibile che molte più persone di quelle a cui possiamo rivolgerci siano ormai disposte a confrontarsi su questi temi, e su queste posizioni. È possibile insomma che, per una volta, quelli strani, la minoranza un po’ eccentrica, non saremo noi ma quelli che si recheranno alle urne. (napolimonitor)



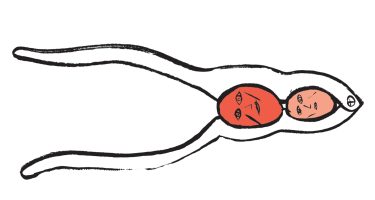
Leave a Reply