
L’11 agosto 2021, al risveglio, un messaggio ha catturato la mia attenzione: “Questa notte è andato a fuoco il campo di Barra. Tutte le baracche rase al suolo”. Una forte sensazione di déjà-vu, per chi, come me, segue da anni l’impervio percorso di vita delle popolazioni rom.
Il messaggio proveniva da un amico, ex operatore di un’associazione impegnata nella scolarizzazione dei bambini dell’insediamento informale di via Mastellone-Cupa Cimitero, nel quartiere Barra, periferia est di Napoli. L’insediamento era nato a inizio anni Duemila per effetto di vari sgomberi forzati di altri campi. Negli anni si è ampliato, sempre come risultato di molteplici sgomberi. Nell’agosto 2021, secondo un censimento curato dall’associazione NEA, contava circa ottanta famiglie, con ottanta minori, cinquanta dei quali in obbligo scolastico, e centoventi donne, per un totale di circa quattrocento persone. L’area su cui sorgeva si estende per circa sedicimila metri quadri, su un terreno di proprietà demaniale e privata.
LA VITA VA COSì
Arrivato in prossimità dell’ospedale Villa Betania, comprendo la gravità dell’incendio. Fumo intenso in tutta la zona, aria irrespirabile, detriti fluttuanti nel cielo. Giunto sul posto, vivo l’ennesimo déjà-vu. Vigili del fuoco e polizia presidiano l’ingresso della stradina di via Cupa Cimitero, sui lati. I volti dei volontari, da sempre impegnati a supportare gli abitanti dell’insediamento, al centro. Circa centotrenta “inquilini” del campo, tra essi almeno cinquanta bambini, appoggiati sulle proprie auto parcheggiate in fila indiana con sguardi rassegnati e stanchi, a definire la cornice della fotografia.
Scorgo tra i tanti N., 45 anni e tanti figli. Resto colpito dal suo sguardo: spento, vacuo. Come se avesse vissuto questa esperienza cento volte. Gli chiedo come va in rumeno e lui mi risponde con una frase tipica del popolo rom: «Ce sa fac, viata asa este». Che dobbiamo fare, la vita va così. N. ha di recente scoperto di avere il diabete e, con grandi sforzi, cercava di modificare il proprio regime alimentare. Con altrettanta difficoltà, supportato da una ONG locale, era riuscito a districarsi nella burocrazia sanitaria napoletana, arrivando a certificare il proprio diabete e riuscendo a prendere gratuitamente presidi e medicine. «Ho perso tutto nell’incendio, documenti, medicine e referti medici. Puoi aiutarmi?».
Poco dopo incrocio D., 23 anni, e a pochi metri da lei la figlia, M., di 6 anni, cardiopatica dalla nascita. Riconosco subito il corpicino scheletrico e lo sguardo vitreo che cela, però, un’intelligenza fuori dal comune. Con grande dedizione, l’associazione sanitaria locale ha costruito con lei e la famiglia un percorso di cura presso l’ospedale Monaldi. «Am pierdut tot acolo, si actele de la spital, cum sa facem?». Ho perso tutto nell’incendio, anche i referti medici, come faccio adesso? Poi mi si avvicina S., 26 anni e due figli, che due anni fa riuscì a portare via dal campo la famiglia, affittando un piccolo appartamento nel vicino quartiere Ponticelli. Non riuscendo a sostenere le spese, fu costretto a rientrare al campo, circa sei mesi fa. «La mia baracca è distrutta. Ho perso vestiti ed effetti personali ma fortunatamente ho salvato i documenti. Per qualche giorno andrò da mio suocero in un appartamento a Ponticelli, ma dopo dove andrò?».
Parlo con tante persone, tutte confermano che l’incendio è divampato tra mezzanotte e l’una dell’11 agosto, dall’area dell’insediamento confinante con l’autostrada A1, poi chiusa per svariate ore. Spaventati, in molti hanno tentato di domare le fiamme, ma di fronte alla potenza del fuoco hanno preferito raccogliere in fretta le cose di maggior valore e scappare. «Meno male che molti sono in Romania per le consuete vacanze estive!», dice F., donna di 25 anni e madre di quattro figli. Infatti, al momento dell’incendio, solo la metà degli abitanti del campo era presente, gli altri si trovavano, come detto, in Romania. Seppure fortunati per non aver vissuto l’ennesima tragedia, non hanno avuto modo di salvare nulla dalle fiamme. Troveranno, al loro ritorno, solo cenere e macerie.
Al momento del mio arrivo, intorno alle 9 del mattino, l’incendio era ancora a pieno regime. I vigili del fuoco sono riusciti a domarlo solo nel tardo pomeriggio, dopo quasi ventiquattro ore di lavoro. Alle 10:30 un rappresentante della Protezione civile ha compiuto un brevissimo sopralluogo, senza condividere con i presenti il risultato dello stesso. Intorno alle 11, dopo aver raccolto idee e risorse disponibili, i volontari delle associazioni del quartiere hanno deciso di far convergere le centoventi persone rimaste presso l’Istituto Marino S. Rosa, a poche centinaia di metri dal campo. L’istituto scolastico è in disuso da anni e di recente è stato assegnato dal comune di Napoli ad alcune associazioni locali, già attive in progetti di supporto agli abitanti di Barra e Ponticelli, rom compresi. Si forniscono pasti, acqua e addirittura supporto medico-infermieristico da parte di una ONG presente sul territorio. Gli infermieri focalizzano l’attenzione sui più anziani e sui bambini. C’è D., 56 anni portati male, molto male, che necessita un medico. Ha una chiara ascite epatica, probabilmente trascurata per anni. Ci sono tante persone che si dichiarano ipertese o diabetiche e hanno perso sia medicine che tessera sanitaria.
Noto un continuo susseguirsi di telefonate tra i volontari e alcuni rappresentanti istituzionali. Ascolto parole slegate tra loro – assessore, Comune, Protezione civile, municipalità. Solo voci, perché nessuno è presente fisicamente sul luogo. Continuo a scorrere i volti dei presenti. Penso che un evento così immediato, imprevisto, distrugga anni di lavoro, di sacrifici e di vite. L’assessore comunale, l’ennesimo degli ultimi e continui rimpasti, rilascia una dichiarazione a mezzo stampa. Ci tiene a precisare che «quello è un campo spontaneo». Vero in parte, ma occorre sottolineare che, nel 2016, la stessa giunta comunale ha approvato il progetto “Campo nomadi di via Mastellone a Barra. Misure urgenti di carattere igienico-sanitario”. La proposta, a firma degli assessorati al welfare e alle infrastrutture, porterà poi al rifacimento della strada di accesso all’insediamento (via Cupa Cimitero) e all’installazione di bagni chimici e docce nell’area posteriore del campo. Seppure discutibile in termini prospettici e di programmazione sociale – certamente l’intervento comunale non contempla il concetto di “superamento del campo” come luogo abitativo –, appare chiara una legittimazione istituzionale dell’insediamento. A rafforzare il tutto, una dichiarazione ufficiale dell’assessore al welfare dell’epoca, Roberta Gaeta: «È un ulteriore passo avanti verso una migliore vivibilità dell’insediamento».
Inizio a scorrere le prime notizie sul web. Tra le tante dichiarazioni di politici, capipopolo, candidati alle prossime elezioni, cittadini, noto quella del sempre-verde Emilio Borrelli, paladino della giustizia universale: «Occorre eliminare il problema a monte e cioè smantellando questi campi che diventano sempre ricettacolo di rifiuti e roghi tossici pericolosi per chi ci vive e per la cittadinanza. Le persone che vi vivono devono essere inserite in un programma di reinserimento sociale in modo che tali situazioni degradanti non si generino più». Insomma, riassumendo: campo rom – rogo – rifiuti tossici – reinserimento sociale. Peluso, Fratelli d’Italia, dichiara: «I campi nomadi costituiscono una grave emergenza ambientale e sociale in quanto contribuiscono a degradare le aree periferiche della città e della sua area metropolitana aumentando i problemi di illegalità, di insicurezza e inquinamento ambientale». Ma come, proprio i politici campani accusano i rom di essere specializzati in roghi? Dal rapporto Ecomafia 2021 risulta che in Italia sono andati distrutti 62.623 ettari in modo doloso. Il 54,7% degli illeciti rilevati si concentrano in Campania, Sicilia e Calabria. Nel solo mese di luglio 2021 sono finite in fiamme, nella Terra dei Fuochi, oltre duecento discariche illegali, centoquarantasette incendi solo nel napoletano. Basta percorrere in auto Barra e Ponticelli per scorgere ovunque discariche illegali. Insomma, non servono i campi rom per smaltire/bruciare i rifiuti. C’è una città intera a disposizione.
IL PAESE DEI CAMPI
Faccio una pausa e passo al bar di fiducia per un caffè veloce. Il barista, al quale racconto dell’incendio, sbuffa e ricorda che nel 2008 ci fu un altro grande incendio di un campo rom in zona. «Eh, ma chilli rapettero ‘nu criaturo, hanno fatt’ buon’ ad appicciarli». Mi si accende un’altra lampadina. Correva l’anno 2008 e proprio a Napoli il governo Berlusconi presentava il “pacchetto sicurezza”, ad appena dieci giorni dal pogrom del campo rom di Ponticelli, situato sotto un cavalcavia nei pressi di via Argine. L’area sulla quale sorgeva il campo era interessata da un progetto di risanamento urbanistico per decine di milioni. I poteri locali riuscirono a strumentalizzare la vicenda, parlando del fantomatico tentativo di “rapimento di un bambino” da parte di una minorenne rumena che non viveva nemmeno nel campo ma in una casa limitrofa. Del totale dei dieci campi rom abusivi di Ponticelli, presero fuoco solo quelli che sorgevano nel luogo sbagliato, interessato dai Programmi di recupero urbano istituiti con l’art. 43 della legge 493/93. Entro il 4 agosto 2008 il comune di Napoli avrebbe dovuto assegnare l’appalto. Gli ignari cittadini rumeni costituivano l’unico ostacolo per la riqualificazione dell’area. L’episodio ebbe risonanza nazionale e scatenò una serie di proteste popolari, fomentate, come spesso accade, da politicanti locali. Emerse inoltre il ruolo di pregiudicati affiliati al clan Sarno nell’aizzare la folla. Il boss Ciro Sarno, in carcere dal 1999, avrebbe avuto contatti nel carcere di Opera con il boss dei Casalesi Francesco Schiavone, detto Sandokan. Uno degli ambiti del Pru venne assegnato alla Associazione temporanea di imprese “Fontana Costruzioni” di Fontana Luigi, con sede legale in San Cipriano D’Aversa in via Salvatore Vitale 18, nella stessa strada in cui viveva Michele Zagaria, boss latitante. In seguito il Servizio edilizia pubblica del Comune revocò l’appalto per interdittiva del Gruppo Investigativo Antimafia. Che cosa è rimasto oggi, dopo tredici anni, di quell’area? Una discarica abusiva. Ancora, nel 2014, andò a fuoco il campo rom di via Del Riposo in zona Capodichino, di nuovo in seguito a una rivolta del quartiere per presunte molestie di due giovani rom nei confronti di una donna del posto. Nel 2016 il Comune sgomberò il campo rom di via Virginia Woolf, sempre a Ponticelli, per ordine della procura e su richiesta del proprietario del terreno: trecento persone di cui cento minori. Come in altri casi, la soluzione “alternativa” fornita dal Comune fu la ex scuola Deledda di Soccavo. La maggior parte delle famiglie preferì, però, recarsi in altri campi della provincia di Napoli, magari raggiungendo conoscenti o parenti. Via Woolf, guarda caso, era oggetto di un progetto di “riqualificazione” per iniziativa privata – parcheggi, centri commerciali. Dopo quattro anni, le macerie sono ancora lì.
Infine, quello che Amnesty International ha considerato lo sgombero forzato più grande d’Europa negli ultimi quindici anni: il campo rom di via Brecce a Sant’Erasmo. Il 7 aprile 2017 circa mille e quattrocento persone, tutte di nazionalità rumena, vengono “invitate” ad abbandonare le proprie baracche. L’amministrazione comunale, quella che anche oggi continua a diffondere lo slogan di “Napoli solidale”, settimane prima dello sgombero, servendosi della polizia municipale, aveva compiuto azioni dissuasive e preparatorie: cibo della Caritas requisito, automobili sequestrate, area del mercato adiacente al campo messa sotto fermo amministrativo. Il giorno dello sgombero gli ottocento rom rimasti uscivano mestamente dal campo trasportando i propri beni in sacchi, buste e carrelli. Profughi di guerra. Amnesty, promotrice di una campagna contro lo sgombero forzato dell’insediamento, sostenne che “Gianturco è solo l’ultimo di una lunga serie di sgomberi forzati ai danni dei rom in Italia. Questa crudeltà deve cessare e le autorità italiane devono essere chiamate a rispondere dalla Commissione europea per la discriminazione e la segregazione cui continuano a sottoporre i rom”. Del resto l’Italia è stata definita il “Paese dei Campi”, perché è l’unica nazione in Europa in cui esistono insediamenti informali e formali di soli rom.
La soluzione alternativa allo sgombero individuata dal comune di Napoli fu, per l’appunto, un “campo attrezzato”. Ironico che sia stato costruito, investendo centinaia di migliaia di euro sottratti a una eventuale programmazione a lungo termine, nell’area di via Del Riposo, dove sorgeva anni prima un altro insediamento sgomberato e incendiato nel 2011 per “frizioni” tra i rom e gli abitanti del quartiere. Delle persone sgomberate, solo duecento, adeguatamente “selezionate” da associazioni vicine al Comune, finirono nel campo attrezzato per soli rom – apoteosi della segregazione etnica. Una distesa di container, isolati e confinanti con un cimitero, che d’estate raggiungono temperature insopportabili. I restanti occuparono, mesi dopo, un’area a poche centinaia di metri dal campo sgomberato, all’interno dell’ex mercato ortofrutticolo, creando l’ennesimo insediamento che a oggi conta circa quattrocento persone. In aumento, dopo l’incendio di Barra. Evito di proseguire descrivendo l’incendio dei campi rom di Caivano e Casalnuovo, entrambi nel 2016. O il vasto incendio del campo di Cupa Perillo, di probabili origini dolose, nel 2017.
Preso il caffè, esco dal bar e torno verso la scuola Marino S. Rosa. I volontari mi confermano che in serata arriverà un autobus del Comune e trasporterà le centoventi persone presso la ex scuola Deledda, definita dagli apparati comunali “riferimento per la progettazione rivolta ai rom rumeni”. Progettazione, certo. Nato nel 2008, fu definito “non un campo, ma un centro, con servizi e strutture organizzate per i rom, ma anche per qualsiasi altra popolazione comunitaria o per un’emergenza”. Da allora è stato utilizzato come luogo di raccolta per soli rom sgomberati e selezionati. Al momento dell’arrivo degli sgomberati di Barra, erano presenti venticinque persone, a loro volta sgomberate anni addietro. Il luogo, a detta dei volontari, si presenta completamente sfornito di qualsiasi bene o attrezzatura necessaria. Sembra che, dopo poche ore dal loro arrivo, siano iniziate frizioni tra nuove e vecchie famiglie presenti, a causa di lamentele arrivate dagli abitanti del quartiere Soccavo che a malapena “tollerano” le precedenti famiglie. Complice anche la totale inadeguatezza del luogo, delle centoventi persone trasportate presso la Deledda, a oggi ne restano solo quaranta. Escludendo le famiglie rientrate in Romania prima dell’incendio – per le quali bisognerà poi trovare una soluzione – restano centinaia di individui che hanno trovato rifugio nei campi di Gianturco e Arzano. Alcune famiglie, invece, hanno trovato nella propria auto un rifugio di fortuna.
Il giorno dopo, mi imbatto in due notizie che confermano quanto in Campania, ma forse in Italia, ci sia un reale problema di comprensione del fenomeno. Un assessore comunale rivendica l’utilità della soluzione Deledda, sostenendo che i rom avranno a disposizione “un centro cottura” per favorire il loro processo di integrazione sul territorio (sic). Un ex assessore, invece, si reca alla Deledda per portare alle famiglie cornetti e caffè, rievocando le perline e le collanine africane, di memoria coloniale. Entrambi gli episodi sembrano confermare l’approccio e la cultura delle istituzioni napoletane, da sempre incapaci di programmare e autonomizzare facendo rete e valorizzando le diverse competenze presenti sul territorio. Una “cultura della carità”, per citare qualcuno che di recente ha lasciato questo mondo. (andrea belfiore)



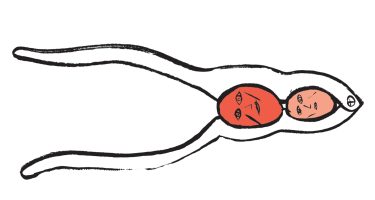
Leave a Reply