
da Repubblica – Napoli del 21 aprile 2013
Ricorre in questi giorni il quarantesimo anniversario della Mensa dei bambini proletari di Montesanto, una delle esperienze pedagogiche più felici e più spesso ricordate nella storia recente della città, simbolo dell’anima ludica e costruttiva – ma non per questo meno “politica” – dei giovani degli anni Settanta. La mensa vera e propria, intesa come distribuzione dei pasti ai bambini del quartiere, in effetti durò pochi anni, ma nei locali di vico Cappuccinelle si susseguirono attività, corsi e assemblee fino all’inizio degli anni Ottanta. In seguito, con il riflusso dei movimenti, si consolidò un nucleo più ristretto che scelse di portare avanti il lavoro attraverso una cooperativa di servizi per l’infanzia, tuttora attiva.
I tempi cambiano, e un anniversario del genere, piuttosto che per rimpiangere l’attivismo di allora, dovrebbe servire soprattutto per porsi (e porre) delle domande sul presente. Le condizioni di vita dei bambini napoletani nei quartieri popolari, salvo casi limite, non sono più quelle di un tempo. I sintomi di malessere affiorano numerosi, ma spesso hanno un’apparenza più sottile, più ambigua, meno elementare. Lo sa bene chi condivide con loro parecchie ore al giorno, a cominciare dagli insegnanti delle scuole. I ghetti, fisici e mentali, esistono ancora. E tante delle questioni sollevate ai tempi della Mensa restano irrisolte. L’incapacità, per esempio, della politica e dell’amministrazione pubblica di generalizzare le iniziative nate spontaneamente nella società, di integrazione e supporto all’istituzione scolastica. Fin dai tempi di Valenzi, non si può dire che siano mancati i tentativi e la buona volontà, accanto alla solita approssimazione e al disinteresse. Abbiamo avuto, in passato, un assessore che gestiva con capacità e profitto diverse scuole private in città, che conosceva e propugnava i modelli pedagogici più avanzati, abbiamo avuto per dieci anni le scuole della seconda opportunità, i Nidi di mamme, i centri Re Mida e tanto altro ancora, ma niente di tutto questo ha avuto la forza di durare, di diventare istituzione, di incarnarsi in una prassi condivisa, da tramandare aggiornandola, di mettere radici in luoghi stabili e in bilanci inattaccabili, piuttosto che basarsi su finanziamenti episodici o su qualche personalità carismatica – per non parlare dei fallimenti e delle omissioni, dalla Città dei bambini mai realizzata, alla gestione disastrosa degli spazi pubblici, fino alla mancanza di centri territoriali di aggregazione.
Gruppi e iniziative come quelle della Mensa, magari seguendo direttamente quel modello, sono nate, poi cresciute e infine appassite nel corso degli anni. Ne potremmo elencare numerose, attive ancora oggi, animate da uno slancio idealista ma capaci di costruirsi nel tempo delle basi concrete su cui poggiare i propri passi. Basterebbe ricordare che proprio nella ristretta area di Tarsia, dove è nata la Mensa, si è sviluppato quasi ininterrottamente un tessuto sociale fittissimo di comitati e associazioni tra i più consapevoli e propositivi in città. Non è certo un caso. Tali esperienze, però, sono soprattutto dei prototipi, il loro ruolo è di mostrare una strada, di tenere desta l’attenzione, di reclamare e proporre soluzioni. Raramente riescono ad attivare risorse sufficienti per restare aperte a tutti, e sostenersi a lungo termine. Di rado hanno ricevuto l’ascolto che meritavano, ma nemmeno hanno avuto la forza di imporre la propria visione, senza farsi risucchiare nella gestione di piccoli insignificanti poteri. Chi ha vissuto quelle esperienze, a un certo punto ha spiccato legittimamente il volo verso altri lidi, portando con sé un bagaglio ben fornito. Un’altra delle cose rimaste immutate in questi anni, infatti, è che dall’incontro con i bambini, e soprattutto con quelli che appartengono a un universo inedito e distante, come sono ancora oggi i bambini di strada, a imparare sono soprattutto gli adulti. Questo gli educatori con un minimo di discernimento lo sanno: è molto più quel che si prende di quel che si dà. E sanno anche che questo rapporto, e quindi la ricaduta delle azioni educative, potrà cambiare solo se cambierà la società intorno. Ai tempi della Mensa, l’ambizione dell’ascesa sociale aveva come contrappunto la voglia di ribellione, che non voleva dire per forza imbracciare le armi, ma piuttosto coltivare una via d’uscita dall’emarginazione, e però anche dal conformismo piccolo borghese, cercando una sponda in comunità alternative in cui riconoscersi, minoritarie ma attive, accoglienti. Un riferimento che già all’inizio degli anni Ottanta si andava sfaldando. Le condizioni di vita dei più esposti, dei più indifesi, continuano a deteriorarsi da allora, anche se in modo diverso: il piatto a tavola c’è (quasi) per tutti, il lavoro minorile non è più una scelta obbligata. Nel frattempo, nuovi soggetti incarnano oggi le vecchie emergenze, ma l’orizzonte di senso, le prospettive da offrire, continuano a mancare, anzi se possibile si sono addirittura ristrette. Insomma, l’anniversario della Mensa suggerisce riflessioni generali sulle condizioni dell’infanzia, ma anche spunti meno scontati sulle relazioni all’interno della città; su chi insegna cosa, sul come e sul dove si insegna; e anche su cosa debbano farsene, certe elite cittadine, delle competenze acquisite nelle esperienze di frontiera, a contatto con mondi diversi dai loro. Certo, sembrano questioni di dettaglio, in un’epoca in cui i politici non riescono a dire altro che “i soldi sono finiti”, gli educatori hanno appena le forze per dedicarsi a sopravvivere e gli intellettuali pesano ancor più le parole per non perdere il poco che gli è rimasto. Eppure, certi nodi di fondo continueranno a influenzare in modo sotterraneo i movimenti superficiali della nostra società. La capacità di affrontarli (e di scioglierli) è quello che ci si aspetta da una classe dirigente a venire, finalmente all’altezza dei suoi compiti e delle aspettative di tanti. (luca rossomando)



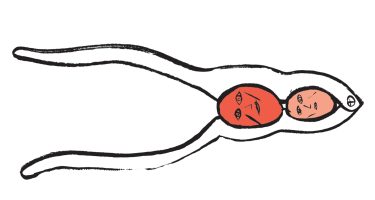
Leave a Reply