
«O rion’ nun va n’terra». È la frase che mi ripetono più volte gli abitanti del rione De Gasperi di Ponticelli, mordendo le parole in una sorta di formula scaramantica per esorcizzare quanto avverrà, tempistiche comunali permettendo, a settembre. Sguardo fisso e mento in alto, quasi a sfidare le ruspe che dovranno abbattere le prime dieci palazzine. Scaramanzia e spavalderia, due facce della stessa medaglia, quella di chi vuole difendere il rione perché non gli è rimasto più nulla da perdere. Non le case asfissiate dall’umidità e avvelenate dall’amianto, non le strade costellate di buche come fossero i resti di un vecchio mobile infestato dalle tarme, né gli sparuti chioschi abusivi di bibite e detersivi. In gioco c’è l’identità del rione, seicento famiglie stipate in altrettanti alloggi popolari di trenta-cinquanta mq, all’interno di un ghetto il cui periodo più florido è coinciso con quello dell’egemonia criminale del clan Sarno, sgominato nel 2009.
Il rione De Gasperi rientra nel progetto dell’Ospedale del Mare, inaugurato a marzo 2015 alla presenza del governatore Caldoro e del cardinale Sepe, e oggi solo parzialmente attivo. Le palazzine interessate (duecentodieci famiglie) verranno abbattute per far posto a infrastrutture di supporto, poientro il 2020 l’intero rione, costruito con i fondi del piano Marshall nel secondo dopoguerra, dovrebbe essere raso al suolo. Lo scorso mese le prime cinquantasette famiglie assegnatarie si sono trasferite nei nuovi alloggi Iacp di Via de Meis, proprio di fronte al vecchio rione. A settembre altre centouno famiglie andranno ad abitare nelle palazzine del Comparto N, pronte dal 2013. In realtà, gli scheletri di questi palazzi sono noti da almeno vent’anni agli abitanti di Ponticelli. Nel 2002 fu firmato l’accordo di programma tra Ministero dei lavori pubblici, Comune, Regione e Iacp, ma i soldi arrivarono molto tempo dopo e i lavori cominciarono solo nel 2010. Sul totale di duecentodieci famiglie assegnatarie ne restano fuori quasi cinquanta, appartenenti a queste categorie: occupanti rientrati nella sanatoria del 2010, approvata in sede regionale ma non deliberata dal consiglio comunale, e nuclei familiari in cui uno dei coniugi è condannato per reati associativi. A questo si deve aggiungere un numero imprecisato di abusivi, la maggior parte dei quali vive nei sottoscala.

È un afoso pomeriggio di metà giugno, l’asfalto ribolle e caccia verso l’alto tutto il calore accumulato durante il giorno. A ogni passo riesco a immaginare i filamenti collosi attaccati alle suole delle scarpe, mentre percorro la strada che attraversa il rione. Gli occhi di una donna appoggiata al muro incrociano i miei, mi fanno da bussola in un deserto di macchine e balconi, solcato solo dal rumore dei motorinio dai fischi del fruttivendolo, che tre volte a settimana arriva col suo treruote. Chissà perchéin tutti i rioni popolari in cui ho messo piede c’è sempre un personaggio che se ne sta fermo, in piedi, che tutto osserva e a tutto è indifferente. Sta lì per forza di inerzia, non aspetta nulla, o forse aspetta proprio che succeda qualcosa; archivia le facce che gli passano davanti, di certo io sono finito nel cassetto degli estranei. Un saluto accennato, e nel giro di dieci minuti il quartiere è affacciato ai balconi, quasi come una seduta plenaria chediscute l’ordine del giorno: il trasferimento delle prime famiglie nelle nuove palazzine di Via De Meis. Ciascuno, sporgendosi dal proprio seggio, si dibatte in un vociare affaticato, affastellando storie personali, giudizi sull’amministrazione comunale e qualche entusiasmo per la nuova casa. Si conoscono tutti nel rione, quasi tutti hanno un soprannome (Carmela a’ malese, Anna a’ nasona, Maria a’ciurara). Quello che colpisce è la capacità gestionale delle donne, soprattutto quelle con i mariti in carcere, che devono farsi carico dei problemi quotidiani, e negli intervalli tra una galera e l’altra festeggiano con un nuovo figlio. Sono loro che hanno a che fare con la burocrazia per la questione della casa, compilano moduli, aspettano per ore l’autobus, si sbattono da un ufficio all’altro perché “la carta” non è di competenza di X e neanche di Y ma di Z, allora cercano di risolvere la questione direttamente con l’assessore; e saranno loro che si mureranno davanti la porta di casa quando dovranno essere buttate fuori.
Partecipanti inconsapevoli di un gioco di prestigio, i non aventi diritto alla casa sono scomparsi dai piani comunali e dall’informazione. Il rischio di svanire insieme al rione si esprime nella veemenza con cui incalzano i rappresentanti comunali, arrivati ad assistere alle operazioni del primo giorno di trasferimenti. Il responsabile Domenico Abet assicura che, per quanto riguardale ventisette famiglie della Sanatoria 2010, una soluzione verrà trovata, ma al momento non c’è un progetto. Sulla questione ci sono versioni contrastanti: Abet ha parlato di un albergo popolare, cioè un prefabbricato adibito a sistemazione temporanea. La voce del rioneinvece mormora che almeno una palazzina, di quelle che stanno un po’ meglio, rimarrà su e ce li butteranno dentro.

In mente mi ritornano alcune parole di Foucault: “Probabilmente non esiste alcuna società che non si faccia la sua eterotopia o le sue eterotopie”. Il concetto di eterotopia è inverso a quello di utopia, ma sono collegati. Potremmo definirla la proiezione nel tempo e nello spazio dell’immaginario utopico di un uomo, di una società, il tentativo di rinchiudere in uno spazio delimitato i desideri a cui questa aspira o le paure da cui rifugge. Che si tratti dei nuovi alloggi Iacp o delle palazzine che sopravvivono al rione De Gasperi le operazioni di trasferimento stanno costruendo l’eterotopia attraverso cui il comune rispondeall’esigenza della casa. La strategia politica è rinchiudere “l’altra Napoli” in comparti e lotti (letteralmente: Lotto O, Lotto G, Comparto N), ed elargire premi in base a contrapposizionistereotipiche: onesto/delinquente, buono/malamente, e così via.
Emblema di un’eterotopia che persegue la logica dell’esclusione è la scena che mi trovo di fronte quando arrivo nella piazzetta con i primi sgomberi: gli operai stanno murando le case senza più infissi a porte e finestre, che gli abitanti erano stati invitati a togliere. Cinque camioncini per traslochi, una volante della municipale, una della polizia che fa il giro del quartiere, i funzionari del comune. Alzo lo sguardo al cielo e vedo un divano che scende su una scala montante. Sul marciapiede c’è il resto del mobilio, mentre una cucina viene smontata per essere caricata sul furgoncino. Sul ballatoio gli operai sudano avvolti in tute bianche come quelle dei RIS. Entro in una casa sgomberata: cucina, stanza e bagno. Dentro alcuni operai rompono il lavandino e il water, un altro mura il balcone. Sono misure preventive per evitare la rioccupazione. Mattoni e calcestruzzo, uno dopo l’altro, mentre i raggi del sole tagliano in modo netto la stanza.L’operaio mi dice con scetticismo: «Tra nu mese scassano tutt’ cos’, che ce vo’». Un ultimo mattone, e insieme al rione si murano anche i suoi spettri. (emiliano esposito / piera boccacciaro)

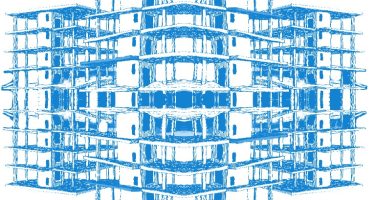

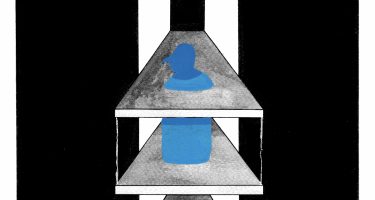

Leave a Reply