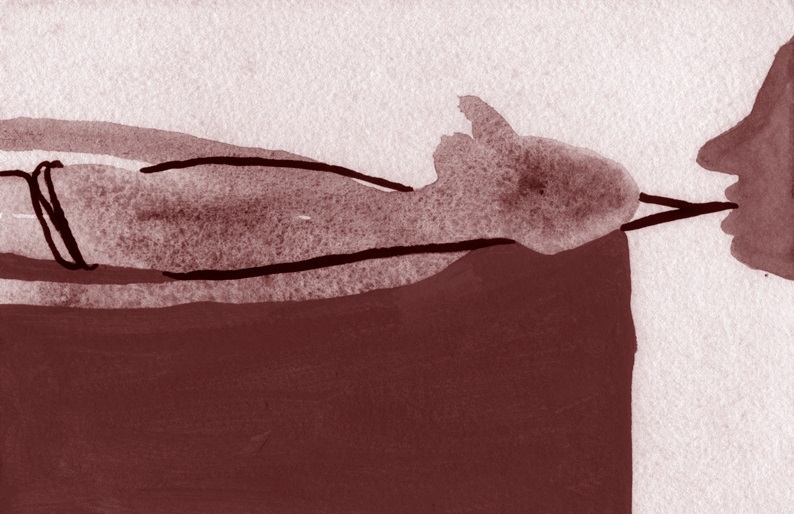
Il Gruppo di supporto psicologico per i familiari dei detenuti che si sono tolti la vita o che sono deceduti per altre cause in carcere nasce nel mese di luglio, dopo un contatto tra alcuni attivisti e attiviste e i familiari di un ragazzo che si sarebbe suicidato inalando il gas del suo fornelletto, nel carcere di Modena.
È possibile seguire le riunioni del gruppo ogni venerdì, dalle 17:45 alle 20:00. Le riunioni avvengono tramite una piattaforma on-line, con il supporto del dottor Vito Totire, psichiatra, attivista e portavoce del circolo “Chico Mendez” di Bologna. Durante gli incontri ognuno può raccontare la propria storia, parlare del proprio dolore e confrontarsi con altre persone che hanno vissuto la tragica esperienza di familiari morti all’interno delle carceri. Il link per accedere alla riunione settimanale viene pubblicato qualche giorno prima dell’incontro sul gruppo Telegram “Morti in carcere” e su quello Whatsapp “Sportello di supporto psicologico per i familiari dei morti in carcere” .
È possibile ricevere informazioni, ma anche raccontare in forma scritta la storia propria e del proprio familiare, anche scrivendo all’indirizzo e-mail dell’associazione Yairahia Ets ([email protected]). Avvocati, volontari, membri di associazioni, garanti delle persone private della libertà sono invitati a unirsi e a condividere il proprio punto di vista.
* * *
Marisa è la sorella di Stefano Dal Corso, un detenuto che secondo le ricostruzioni ufficiali si sarebbe suicidato nel carcere di Oristano, nel reparto d’infermeria, il 12 ottobre del 2022. Ci racconta la storia di suo fratello, trattenuto in Sardegna in via temporanea, per assistere a un’udienza del suo processo. Dietro la sua morte ci sono però molti dubbi e incongruenze.
La questione più scabrosa riguarda le anomalie nella presunta impiccagione. La finestra della cella in cui si trovava Stefano era molto bassa. Stefano era invece alto un metro e settanta circa: sarebbe stato impossibile per lui, secondo la perizia medico-legale di parte, rimanere nel vuoto, senza contatto con il suolo o quantomeno con il letto che si trovava proprio sotto la finestra, per il tempo sufficiente a provocargli la rottura dell’osso del collo. Inoltre, le foto scattate subito dopo il fatto ritraggono un letto fatto con precisione, senza alcun segno, e soprattutto senza che vi fosse stato in precedenza rimosso alcun lenzuolo o coperta. Non ci sono informazioni o indizi su dove avrebbe potuto prendere Stefano il lenzuolo con cui si sarebbe impiccato.
Sempre stando alla perizia medico-legale, la ferita di colore rosso che Stefano aveva sul collo al momento della sua morte sarebbe incompatibile con l’orario del decesso registrato agli atti, ma risalirebbe all’incirca a dodici ore prima. Si tratta, inoltre, di una ferita che sembrerebbe più vicina a quella provocata da uno strangolamento che non da una impiccagione. Stefano aveva poi altri segni sul braccio, in testa e sugli occhi, compatibili con una presa e/o una colluttazione. Tutti questi elementi, tuttavia, restano delle suggestioni irrisolte, dal momento che nessuna autopsia è stata mai effettuata sul corpo del detenuto.
Altre anomalie emerse al momento del ritrovamento del corpo vanno segnalate. Innanzitutto le scarpe che indossava Stefano, più grandi della sua misura e soprattutto allacciate, cosa che l’uomo non faceva mai. E poi il caso di un pacco anonimo consegnato alla famiglia qualche giorno dopo il decesso.
A casa Dal Corso, infatti, si è presentato un presunto fattorino di Amazon, consegnando un pacco che conteneva un libro, Fateci uscire da qui, di Nicholas M. Eltz. Nel libro erano sottolineati due capitoli: “La confessione” e “La morte”. Dalle chiamate effettuate dai familiari di Stefano ai centralini della multinazionale per rintracciare il mittente, il pacco sarebbe risultato essere un falso, e il numero di tracciamento della scatola inesistente.
Stefano stava scontando la pena agli arresti domiciliari presso la sua abitazione prima di essere ricondotto in carcere a Rebibbia. Era infatti stato trovato sotto casa dalla polizia mentre portava a spasso i suoi cani, ma la sua detenzione era comunque ormai quasi terminata. Aveva una figlia che amava molto e a cui scriveva con regolarità. Nell’ultima lettera, che le aveva inviato il giorno stesso dell’udienza, esprimeva la volontà di rifarsi una vita dopo la detenzione. Aveva richiesto di poter essere presente all’udienza sottoponendosi al viaggio da Rebibbia alla Sardegna proprio per poter vedere la sua bambina, che abita a Oristano assieme a sua madre (ex compagna di Stefano).
Il pubblico ministero che si è occupato del caso ha rigettato per ben tre volte la richiesta di autopsia presentata dai familiari e ne ha chiesto l’archiviazione. La famiglia ha nel frattempo lanciato una campagna di crowdfunding per provare a raccogliere i fondi necessari all’esame autoptico, che però resta vincolato all’approvazione da parte dell’autorità giudiziaria, per poter essere utilizzato nell’eventuale processo.
Un atteggiamento, quello della procura, di certo molto ambiguo, che sembra nascondere qualcosa. È stato davvero un suicidio, quello di Stefano, o varrebbe la pena indagare per chiarire le circostanze che adombrano ben più di un sospetto? Perché, in tal caso, si continua a rifiutare l’autopsia? Ancora: perché i possibili testimoni detenuti sono stati tutti trasferiti subito dopo la morte dell’uomo? Troppe domande ma, a oggi, nessuna risposta. (luna casarotti, yairaiha ets)





Leave a Reply