
Traducendo in narrazione polifonica e stratificata l’abusato quanto sterile interrogativo che incalza le genti vesuviane nell’era della cementificazione indiscriminata – ma come fanno settecentomila persone a vivere accalcate sotto un vulcano che da un momento all’altro potrebbe risvegliarsi e annientarle in un attimo? –, Maria Pace Ottieri ha costruito un reportage sull’ambivalenza di un popolo, ma anche sulla transitorietà di ogni impresa umana, così come sulla possibilità, dei luoghi e delle persone, di rinascere e rigenerarsi. Forse per il suo respiro così ampio, che abbraccia distanze millenarie e materie disparatissime, il libro s’intitola Il Vesuvio universale (pp. 282, Einaudi 2018).
Come il profilo della Montagna appare mutevole all’occhio di chi gli gira intorno muovendosi su autostrade e binari, o sui propri piedi, così Ottieri costruisce il suo inventario vesuviano utilizzando punti di vista sempre diversi: quelli dei contemporanei e degli antichi, dei forestieri e degli autoctoni, dei viaggiatori e dei poeti, degli accademici e degli autodidatti, dei concilianti e dei catastrofisti. Intorno al vulcano, quasi ad avvolgerlo per farcelo meno distante e minaccioso, intesse una maglia di racconti in cui il presente s’alterna al passato recente e a quello remoto, e le storie s’addensano in corrispondenza delle eruzioni maggiori, le più note e catastrofiche, da quella che distrusse Stabia, Ercolano e Pompei nel 79 d. C., documentata da Plinio il Giovane in due lettere a Tacito, a quella del 1631 che fece quattromila vittime, fino alla più violenta registrata lo scorso secolo, nel 1906, che causò trentamila profughi e più di duecento morti.
Brevi corsivi intervallano i capitoli, rapidi flash spesso ambientati nei vagoni della Circumvesuviana, conversazioni rubate, appunti presi a caldo su incontri che durano il tempo di poche fermate, un “dietro le quinte” cinematografico in cui l’autrice si mostra “a riposo”, nella transizione da un luogo all’altro, da un testimone all’altro. Frammenti minori in cui però si fa esplicita l’altalena tra attrazione e repulsione, diffidenza ed empatia, desiderio di identificarsi e lucida distanza dalle persone e dai loro pensieri, che percorre l’intero libro e dice delle relazioni dell’autrice con i suoi personaggi, ma anche delle relazioni tra i personaggi stessi, e di questi con il vulcano che li domina e li identifica. D’altronde anche altrove Ottieri dissemina spunti di riflessione, sottraendosi al flusso narrativo per interrogarsi sulle caratteristiche e il senso del proprio lavoro: “Le ragioni, le spinte all’incontro sono sbilanciate: chi indaga e raccoglie cerca delle fonti, la fonte vede in lui un assetato che viene ad abbeverarsi e gli offre tutta la sua acqua, senza preoccuparsi di fargli scoppiare la pancia. […] Il bruciante bisogno degli abitanti di luoghi invisibili di sentirsi osservati li spinge ogni volta che se ne presenti l’occasione a raccontarsi, a rivivere la propria storia sofferta, violenta, esaltante perché unica e a farlo con l’intensità di un rito, come se fossero ancora i modi della religione a dettare le regole dello scambio” (p. 56).
Ma al di là dei caratteri universali, della complessità e opacità talvolta disperante delle questioni toccate, del fascino sottile della dissociazione indotta dalla compresenza di antico e moderno, Ottieri non può che constatare, seppure di passaggio, alcune evidenze inequivocabili del declino presente che avvolge luoghi, economie, relazioni. Il corso desolato di Torre Annunziata, con i negozi chiusi e gli edifici in rovina, il porto deserto, le spiagge puntellate da cumuli d’immondizia, immagine sintetica di una città un tempo vivace e laboriosa, ora che la parentesi industriale si è chiusa e la riconversione turistica è un’eterna illusione. Oppure la parabola della compagnia di navigazione Deiulemar, fondata nel 1967 da tre comandanti di Torre del Greco imparentati tra loro, diventata la quarta in Europa per trasporto di merci alla rinfusa, con venti navi e mille dipendenti, fragorosamente fallita qualche anno fa, trascinando con sé le economie di settantamila concittadini che per quarant’anni le avevano incautamente affidato i loro risparmi.
Un declino che non risparmia floridi banchieri di provincia come i Fabbrocini di Terzigno, il cui patrimonio pare polverizzarsi nell’arco di in un paio di generazioni, o le decine di ville settecentesche disseminate tra Ercolano, Portici, San Giorgio e Torre del Greco, che gli eredi dell’aristocrazia locale cercano invano di puntellare a dispetto della rovina incombente.
Il controcanto scelto da Ottieri sono le attività produttive – dall’impresa di Somma che commercializza il baccalà islandese, all’industria di abbigliamento sportivo di Pompei –, le iniziative civiche o caritative – come Radio Siani a Ercolano o la rete di solidarietà che si irradia dal Santuario di Pompei –, le imprese agonistiche come la palestra di Lucio Zurlo dove si insegna boxe ai ragazzi difficili di Torre Annunziata, ma l’unica attività che davvero non sembra conoscere incertezze a queste latitudini resta l’edilizia, che si manifesta trionfalmente ovunque si posi lo sguardo, col riempimento di ogni interstizio disponibile, la saturazione di ogni spazio, l’annullamento di fatto dei confini intercomunali, fino a rendere la “città vesuviana” un agglomerato denso e continuo, pronto a dare l’assalto anche agli ultimi baluardi che la separano dalle pendici della Montagna.
In un paesaggio votato al caos e all’autodistruzione, Ottieri prova a rintracciare le poche vie d’uscita razionali, dando spazio a voci competenti e responsabili come quella di Aldo Loris Rossi, antesignano della città metropolitana diffusa, o dell’antropologo Giovanni Gugg, che per scrivere la sua tesi di dottorato ha fatto per due anni ricerca sul campo a San Sebastiano. Gugg le parla di de-cementificare, decongestionare, della necessità di cambiare linguaggio e provare a coinvolgere le persone una per una, trasformandole in sentinelle locali. Ma l’effetto Cassandra è inevitabile, perché tutti sappiamo, e l’autrice lo scrive, che l’eventualità che nasca una classe dirigente, locale e nazionale, capace di lavorare di fino, di cambiare paradigma, di elaborare un piano di lungo periodo e di farlo accettare alla popolazione, è più remota della stessa eruzione del Vesuvio.
L’alta qualità della scrittura, l’appassionata curiosità che le fa da impalcatura, l’intreccio di esperienze e caratteri, la leggerezza – e perfino la “superficialità”, che pure appartiene al genere, e che sollecita il lettore a cercare da sé altri dettagli, altre storie rimaste fuori campo –, insomma l’arte di Maria Pace Ottieri, che è quella del reportage al suo meglio, mette a nudo, di riflesso, la grande miseria del giornalismo presente – e di quello locale in particolare, che questo vivaio di temi ed esperienze ce l’ha quotidianamente davanti e non riesce a cavarne che narrazioni pigre, stentate, sempre uguali. Non è così paradossale allora che un altro libro in uscita capace di dialogare con questo “Vesuvio” non sia stato scritto da un giornalista – pur usando il metodo dell’andare sul posto, descrivere, interrogare – ma da un agronomo napoletano, Antonio di Gennaro, che ha sviluppato uno solo dei tanti episodi della Ottieri, ma universale anch’esso, quello dell’agricoltura, e in particolare delle condizioni dei coltivatori campani dopo la crisi della Terra dei fuochi, abbassando il tono letterario ma intensificando la quantità di informazioni, dati, ricognizioni.
Non si sa attraverso quale incantesimo, di Gennaro è riuscito a ipnotizzare i redattori napoletani di Repubblica che da anni gli pubblicano intere pagine con i suoi reportage dalla Campania Felix, ora raccolti, rivisti e integrati con il titolo Ultime notizie dalla terra (pp. 160, Ediesse 2018). Fattosi giornalista per necessità, di fronte all’allarmismo che durante la crisi della Terra dei fuochi aveva provocato la messa al bando indiscriminata dei prodotti campani, l’agronomo ha preso atto che gli strumenti del suo mestiere non bastavano più e per intervenire nel dibattito pubblico bisognava padroneggiarne altri. “Per vent’anni – scrive nell’introduzione – avevo studiato il territorio rurale con l’occhio del geografo fisico, attento a osservare caratteristiche e qualità dei singoli paesaggi, misurandone i cambiamenti e l’evoluzione nel tempo. Mi accorgo ora di aver parlato troppo poco con le persone”.
Nascono così gli interventi che formano l’oggetto del libro, in cui alla varietà dei paesaggi rurali campani corrisponde l’eterogeneità di tecniche, memorie, personalità dei coltivatori-imprenditori, che oltre a produrre alimenti sono anche i primi custodi della sicurezza e bellezza di un territorio “dove città e campagna non sono più due sistemi distinti, ma elementi di uno stesso, disordinato mosaico”, e la loro tutela, più che una questione di manutenzione agroforestale, è ormai un tema di gestione urbana, di amministrazione efficiente, di politiche virtuose per il governo del territorio. (luca rossomando)



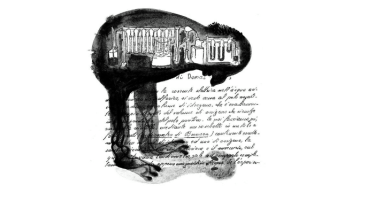

Leave a Reply