
Il primo dicembre 2021 i sindacati dei metalmeccanici e la Whirlpool hanno raggiunto un accordo sulla definitiva chiusura della fabbrica di San Giovanni a Teduccio, nella periferia est di Napoli, e il licenziamento di 321 lavoratori. Di questi, 317 hanno accettato l’indennizzo proposto dall’azienda (95 mila euro), mentre in quattro hanno preferito andare a lavorare nello stabilimento di Cassinetta di Biandronno, in provincia di Varese, con un bonus di 25 mila euro per coprire le spese di trasferimento.
Si è chiuso così un ciclo di lotta e resistenza operaia che ha visto il prevalere delle logiche aziendali e del profitto legato alla delocalizzazione produttiva. La multinazionale americana ha impegnato 30,1 milioni di euro per raggiungere l’obiettivo della chiusura. Un investimento della metà avrebbe potuto, forse, innovare la produzione ed evitare la delocalizzazione. Dal canto suo, il governo italiano continua a essere ineffabile: a inizio novembre è saltato il primo incontro tra sindacati ed esponenti del nuovo consorzio di imprese che sostiene di voler costituire a San Giovanni a Teduccio un polo produttivo per la mobilità sostenibile. A oggi, però, non è stato possibile reperire notizie certe su imprese, soggetti, garanzie finanziarie e prospettive occupazionali relative alla riconversione della fabbrica di San Giovanni. A seguire, le voci di lavoratori e lavoratrici in un articolo apparso sull’ultimo numero del semestrale Lo stato delle città.
* * *
Sul piazzale antistante la palazzina delle attività sociali e sindacali della Whirpool di San Giovanni a Teduccio, periferia orientale di Napoli, una mattina di settembre del 2021. Capannelli di operai e operaie discutono delle prossime iniziative a supporto della vertenza in corso per evitare la chiusura dello stabilimento aperto nel 1964 dal Cavaliere Giovanni Borghi, all’epoca proprietario unico della Ignis, il marchio storico della produzione di elettrodomestici.
Dopo accese discussioni un gruppo di circa duecento persone si dirige in un corteo improvvisato verso lo svincolo autostradale poco distante arrestando il flusso di automobili e camion in entrata nella città. Il blocco dura un’ora, poi scavalcando i guardrail si torna nel piazzale dirimpetto ai cancelli sbarrati della fabbrica. È solo una delle decine di azioni di lotta che dal 25 ottobre 2018 si susseguono per opporsi alla decisione unilaterale della Whirpool di dismettere lo stabilimento di San Giovanni.
La multinazionale statunitense ha rilevato gli stabilimenti italiani nel 1988 dall’olandese Philips, che a sua volta li aveva acquisiti nel 1974 grazie alla fusione con le Industrie Riunite Elettrodomestici (ex Ignis) del Cavalier Borghi. In quegli anni la fabbrica di Napoli aveva quasi mille e cinquecento addetti ed era parte integrante di un territorio in fermento con una miriade di industrie piccole e grandi dove lavoravano migliaia di persone: pastifici, concerie, la Snia Viscosa, la Mecfond, l’Ansaldo, la Cirio, il settore chimico-petrolifero e quello del vetro. La storia della Whirpool si intreccia con quella delle diverse generazioni che si sono susseguite nei reparti. Le voci raccolte in questo principio di inchiesta appartengono a delegati Rsu di Fiom, Fim e Uilm incontrati ai presidi di lotta e alle strutture del dopolavoro aziendale.
Maria Rosaria: «Sono stata assunta il 2 gennaio del 2001. Mio padre andò in pensione il mese prima e mi ha tramandato questo posto di lavoro. Ero ancora una studentessa liceale, ma a Napoli questo tipo di opportunità non le cestini. Papà fu assunto a Varese nel 1963. All’epoca non si mandavano i curriculum. Lesse su un giornale che a Varese assumevano e si mise su un treno, varcò i cancelli e si presentò alla Ignis. Dopo sei mesi fu spostato a Napoli per montare i primi impianti. È questa tradizione che si tramanda di padre in figlio. Qui a San Giovanni la qualità della produzione è sempre stata eccellente. Fin dall’inizio si faceva tutto all’interno della fabbrica, dal cavo alle manopole».
Leonardo: «Io sono entrato nell’ottobre del 1993. Avevo ventotto anni, venivo da esperienze in officine meccaniche della zona. Ai tempi lavorare in Whirpool era un grande passo avanti. Abbiamo sempre fatto il nostro dovere, acquisendo diritti ma anche dando moltissimo all’azienda. Avevamo la mensa, le sale per le attività sociali, la sede della Rsu. Per anni ci sono stati dei comitati di lotta molto combattivi. Questa fabbrica si è sempre distinta per la qualità nell’organizzazione del lavoro. Ci siamo inventati il lavoro giorno per giorno dando una mano agli ingegneri per migliorare il prodotto, abbiamo sempre collaborato su tutto. I reparti erano due: Assemblaggio e Montaggio, mantenuti in contatto tramite una linea aerea che distribuiva i mobili nelle diverse fasi della lavorazione. Abbiamo prodotto fino a cento pezzi all’ora. Nel 2010 siamo stati premiati per aver fatto un milione di pezzi in un anno».
Raffaele: «Il Cavaliere Borghi ebbe la lungimiranza di vedere in Napoli un ottimo sito dove produrre lavatrici e fondò questo stabilimento dove la forza lavoro in gran parte era fatta dai nostri genitori che vennero trasferiti da Varese, e poi da altri che vennero assunti sul posto. Fu una grande scommessa. Negli anni Sessanta e Settanta la lavatrice non se la potevano permettere tutti, per cui lo stabilimento aveva una capacità di produzione non altissima, ma riusciva a distribuire equamente il lavoro. Poi negli anni Ottanta e Novanta c’è stato il boom dell’elettrodomestico: se non c’era la lavatrice in casa non si andava avanti. L’azienda ha puntato sui giovani e i neodiplomati, ha migliorato i macchinari. Servivano periti elettrotecnici ed elettronici, così è nata la riorganizzazione della fabbrica, con noi giovani in sinergia con gli anziani. Abbiamo dato la nostra gioventù a quest’azienda. Assenteismo zero, infortuni zero. Quando ci hanno chiesto di riorganizzare abbiamo spostato la mensa e l’orario per cercare di essere competitivi in tutto e per tutto… Allora perché si decide che bisogna chiudere quando ci sono tutti i crismi per mantenerla aperta?
«Anche la nostra capacità di lotta viene da lontano. I comitati operai sono nati fin dall’autunno caldo e poi sono continuati per tutti gli anni Settanta, sono arrivati fino a noi. Quando si diceva “stanno scioperando quelli della Ignis”, era il terrore qui intorno: i dirigenti, gli impiegati si nascondevano. Chi è entrato con il cambio generazionale ha ereditato anche le pratiche sindacali e di lotta, mantenendo sempre alta la capacità di mobilitazione. Subito dopo che sono entrato, all’inizio degli anni Novanta, scendemmo in piazza con gli altri sindacati contro gli accordi del governo Amato, e siamo scesi in piazza per contrastare anche quel distacco che si voleva imporre tra politica, sindacato e operai. Poi abbiamo difeso l’articolo 18, ci siamo sempre stati. Certo è normale che il sindacato è anche un mediatore, ma abbiamo sempre provato a ottenere il massimo su tutto, anche con l’ultimo accordo del 2018».
Ernesto: «Io vengo da Ponticelli, sono entrato nel 1988, sono figlio di dipendente. Mio padre era preoccupato per il mio futuro ed è andato via con ventisette anni di contributi per dare la possibilità a me di entrare in fabbrica. È andato via con un milione e cinquantamila lire di pensione. Ha fatto un grosso sacrificio. Io facevo un lavoro di rappresentanza, andare in fabbrica era un po’ da carcerati. All’epoca avevo ventisette anni, sono trentatré anni che sto qui. È stato un sacrificio che ho fatto per onorare quello che aveva fatto mio padre. Oggi mi ritrovo senza un lavoro, sono nonno, sono ammalato. Nonostante tutto mio padre aveva zero assenteismo e lo stesso ho avuto pure io e tanti altri operai, perché in questa fabbrica c’è un grande senso di appartenenza. I nostri genitori dicevano che era casa nostra. Quando i più giovani non riuscivano a mantenere certi ritmi noi li aiutavamo, una cosa che oggi non si fa da nessuna parte. Non ce la fai? È un problema tuo! Mentre per noi erano come fratelli più piccoli. Li abbiamo sempre aiutati perché abbiamo avuto sempre interesse che la fabbrica fosse di un certo livello, e anche per i nostri figli che oggi sono disoccupati. La speranza era che potessero entrare loro…
«Io sono stato uno di quelli che ha portato i Cobas in fabbrica, che rompeva le scatole per i diritti. Questa è una fabbrica che ha avuto anche dei problemi, ha avuto l’amianto… diciamo che quando tu combattevi il sistema non avevi molti vantaggi. Eravamo due compagni dei Cobas. Negli anni Novanta siamo riusciti a far alzare la testa ai sindacati, perché ormai si era creato quel meccanismo di collusione con il padrone. Diciamo che il senso della lotta lo abbiamo sempre avuto. Stavolta ci hanno colpito sulla dignità! Se avessero detto che i napoletani non avevano voglia di lavorare, o che rubavano… ma tutto questo non è stato detto. Ancora oggi non sappiamo perché chiudono uno stabilimento che sta a un minuto dal porto, dalle autostrade e dalla ferrovia, mentre lasciano aperti stabilimenti isolati nelle montagne».
La fabbrica di San Giovanni appare permeata di storia e consapevolezza operaia ma anche di una particolare adesione al progetto aziendale, a un’idea di relazioni industriali più orientate verso una cogestione che a una conflittualità rivendicativa. È forse per questo motivo che prevale una certa sensazione di essere stati traditi, dismessi senza un reale motivo, di essere vittime di un bieco calcolo di profitto. L’incongruenza delle motivazioni della Whirpool in merito alla dismissione sembra essere la questione più bruciante. Il 25 ottobre 2018, al ministero per lo sviluppo economico guidato dal Cinque Stelle Di Maio, venne sottoscritto un accordo tra azienda e sindacati che prevedeva il rilancio dello stabilimento napoletano grazie a un cospicuo investimento supportato dallo stato per evitare la chiusura e la delocalizzazione. Una strategia che cercava dei punti di convergenza con la proprietà piuttosto che affermare rivendicazioni radicali. Una tattica di resistenza più che una riappropriazione delle prospettive.
Raffaele: «L’accordo del 2018 prevedeva diciassette milioni di investimento per lo sviluppo occupazionale e tecnologico del sito di Napoli. Soldi che non arrivavano mai e non si capiva dove fossero. L’azienda, tramite il direttore dello stabilimento, non ha mai smentito che quell’investimento fosse scomparso. Quando ce ne siamo accorti? Quando un ingegnere che da Fabriano doveva seguire tutto il progetto venne sollevato dall’incarico. Lì abbiamo capito. Il 31 maggio 2019 hanno detto che avrebbero chiuso e punto».
Maria Rosaria: «Eravamo molto presi nel monitoraggio dell’accordo del 25 ottobre. Il 31 andiamo al ministero e ci danno questa notizia anche in maniera piuttosto cinica: ci hanno mostrato una slide in cui c’era una “spunta” color verde in corrispondenza dei siti che restavano aperti e l’unico con una X rossa, che quindi sarebbe stato chiuso, era il sito di Napoli. Per questo abbiamo preso la spunta verde come simbolo per la difesa della fabbrica. Spiegazioni pratiche o veritiere riguardo la chiusura non ci sono state date. Ci hanno dichiarato in perdita durante i tavoli ministeriali, ma i dati su cui si basano queste affermazioni non sono stati né controllati né tantomeno mostrati. Questa non era una fabbrica in perdita. È stata in perdita perché forse loro hanno voluto che perdesse. Noi siamo l’unica industria 4.0 in Europa. È l’unico stabilimento pluripremiato su sessantasei siti sparsi nel mondo. Siamo stati autodidatti in un sistema di produzione che è stato adottato prima dalla Toyota e che rendeva la fabbrica più efficiente a costi minori. Non si può dire che non eravamo profittevoli perché con l’adozione di questo sistema siamo diventati anche più economici. È il sistema delle cinque S: niente sprechi, niente scorte, sicurezza, qualità e sostenibilità. Lavoravamo in “just in time”: non avevamo materiale a terra per cui niente costi relativi al magazzino. In altri stabilimenti l’azienda ha investito in corsi di formazione mentre noi siamo stati autodidatti, abbiamo fatto risparmiare anche su questo. C’è stato un gruppo di lavoratori e ingegneri che hanno visto il funzionamento e lo hanno trasmesso agli altri».
Raffaele: «Lo stabilimento di San Giovanni ha ricevuto la medaglia di bronzo per l’adozione del ciclo produttivo WCM (World Class Manufacturing, ndr), un’evoluzione dei cosiddetti circoli di qualità, quando i nostri genitori, dopo l’orario di lavoro, si fermavano in fabbrica e cercavano di portare soluzioni innovative sul prodotto. I circoli di qualità esistevano dal 1995. Quando ho iniziato a lavorare c’erano operai che modificavano autonomamente le viti e facevano tanti altri accorgimenti per migliorare il prodotto. Piccoli dettagli invisibili all’esterno, ma che agli occhi di chi aveva esperienza erano evidenti. Nel 2014 Whirpool ha acquisito Indesit mettendo quegli stabilimenti in concorrenza con noi. Abbiamo sofferto con sacrifici e straordinari per portare lo stabilimento alla produttività richiesta; abbiamo lavorato dieci giorni guadagnando novecento euro al mese. Sempre con l’avallo dei vari governi. L’azienda chiedeva sussidi e ci metteva con i contratti di solidarietà. Negli ultimi tempi l’azienda sosteneva che eravamo improduttivi, che avremmo dovuto arrivare a novecentomila pezzi per la forza lavoro che avevamo. Ci hanno sabotato fino all’ultimo, fino a quando siamo andati a Roma e ci hanno detto che la fabbrica non era più sostenibile con una perdita di venti milioni l’anno… ma non era vero niente. Tutte bugie. Loro hanno fatto capire a Roma che l’Italia era un paese strategico e avrebbero investito cinquecento milioni su tutti i siti tranne Napoli. La ragione della nostra insostenibilità era che il prodotto non andava più sui mercati. Il primo anno abbiamo fatto seicentomila pezzi, il secondo anno pure, ma non c’è stata quella vendita capace di assorbirli e da là quella nicchia di mercato si è posizionata sui duecentomila… Da qui nasce la crisi di Napoli, non una crisi di sito ma una crisi di prodotto. E come stiamo dicendo anche al governo, se un’azienda, una multinazionale sbaglia il prodotto, ne può fare un altro ma non può chiudere un sito intero».
La rigidità aziendale nell’intenzione di dismettere la fabbrica si è scontrata con una miriade di iniziative di lotta che hanno fatto della Whirpool di Napoli una delle crisi industriali più in evidenza degli ultimi anni. Una mobilitazione che ha affiancato ai classici strumenti di lotta la costruzione di un consenso più ampio basato, per esempio, sul coinvolgimento di personaggi mediatici. La proprietà, dal canto suo, non ha mai scartato dai propri binari, approfittando forse anche dell’eccessiva cautela e delle indigeribili proposte di mediazione istituzionale, in un quadro di relazioni industriali troppo disequilibrato. La difesa della fabbrica ha trattenuto la radicalità delle richieste, dell’affermazione dei lavoratori come soggettività antagonista non solo alla Whirpool ma al capitale come modello di sviluppo.
Raffaele: «Abbiamo fatto il giro di tutti i siti aziendali. Siamo stati a Varese, a Siena, a Comunanza per fare le assemblee con i lavoratori. La solidarietà c’è stata, hanno fatto più di cento ore di sciopero, lo sciopero generale. Dall’ottobre 2018 abbiamo continuato a lavorare. Abbiamo lavorato durante il lockdown. Questa è stata l’unica fabbrica che ha continuato a lavorare. Poi a ottobre 2020 hanno messo i sigilli e hanno iniziato la dismissione della produzione».
Leonardo: «Abbiamo sempre detto al governo che se un accordo firmato al ministero non viene rispettato significa che perdono tutti, perde la politica, perde il governo, perdono i cittadini. Se dobbiamo dare un giudizio sui tre ministri che si sono avvicendati, è sicuramente negativo. Nessuno di loro ha pensato a modificare la vertenza. Padoanelli ha seguito le orme di Di Maio, d’altronde sono dello stesso partito. Giorgetti della Lega ha detto: non farò trapelare niente, vi porterò le soluzioni… e non l’abbiamo più visto. Tutto l’impegno lo stanno mettendo sul piano B, che a noi non interessa. Il governo lavora solo sull’alternativa a Whirpool, non lavora sul fatto di andare dall’azienda e dire: tu devi tornare a produrre a Napoli. A oggi non hanno presentato nessuna alternativa. Eravamo preoccupati dallo smontaggio dell’azienda, per questo abbiamo subito messo in salvaguardia gli impianti. Se domattina si vuole ripartire c’è solo bisogno di alzare l’interruttore».
Vincenzo: «Con la legge sulle delocalizzazioni ci hanno buttato fumo negli occhi, perché in realtà non ci sono misure punitive o restrizioni per chi va via. Giorgetti ha sempre parlato di creare condizioni di attrattività per gli investimenti. Così i padroni prendono i fondi, gli sgravi, ma poi hanno sempre la possibilità di svincolarsi e scappare via… Il problema non è se siamo attrattivi o meno, il problema è che se ne stanno andando. Fabbriche come la nostra, le spremono fino alla fine e poi vanno via. Siamo stati a Comunanza e abbiamo visto una fabbrica che fa nascere il paese, non un paese intorno al quale si è sviluppata una fabbrica. Te ne accorgi, lo senti che la città intera vive per quella fabbrica. Duemila abitanti di cui la metà lavora per Whirpool e il restante lavora nell’indotto. I bar, gli alimentari aprono perché ci sono i lavoratori. Quindi se quella fabbrica va via scompare un intero territorio. Certo, in centro Italia la politica fa qualcosa in più rispetto a qui. La Regione qui non ci è stata proprio vicino, a differenza, per esempio, della Gkn a Firenze, dove veramente si stanno schierando tutti. Noi ci troviamo in una situazione in cui tutti ci stanno guardando: il territorio e soprattutto le multinazionali. Whirpool sta cercando di forzare la mano: se passa lei, tutte le altre le andranno dietro, proprio perché non c’è un freno da parte dello stato. Se questa storia si chiuderà davvero con il licenziamento, senza neanche una rivalsa sulla multinazionale, allora ogni giorno altre aziende andranno via perché ormai non c’è più nessuno che le ferma».


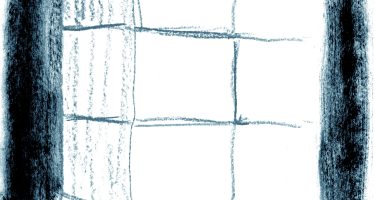


1 Comment