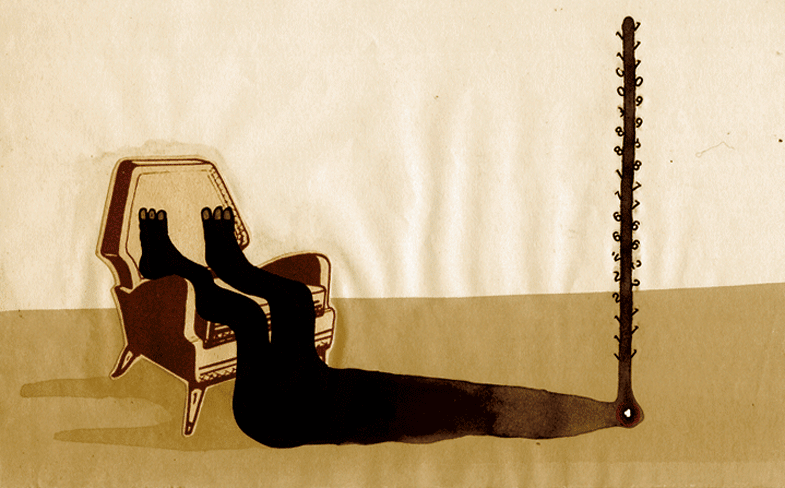
In principio fu la voce, il brusìo del tramando. La chiacchiera che di nonno in nipote, di padre in figlio si conficca nei padiglioni auricolari e – goccia a goccia – si fa carne. L’alito della narrazione che salendo e scendendo, dai bassi alle logge, finisce col posarsi nel nero delle unghie di quei ragazzini che – fujenno fujenno – a mappate popolano vicoli scalinate cave sagrestie. E che succede? Che le mani si mettono in bocca, le storie s’ingoiano digeriscono e alla fine – perché no? – si cacano pure.
Il fatto è questo: le quattro giornate di Napoli. Ma ci tocca dimenticare il compiacimento separatista che vuole farci credere a facili schieramenti tattico-morali, qui i napoletani buoni, lì i tedeschi cattivi. Non solo. Mollando la zavorra storicista il racconto – fattosi fantasma – spicca il volo. La scrittura, come alleggerendosi dal piombo tipografico si fa suono, aria (in senso musicale oltre che elementare), approfondendo i singoli avvenimenti, penetrando a fondo nelle sensazioni epidermiche oltre che psicologiche di patrioti pe’ scagno, cecate canterine, soldataglia germanica scacazzante, cani impauriti al seguito di scugnizzielli rimaiuoli.
Tra i pochissimi testi che riescono a tirarti fuori la voce (e da qui il corpo, e quindi la voglia di memorizzare i testi e ricamarci su, fantasticandoci, magari attorno a un braciere), Tempo che fu di Scioscia di Enzo Moscato (Tullio Pironti editore), riesce a restituire, partendo dalla bidimensionalità della carta stampata, una profondità che non è solo capacità immaginativa o di restituzione di un quadro generale, bensì quella costruzione di un nucleo di sensazioni pronte a insediarsi sotto pelle. “E anche dappertutto nelle vene”, come fa dire l’autore al testimone d’una esecuzione.
Moscato non c’era. “Le quattro giornate io non le ho vissute, ma solo sentite riecheggiare dalle labbra di quelli più vecchi di me”, precisa nell’introduzione. Questa distanza dagli avvenimenti fa sì che il racconto, i racconti (ma dovremmo chiamarli squarci, ferite o feritoie privilegiate), percorrano, tutta d’un fiato, la strada che separa un Fenoglio da un Rulfo. Azione e immaginazione s’abbracciano col beneplacito di una necessaria infedeltà storica. Il dilemma è vecchio ma non archiviabile: perché è necessaria la menzogna per dir meglio la verità? E, allo stesso tempo, perché dire la verità è una menzogna?
Ecco, raccontare di traverso; attraversando le litanìe di una madre che dal vuoto del suo sguardo ancora non può riconoscere la morte dei suoi due, disertori, figli; oppure come quando l’eco della guerra non è più che un soffio sulle pareti di un riformatorio dove i rinchiusi, masturbatori incalliti, vengono ipocritamente chiamati “allievi”.
Non il centro ma il margine / l’orlo / il limite / il bordo.
Non il vero / l’oggettivo / l’integro / il normale / l’ufficiale / ma il declivio soggettivo eccentrico scabroso dell’irregolare anomalo “privato” – l’incofessato intimo d’ ‘a folla
“Napoli è una città in putrefazione”, scrisse Jean-Paul Sartre, e continuava così: “Si va a Napoli come gli adolescenti all’obitorio, come si va a una dissezione. Con l’orrore di essere testimone”. Moscato non si sottrae a questo orrore. Anzi, ce lo racconta anche in quegli aspetti con i quali è più difficile fare i conti. Assassinii mascherati da patriottismo, vendette, falò di carne umana. Senza dimenticare l’umanità della paura, fotografata nel boato di un bacio tra un ribelle e un soldato tedesco caduti sotto i colpi degli attacchi aerei.
Corpo e voce – da quelle quattro giornate a oggi –, seppelliti dai bombardamenti di miracoli economici, televisioni, alfabetizzazione di massa, sembrano essere riportati alla luce e all’ombra che meritano da questo piccolo libro. Sarà quella che chiamano una persistenza? Chissà! Diciamo solo che se l’orale è morto, lunga vita alla sua eco. (cyop&kaf)



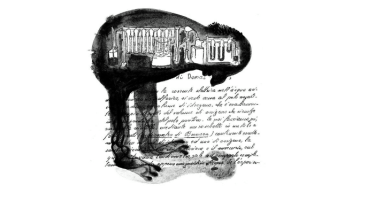

Leave a Reply