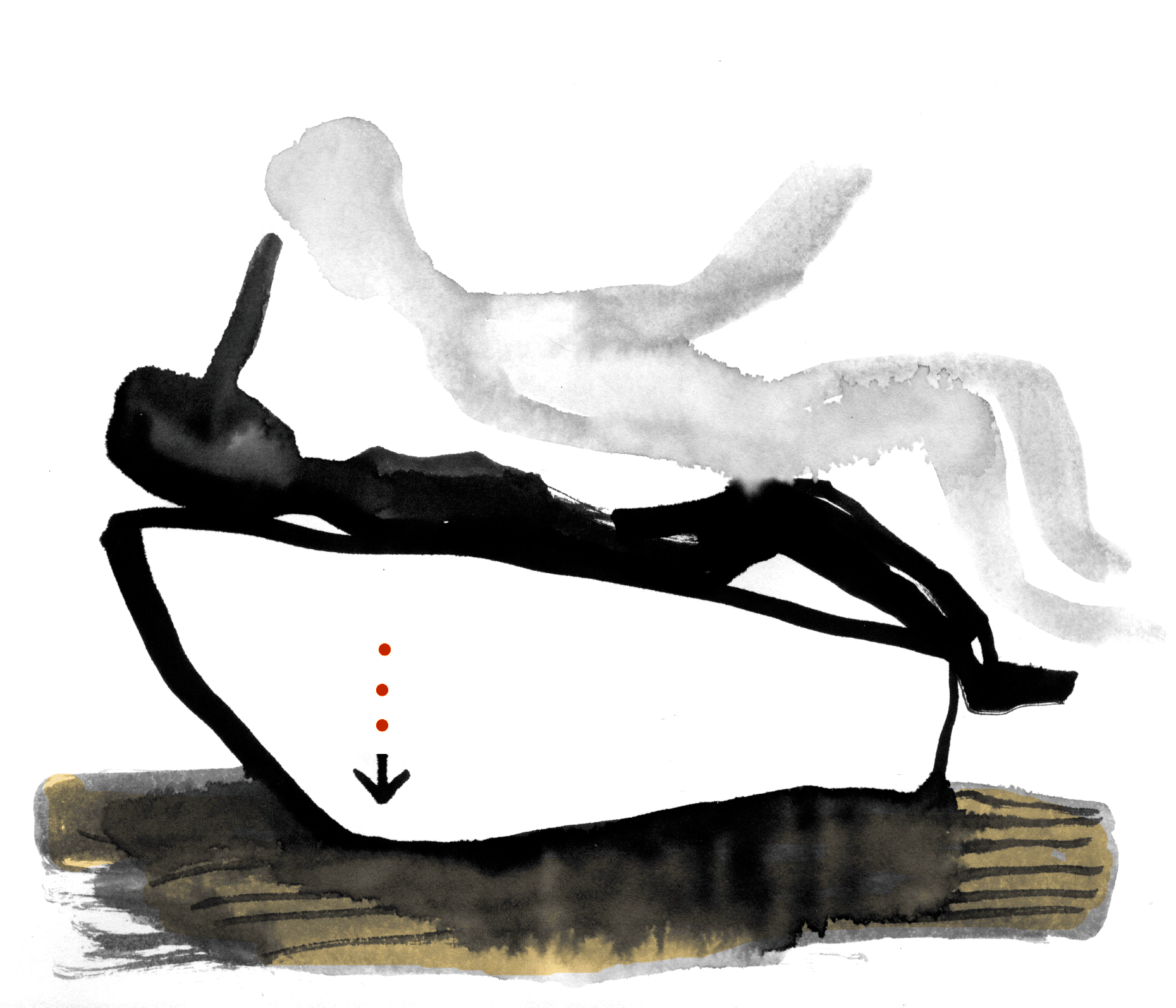
Dall’edizione napoletana di Repubblica del 2 febbraio 2011
Il grande sconfitto nello scandalo delle primarie napoletane è stato il voto d’opinione, il voto progressista di Chiaia, Vomero e Posillipo, il voto di chi ancora può permettersi di pensare con la propria testa, di chi ha firmato appelli pieni di buone intenzioni ma poco ancorati alla realtà. Questa parte dell’elettorato ha subito un duro colpo, se non sul piano dei numeri – essendo difficile da quantificare l’entità dei brogli –, di sicuro sul piano della rilevanza simbolica. Il palcoscenico del dopo-primarie se l’è preso tutto il voto di necessità, il voto a occhi chiusi, il voto di scambio, spesso ben misero scambio; quello procacciato dai caporioni di quartiere, dai porta-gente specializzati nel dragare case popolari di periferia e vicoli del centro, nel radunare davanti ai seggi giovani e anziani, e se capita extracomunitari, dispensando modeste gratifiche e minuziose istruzioni di voto, per poi attendere all’uscita la prova che suggella la transazione.
L’elettore coscienzioso e responsabile ha fatto la figura del fesso. Eppure, accade a ogni elezione. Non c’è partito, ma anche corrente ormai, a destra come a sinistra, che non sia dotata dei suoi porta-voti di fiducia, e quando in lizza c’è una parte sola può anche capitare che si renda disponibile chi di solito lavora per la concorrenza. Forse è anche per questo che stavolta il meccanismo si è inceppato, mostrando come anche a sinistra la lotta per il potere sia imperniata sul controllo, senza tanti scrupoli, di sostanziosi “pacchetti” di voti, sempre più slegati dalle ragioni dell’appartenenza ideologica. Quando si dice “una vittoria degli apparati” si intende questa cosa qui. Quando si parla di “radicamento nel territorio” si allude a questo misero commercio. Quando il funzionario di partito fissa compunto le telecamere parlando di “partecipazione” e di “popolo”, evoca una serie di simulacri del passato che non rimandano più al loro corrispettivo storico, ma a queste meno nobili pratiche.
Chiunque abbia fatto politica di base negli ultimi vent’anni sa bene che i militanti di partito non esistono più, al limite rimane ancora qualcuno che vanta quella remota origine ma se n’è poi allontanato o qualche altro che si muove con coraggio, da isolato, ma non conta più niente nel suo partito. Le sezioni residue sono luoghi in dismissione dove si espongono ai passanti una vecchia scrivania e qualche sedia, che vengono spolverate venti giorni all’anno in coincidenza con la tornata elettorale.
Magari lo scandalo delle primarie servisse a mostrare che il re è nudo, ovvero che i partiti di sinistra come li abbiamo conosciuti, che univano al voto d’opinione dei ceti medi progressisti anche una sostanziosa adesione popolare, strettamente legata a una pratica o almeno a una promessa di emancipazione, non esistono più, non hanno più quelle caratteristiche. Con i mutamenti in corso nella società e nella produzione, l’identificazione tra questi partiti e una parte del mondo del lavoro si è andata scolorendo, fin quasi a scomparire. Alla tensione comune verso un futuro migliore si va sostituendo un rapporto strumentale con gli eredi di quel mondo, resi sempre più marginali da sfavorevoli rapporti di forza nella produzione, un rapporto basato sulla promessa spicciola ma vaga, indefinita, piuttosto che sullo scambio concreto, ché ben poco ormai è rimasto da offrire. Se la confusione, l’indifferenziazione tra destra e sinistra è giunta ormai al suo culmine, questo è uno dei sintomi più chiari e decisivi.
Se non viene a capo di questo corto circuito l’elettore d’opinione avrà un bell’indignarsi di essere stato espropriato delle proprie luminose idee da un manipolo di galoppini di periferia. Le elezioni, per il momento, resteranno questa cosa per stomaci forti, una lotta all’ultimo voto e con tutti i mezzi necessari, in cui la condizione di necessità o la pura e semplice ignoranza sono il punto esatto dove far leva, quello che consente di aumentare in modo massiccio la quantità dei voti.
Quale azione di governo ci si può attendere da chi non si fa scrupolo di questo stato di cose per conseguire i propri scopi? Che interesse dovrebbe avere questa classe dirigente a emancipare una popolazione disillusa, rassegnata alla sua condizione di subalternità, indifferente verso i propri diritti fino a farne commercio, a volte nemmeno per necessità ma per semplice noncuranza?
È questo il nocciolo della questione per l’elettorato progressista, e soprattutto per le nuove generazioni istruite e ambiziose che vorranno proporsi come future classi dirigenti cittadine. Come si ricostruisce un rapporto non più ambiguo ma di fiducia reciproca, di identificazione, di partecipazione costruttiva con questa popolazione ai margini della produzione e della democrazia? Attorno a quali obiettivi, valori, e naturalmente anche interessi – mentre vengono meno con rapidità inesorabile la coesione di classe e la comunanza di ideali – si riconsegna un senso alle vite di centinaia, migliaia di persone dal destino apparentemente già scritto? O si risponde in modo articolato a queste domande, punto per punto, delineando obiettivi concreti e linee di azione, indicando in anticipo gli uomini e le donne – non un semplice candidato – disposti, e competenti, a occuparsene, oppure dovremo rassegnarci a essere non-rappresentati ancora a lungo da questi burocrati senza qualità che si credono ancora di sinistra perché cantano in coro “Bella ciao” alla fine dei comizi. (luca rossomando)




Leave a Reply