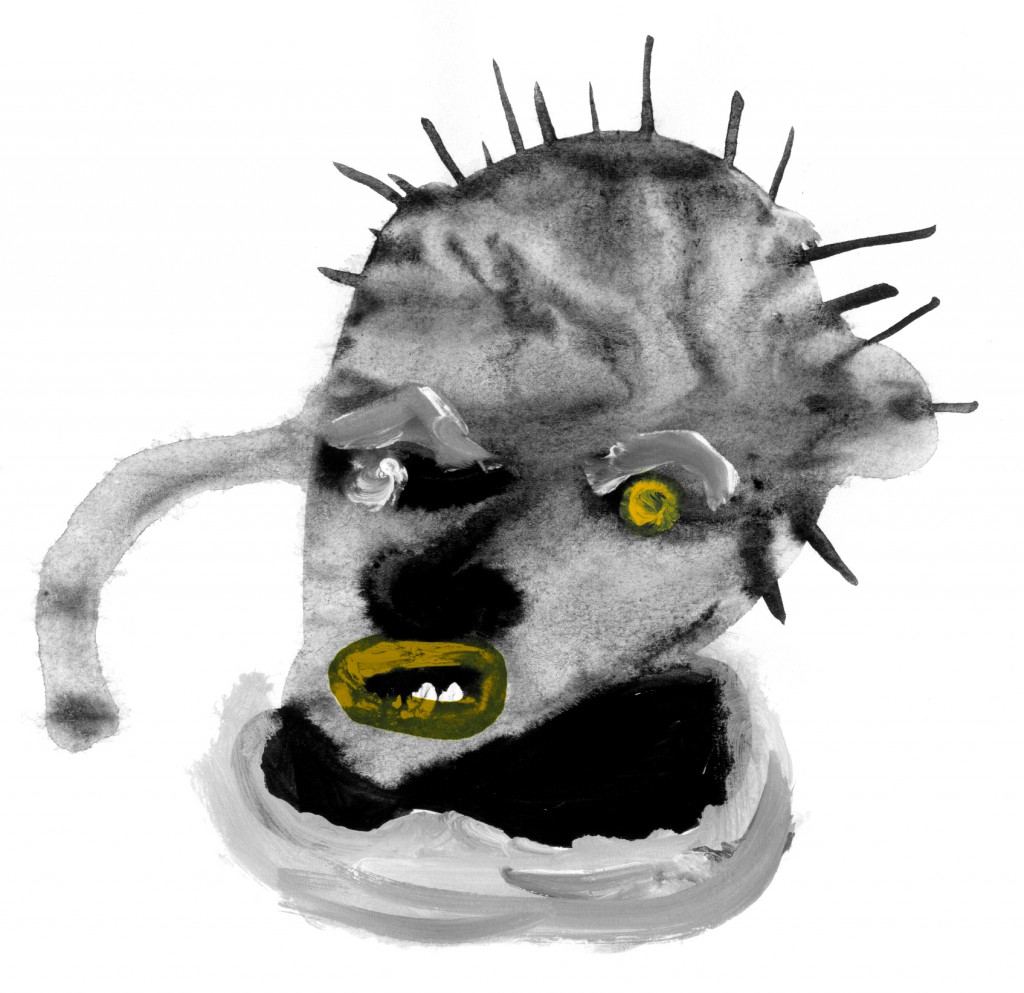
Percorro l’asse mediano, che decolla a Capodichino, sorvola i palazzoni a schiera e poi atterra a Secondigliano. Proseguo fino a Casandrino e poi, dopo vari incroci e segnalazioni stradali equivoche, arrivo a Sant’Antimo. La piazzetta principale è quasi sempre popolata, di domenica è piena. Sul muretto che la circonda siedono ragazzini e pensionati. Ci sono anche molti bengalesi, parlano tra loro come sono soliti fare: guardandosi attorno mentre si rivolgono a un altro, gesticolando più con la testa che con le mani. Nella piazza i figli dei santantimesi si arrampicano assieme a quelli dei bengalesi sulla statua dei caduti della seconda guerra mondiale. Macchine che suonano il clacson per attirare l’attenzione, grasse risate. Dalla piazza si snodano vie poco ampie, che si muovono sui tracciati che collegavano i casolari, oggi inglobati dalla cittadina. Una di quelle strade, via Sambuci, fu al centro dell’attenzione nel 2010 per via di uno sgombero effettuato su ordinanza del sindaco, che prevedeva l’evacuazione dal giorno alla notte di circa quaranta immigrati. Fu quella la prima volta che vidi Sant’Antimo. Quattro anni dopo, una domenica di luglio di quest’anno, mi ritrovai nella piazza centrale di quel paese, seduto sul muretto. La gente affollava i marciapiedi, uno solo tra loro aveva l’aria di cercare qualcuno: fu così che riconobbi Rabindra, anche se non l’avevo mai visto da vicino. Rabindra è basso, ordinato, ha le mani rovinate ed è puntuale. Ci sediamo all’interno di un bar lì vicino.
Rabindra è stato il primo a denunciare i suoi datori di lavoro, scatenando una reazione a catena che in città ha scatenato un bel putiferio. Mentre parliamo arrivano altri lavoratori del Bangladesh, uno alla volta: stanno in silenzio a far finta di ascoltare, non parlano italiano. Uno dei datori di lavoro gli ha sequestrato con l’inganno i documenti d’identità, per poterli ricattare quando avrebbero protestato per le loro condizioni lavorative. Hanno denunciato tutto ai carabinieri, che hanno perquisito la casa del padrone della fabbrica ritrovando uno solo dei passaporti sequestrati. Rabindra fa spiegare a ognuno la sua situazione, lo invita a sedersi con un gesto tra la soddisfazione e la rabbia: è agguerrito, vuole spiattellare i nomi dei colpevoli, risolvere la situazione, fare giustizia. Io resto seduto a quel tavolino che ora è diventato una scrivania, ricevo persone che accorrono dai dintorni e provo imbarazzo perché forse non sanno che io non posso fare niente per loro. Rabindra dice che vengono da lui perché sanno che, quando può, lui cerca sempre di aiutare. Parlando dei padroni mi fa: «Loro, mi odiano, loro vorrebbero che io fossi come loro, che io prende, prende! Ma io non sono come loro. Quando ho quello che mi serve per vivere mi fermo e penso agli altri». Lui è stato il primo a denunciare la condizione di sfruttamento in cui si trovava, l’ha fatto subito, dopo la prima mensilità non pagata. Con lui si è aperta una voragine che ha portato alla luce un intero sistema di sfruttamento.
I proprietari delle fabbriche tessili di Sant’Antimo sono imprenditori bengalesi, spesso proprietari di altre fabbriche in Bangladesh, dove le condizioni dei lavoratori sono tristemente note. A un lavoratore arriva la proposta, per via di conoscenti e familiari, di un lavoro in Italia, con lauti compensi che salderebbero in poco tempo il debito col proprietario della fabbrica, il quale si impegna ad anticipare le spese per il viaggio. Arrivato nel nostro paese, al lavoratore viene offerto un impiego in una azienda tessile non troppo diversa da quelle che si trovano a Dacca. Neanche i ritmi di lavoro sembrano allontanarsi troppo da quelli della patria d’origine: dalle dieci alle quattordici ore al giorno, sette giorni su sette. Alla fine del mese, al lavoratore viene decurtata arbitrariamente gran parte della paga, e riceve in media trecento euro. Quando protesta arrivano gli insulti e le intimidazioni, poi la violenza fisica. Alcuni dei proprietari dispongono di aiutanti il cui mestiere è tenere sotto controllo gli operai, sequestrandogli in misura preventiva i documenti nel caso in cui il lavoratore dia problemi.
Rabindra ha fatto un’altra trafila. Prima di arrivare a Sant’Antimo ha lavorato per diversi anni in Italia, è più anziano, sa che se un padrone non vuole pagarti la prima volta non lo farà neanche la seconda. Non solo: conosce bene l’italiano, come quasi tutti quelli che lo seguono subito dopo nella denuncia, e riesce a districarsi dalla trappola di ricatto e isolamento tesa dagli imprenditori bengalesi
Col sostegno dell’Associazione 3 Febbraio, i lavoratori che hanno denunciato per primi le loro condizioni si organizzano per coordinare una lotta e per coinvolgere altri loro connazionali. Attraverso la stessa associazione, Rabindra e gli altri raggiungono gli avvocati che si sarebbero occupati del loro caso. Si tratta di procedimenti civili, cause di lavoro intentate nei confronti di tre società con sede legale a Sant’Antimo. L’avvocato D’Ago, che se ne occupa, mi spiega che si tratta di tre società regolarmente iscritte alla Camera di commercio, che però hanno assunto tutti i loro dipendenti a nero. Il primo dei ricorsi riguarda quindi il riconoscimento dei rapporti di lavoro. C’è poi la questione dei pagamenti arretrati, per non parlare del trattamento di fine rapporto. Alcuni operai hanno lavorato per due anni senza un giorno di riposo, continuando a percepire una frazione di quello che gli è dovuto. Questo vuol dire che alcuni tra loro vantano arretrati che arrivano ai centomila euro, che questa causa potrebbe dargli modo di riavere. È proprio un debito del genere quello che impedisce ai lavoratori di abbandonare di punto in bianco l’azienda, o di fare mosse azzardardate. Il proprietario, dal canto suo, non corre invano questi rischi, visto il notevole ritorno economico: il costo della manodopera è praticamente irrilevante, il prezzo a cui vengono venduti i vestiti all’ingrosso è molto vantaggioso e perdipiù la produzione è a ciclo continuo. Secondo l’opinione dell’avvocato, questa attività non sarebbe legata con la camorra a livello organizzativo: si tratta di spiccioli per chi si occupa del commercio di stupefacenti. I capi così realizzati sono commissionati da note marche italiane, che ottengono prodotti al prezzo del Bangladesh senza però dover pagare una traversata dell’Oceano Indiano: basta l’Autostrada del sole.
Uno dei bengalesi in prima linea nella lotta si fa chiamare Debdan, nel suo paese è un avvocato. Anche lui ha intentato una causa civile contro i suoi datori di lavoro, ed è subito rimasto disoccupato. Ora fa da coordinatore alla lotta dei bengalesi di Sant’Antimo. Debdan è andato più volte a denunciare la situazione dei suoi compatrioti nell’ambasciata bengalese in Italia, ma nessun provvedimento è mai stato preso dalle autorità di Dacca. Del resto, le stragi del 2013 in due fabbriche tessili non sarebbero state possibili senza uno stato centrale che stringe accordi, spesso poco trasparenti, con le società multinazionali, bypassando la questione dei diritti dei lavoratori.
Mentre guardiamo con la giusta apprensione a quello che accade nel cosiddetto terzo mondo, dinamiche del tutto simili si riproducono indisturbate nel nostro paese, a pochi passi dalle nostre case, mentre un lavoratore italiano viene messo alle strette con metodi molto vicini a quelli utilizzati coi bengalesi: lavoro nero, nessuna garanzia, mancata percezione dello stipendio e conseguente ricatto. Nonostante ciò, continuiamo a percepire le due situazioni come questioni separate. Nel frattempo, ci si prepara anche per una causa penale: i proprietari delle tre aziende di Sant’Antimo dovranno rispondere dell’accusa di sfruttamento e riduzione in schiavitù. (umberto piscopo)


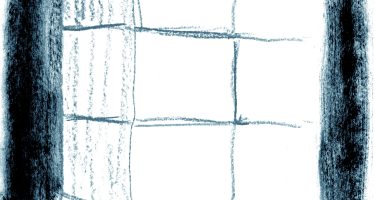


Leave a Reply