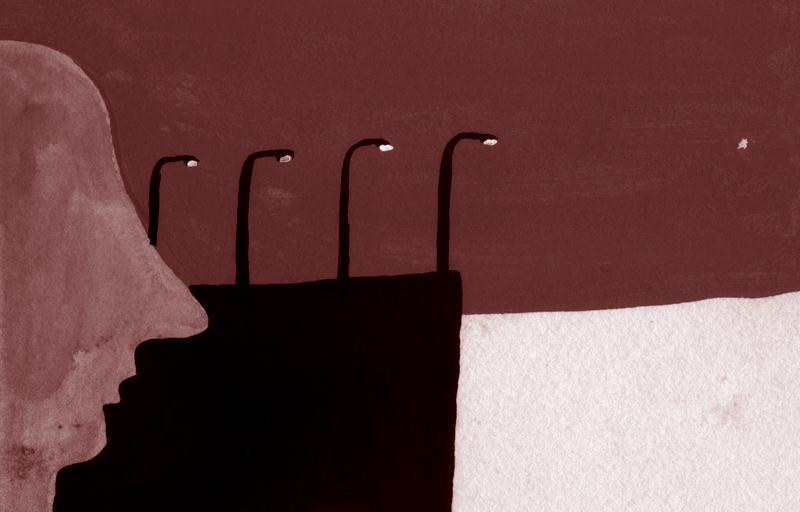
Sulla porta del cinema dove sto per vedere Dogman di Matteo Garrone, un’amica mi fa: «Questo film ti interesserà particolarmente, perché si ambienta a Ostia». Sgrano gli occhi: il particolare mi era sfuggito. Ho fatto ricerca per alcuni anni sul litorale romano, ma non sapevo che questo film si svolgesse nei “miei” luoghi. Sono andato a vederlo perché Marcello Fonte, l’attore principale, è un attivista del cinema Palazzo di San Lorenzo. La sua Palma d’Oro è fonte d’orgoglio per tutto il quartiere, quasi un riconoscimento collettivo. Ma il film non si svolge a Ostia; è girato sul litorale di Castel Volturno. Gli abitanti però parlano romano, e l’unico quartiere popolare di Roma che ha il mare è Ostia. Inoltre, nel film tutta la zona è tenuta sotto scacco da un ex pugile, dalla cui violenza lo stato sembra non offrire alcuna tutela. Ho scritto da poco un articolo su Nuova Ostia e la capocciata di Roberto Spada al giornalista Piervincenzi: vedendo il film non ho potuto non riconoscere un’allusione, magari non voluta, all’ex pugile di Ostia che l’anno scorso è diventato il simbolo della mafia a Roma. Non sono il solo: molte recensioni del film fanno riferimento a Ostia: “Quella specie di Ostia da incubo che Ostia non è”; “un litorale periferico romano (Ostia?)”; “una sorta di Ostia ricostruita come terra di nessuno”; eccetera.
In un’intervista Garrone ha detto di non aver voluto parlare di periferie, ma della violenza che connota l’esistenza umana in generale. L’ambientazione quindi non farebbe riferimento a un luogo specifico: «L’ho pensato come il villaggio di un film western, un simbolo dell’intera società, dove i protagonisti incarnano degli archetipi e hanno delle storie che scavano dentro l’essere umano». Eppure il film trae spunto da un fatto di cronaca indissolubilmente legato a un quartiere di Roma, la Magliana, dove nel 1988 un canaro cocainomane uccise e fece a pezzi un complice che lo vessava. Arrestato, raccontò agli inquirenti una sequenza di torture e sevizie che impressionarono l’opinione pubblica, ma che l’autopsia rivelò sostanzialmente deliri da cocaina: tutte le mutilazioni erano avvenute dopo l’omicidio. Nelle periferie reali, c’è ancora chi cerca di capire cosa realmente sia successo: per esempio, la madre della vittima del canaro, che ha rifiutato duramente il film. «La violenza è sempre esistita: è nella natura dell’essere umano», dice Garrone. «Mi domando da dove nasca questo male, come si diffonde, perché non riusciamo a lasciarlo fuori da noi. Non so come rispondere».
Il punto invece è proprio questo. Violenza, sopraffazione, sofferenza, hanno radici storiche precise: i due riferimenti spaziali e temporali del film, uno esplicito anche se trasformato in fiction (Magliana 1988) e uno implicito, non voluto ma percepito da molti (Nuova Ostia 2017), rinviano a uno stesso fenomeno: la degenerazione della convivenza come prodotto di politiche urbane e sociali specifiche. La Magliana e Ostia hanno la stessa storia. In entrambi i quartieri, negli anni Settanta, il Comune trasferì migliaia di cosiddetti baraccati, più o meno a forza, alloggiandoli in palazzine che i costruttori non riuscivano a piazzare sul mercato. Nuova Ostia era troppo vicina al mare, la Magliana era proprio sotto il livello del Tevere. I quartieri si popolarono, ma gli ex baraccati nelle palazzine si ritrovarono più impoveriti e isolati di prima, e iniziarono a organizzarsi per resistere e protestare contro la nuova difficile condizione, per alcuni addirittura peggiore di quella delle baracche.
Secondo lo storico Bruno Bonomo [1], “questa intensa partecipazione popolare alla vita del quartiere si va via via affievolendo”, e dagli anni Ottanta alla Magliana “quello che, fino a pochi anni prima, è stato un quartiere rinomato in tutta Roma – e non solo – per le lotte collettive della popolazione, si ritrova ad essere percepito nella coscienza comune come un ‘ghetto’, un ricettacolo di disperazione e marginalità sociale”. Così, mentre a Nuova Ostia si girano molte scene di Amore tossico di Claudio Caligari, la Magliana diventa la base operativa della prima mafia autoctona di Roma, la banda della Magliana, appunto. I due quartieri diventano simboli della disperazione urbana: territori disgregati per natura, dove gli abitanti – per la loro stessa condizione periferica – si derubano, si fanno violenza, si uccidono a vicenda. La guerra tra poveri è percepita come prodotto della distanza e dell’abbandono: la mancanza dello stato, il degrado dei luoghi, producono quello scandaloso stato di homo homini lupus di cui scrivono i giornali. L’indignazione, quindi, reclama un intervento dello stato: si invoca la legge, un Leviatano, anche punitivo, ma che affermi che qualcuno comanda. Allora sì, torneranno l’ordine e la morale.
Siamo così abituati a questa narrazione che trasforma le periferie in simboli atemporali della cattiveria umana, che non vediamo più il paradosso quando ce la ripropone un autore tra i più affermati del cinema italiano. In Dogman, la splendida fotografia e la bravura degli attori creano un binomio coerente, eppure mistificante, tra la decadenza dei luoghi e l’immoralità degli abitanti. Il paesaggio sordido fa da correlativo oggettivo ai comportamenti umani: così come le scene d’amore tra padre e figlia avvengono sott’acqua, in silenzio, sulla terra la parola “amore” rende solo il protagonista più disadattato e ridicolo. Ma questa relazione diretta tra spazio e società è assolutamente infondata: è la teoria della broken window dei conservatori americani, secondo cui il degrado del paesaggio costruito fomenta il degrado dei rapporti sociali. Nella realtà, luoghi sordidi e apparentemente disperati come le baraccopoli o le favelas ospitano rapporti di aiuto mutuo e supporto reciproco che paradossalmente collassano proprio quando lo stato interviene a “risolvere i problemi” – per esempio, quando gli abitanti dei “borghetti” romani vengono trasferiti negli appartamenti. È con l’arrivo dello stato, non con la sua mancanza – con il trasferimento a Magliana e Nuova Ostia, non nelle baracche dell’Acquedotto Felice o di Prato Rotondo – che gli abitanti più poveri di Roma iniziano a spararsi addosso e a derubarsi tra loro. Il crimine che porta in prigione Dogman, il buco nel muro per derubare il vicino, è proprio il simbolo di ciò che prima del trasferimento non avveniva: nelle baracche i ladri c’erano, ma non avrebbero mai rubato a un abitante del quartiere. Solo quando lo stato ha reso tutta la popolazione succube e dipendente, è scoppiata la catastrofe sociale. È quello che raccontano, a centinaia, gli ex abitanti delle baracche, a chi si prende il disturbo di andare a parlarci: a Ostia come alla Magliana o a Spinaceto.
In un momento storico in cui l’isolamento prodotto dalla città arriva fino al limite di farci considerare folle, crudele e criminale chiunque viva in modo diverso, pensi in modo diverso, voti in modo diverso da noi – al punto da spingere intellettuali rispettati a invocare la fine del suffragio universale –, film come questo ci rinchiudono ancora di più nella nostra bolla di paure irrazionali. Questi archetipi, queste proiezioni dei nostri pregiudizi, ci rendono sempre più impermeabili alla curiosità e alla voglia di capire davvero come funziona la società, la città; rendono i nostri spazi sempre più frammentati, le periferie più isolate e incomprese. Non stupisce allora il clamore per la visita di Papa Francesco a Nuova Ostia, proprio in questi giorni. In questi inferni in terra, popolati da demoni in forma umana, sembra non avere più senso chiedere riforme, lavoro sociale, sport, cultura. Al massimo si può invocare un esorcismo. (stefano portelli)
[1] Bonomo B., “Dalla borgata di Prato Rotondo al quartiere Magliana. Storia di una comunità di immigrati nella Roma del secondo dopoguerra”, in Giornale di storia contemporanea, n. 6, 2003, p. 99.





Leave a Reply