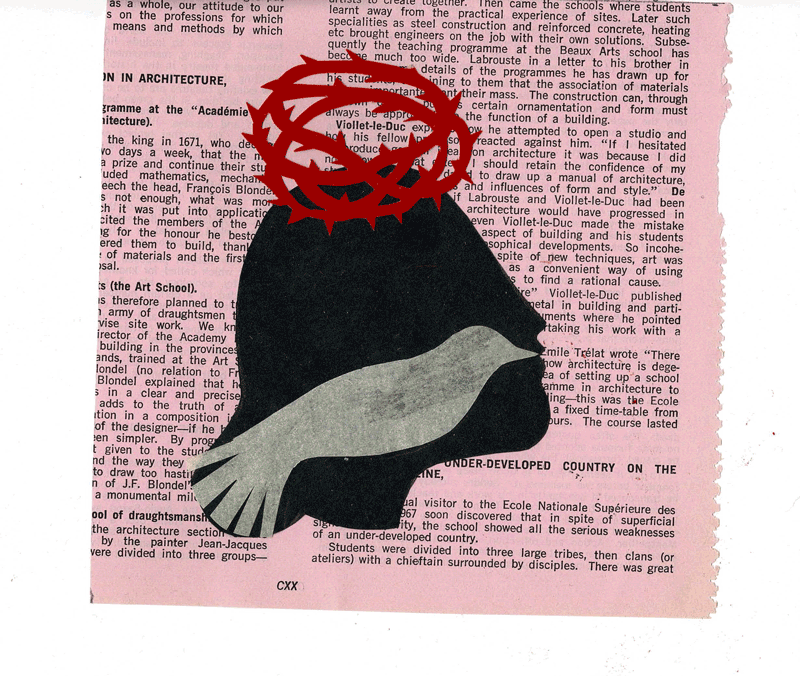
Sapri si nasconde in un’insenatura stretta tra il mare e l’Appennino meridionale. Fino agli anni Settanta alcuni tratti di quella parte del golfo di Policastro conservavano ancora la fisionomia originaria e soltanto con gli investimenti conseguenti al terremoto del 1980 subì trasformazioni profonde. In quegli anni il fermento sociale si raccoglieva intorno al comitato che lottava per l’apertura dell’ospedale, in quelle assemblee il Partito comunista era forte tanto da vincere le elezioni comunali ed esprimere nel 1980, per un solo anno, la prima carica cittadina. Chi non riusciva a emigrare, combatteva per migliorare le infrastrutture di un territorio rimasto anni luce indietro rispetto alle regioni travolte dall’accelerazione economica del dopoguerra. I tentativi di industrializzazione forzata (come il cadavere del cementificio iniziato negli anni Cinquanta e mai finito, recentemente raso al suolo) disarticolarono l’economia contadina e le paranze di pescatori incrementando l’emigrazione verso il nord. Dal 1971 Sapri cominciò a spopolarsi, una storia che si incontra nei vagoni della tratta Napoli-Sapri in Cafè express di Nanni Loy (1980).
* * *
La famiglia di Massimo è di origini venete. Il padre, Umberto, era un ex militare dell’aviazione italiana che dopo l’8 settembre si unì alle bande partigiane combattendo in un territorio dove la Repubblica sociale era molto forte. Dopo la guerra si sposò una prima volta con Teresa che gli diede tre figli morendo subito dopo; si risposò con la sorella della prima moglie. Da quest’ultimo matrimonio nacque Massimo, sua sorella Luna e i gemelli Serena e Mario. I primi figli non costruirono nessun rapporto con gli altri fratelli e in parte quel legame mancato richiama ancora antichi dolori.
Negli anni del boom economico, la famiglia si trasferì a Sapri seguendo il lavoro del padre, che avviò un servizio mensa per gli operai impiegati nei cantieri delle grandi opere pubbliche. A Sapri cominciarono i lavori della statale costiera che collegherà la città con Maratea, e il padre di Massimo vinse l’appalto per quel cantiere. Dopo la costruzione della statale, Umberto decise di finirla con quel lavoro che gli imponeva continui spostamenti. Rilevò un piccolo ristorante e rimase a Sapri. «In famiglia abbiamo sempre parlato veneto – dice Luna –. Con i miei fratelli condividevo la sensazione di essere straniera in quella terra. Qui se non fai il prepotente non ti ascolta nessuno». Luna racconta spesso questa sensazione di straniamento: «Massimo era il più buono tra noi, e una volta ci rimase davvero malissimo quando, appena diciottenne, gli amici lo lasciarono solo e lui per una bravata si fece una notte di prigione».
Secondo i fratelli, quell’esperienza scavò in lui delle ferite mai rimarginate. Luna quando parla del fratello ricorda sempre che era portato per la fotografia e quella passione poteva diventare un mestiere, ma verso i vent’anni qualcosa cominciò ad andare fuori rotta, Massimo cominciò a isolarsi. Quella melanconia che lo accompagnava nascondeva tensioni che non riuscivano a trovare forma e a volte si manifestavano attraverso comportamenti strani. C’era ancora tempo per ricucire le ferite e assorbire gli urti, indagare e comprendere. A vent’anni è tutto possibile. Eppure, questa storia si interrompe il 22 marzo del 1985.
Massimo aveva ventitré anni, guidava l’auto del padre e venne fermato da un vigile urbano. Il confronto con il pubblico ufficiale assunse toni strani, ma su questo i racconti si contraddicono. Il dato certo è che scoppiò un diverbio e il vigile fu colpito. Massimo venne arrestato e processato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, ma se tutto fosse rimasto sul “binario ordinario” quel ragazzo di vent’anni se la sarebbe cavata con qualche mese di carcere. Tuttavia, Massimo per il tribunale di Vallo della Lucania era semiinfermo di mente, malato e pericoloso. Così si aprirono le porte del “secondo binario”, quello ancora oggi percorribile delle misure di sicurezza destinate agli autori di reati che portano il peso di una diagnosi psichiatrica. Il provvedimento del giudice stabiliva che per vent’anni doveva essere rinchiuso in un ospedale psichiatrico giudiziario e il tribunale avrebbe monitorato progressivamente la pericolosità sociale.
Massimo entrò nell’inferno della contenzione pura, declinata attraverso le forme classiche del manicomio. Quelle tensioni che portava dentro di sé si trasformarono in forze difficilmente governabili e si mischiarono al linguaggio violento che apprese immediatamente per sopravvivere in quell’ambiente. Nell’Opg di Aversa, dopo appena un anno, durante una lite furiosa strappò gli occhi a un altro internato che morì poco dopo il ricovero in ospedale. La diagnosi psichiatrica relativa al proscioglimento per infermità descrive un essere abominevole. Massimo, legato, isolato, divenne l’oggetto di un graduale processo di mostrificazione coperto di ragionevolezza dalla scienza medica e giuridica. Girò quasi tutte le strutture del paese: Barcellona Pozzo di Gotto, Montelupo Fiorentino, l’Opg di Reggio Emilia. A Castiglione delle Stiviere si difese dall’aggressione di un altro internato tentando di cavare nuovamente gli occhi al ristretto. Lo sguardo sembrava ossessionarlo.
In questo percorso, Massimo regrediva costantemente perdendo il pensiero e il linguaggio, l’istituzione totale lo stava massacrando. Nel 2008 tornò a Napoli, internato nell’Ospedale psichiatrico di Secondigliano, qui lo seguirono alcuni operatori coscienti delle logiche manicomiali e del ruolo delle istituzioni. Sembrò cominciare finalmente un percorso di cura della sua sofferenza.
Durante i primi vent’anni di internamento gli equilibri familiari comprensibilmente mutarono. Luna alla fine degli anni Ottanta se ne andò a lavorare in Inghilterra, l’altro fratello Mario morì di overdose da eroina nel 1995 e l’altra sorella gemella di Mario emigrò a Torino mettendo su famiglia. Il nucleo familiare si sfilacciò dopo la morte della madre nel 2002. Luna quando tornò in Italia continuò a mantenere i contatti con Massimo, perché la mamma, Rosaria, in punto di morte le chiese di non abbandonarlo mai.
* * *
Nel 2015 il sistema contenitivo mutò forma con la chiusura degli Opg, l’istituzione delle Rems (Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza) e la presunta fine dei cosiddetti “ergastoli bianchi” (perché le misure di sicurezza strettamente restrittive “non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso”). In realtà, molte strutture non hanno smesso di assolvere la loro funzione detentiva accogliendo i ristretti del primo binario (come l’Opg di Aversa diventato uno dei quindici carceri della Campania) e altre continuano a rinchiudere sofferenti psichici provenienti dal circuito penale, come la struttura di Castiglione delle Stiviere che ha cambiato soltanto nome, trasformandosi in un’enorme Rems.
Il riesame della pericolosità sociale di Massimo aveva sempre esito negativo: la “schizofrenia latente cronica”, il peso dell’omicidio e del tentato omicidio hanno sorretto la misura di sicurezza detentiva a lungo. Finì in una Rems che riproduceva la medesima dinamica manicomiale e ormai la coscienza e il fisico erano fortemente danneggiati. Questo tipo di istituzioni totali sono congegnate per piegare l’individuo e, se solo riuscisse ad articolare la parola, Massimo potrebbe raccontarci di come è stata disattesa e sabotata la legge Basaglia e della caparbia resistenza del manicomio anche dopo la legge 81 del 2014. Tuttavia, il ricovero in Rems non poteva essere reiterato oltre gli anni di carcerazione inflitti (sospesi con l’esecuzione della misura) e per questo il magistrato di sorveglianza di Avellino, con ordinanza del 2019, sostituì il ricovero con (un altro ricovero) la “libertà vigilata residenziale” da eseguire presso una struttura convenzionata nella provincia di Salerno. Questa misura può restringere la libertà del soggetto al pari dell’internamento in residenza, ma formalmente (poiché non “detentiva”) elude quel limite imposto dal legislatore riproducendo – nei fatti e in forme differenti – gli ergastoli bianchi.
La schizofrenia, da un lato, e la continua sottrazione di elementi psicofisici adoperata con l’internamento, dall’altro, hanno annientato Massimo, che conserva alla soglia dei sessant’anni principalmente gli stimoli elementari. In questo lungo percorso incontra durante la reclusione nella struttura salernitana un’equipe di psichiatri dell’Asl di Salerno che cominciano a battersi per chiudere quantomeno la vicenda giuridica rimasta inalterata dal 1985. La battaglia viene condotta sull’assunto che la condizione psichiatrica non è di per sé indice di pericolosità e le condizioni attuali di Massimo, che a stento deambula, non consentono di immaginare future aggressioni. Questi elementi teorici e fattuali sono stati presentati dal difensore al giudice di sorveglianza nell’udienza per il nuovo riesame della pericolosità. La relazione dell’Asl depositata per il riesame era molto chiara: “Il paziente è in sufficiente compenso, assume regolarmente la terapia farmacologica prescritta e segue le indicazioni dei clinici di riferimento. Presenta sintomatologia residuale con eloquio stentato e di difficile comprensione, pensiero concreto povero, deterioramento cognitivo, comportamenti regressivi, necessità di assistenza anche per semplici compiti della vita quotidiana […]. Dalle valutazioni effettuate, allo stato, non emerge pericolosità sociale connessa alla patologia psichica. Nel complesso persiste la necessità che il paziente resti ricoverato in un ambiente protetto e stabile, in ragione delle condizioni sanitarie”.
Nel corso della prima udienza, il giudice sembrava perplesso. Incombeva sul tribunale un’altra domanda – forse più terrorizzante rispetto al quadro clinico tutto sommato sotto controllo –, non strettamente giuridica e che, invece, riguardava l’allocazione residenziale del soggetto nell’ipotesi di cessata pericolosità sociale. Quale posto potrebbe occupare nella nostra società un uomo con una residuale schizofrenia dopo quarant’anni di istituzionalizzazione? Questo vegetale che a stento riesce a muoversi necessita ormai di assistenza continua e la sorella Luna, unica tutrice, isolata in un piccolo paese, non riuscirebbe a occuparsi del fratello. Appurato in una seconda udienza che il soggetto poteva rimanere nel “finto manicomio” (avrebbe detto Sergio Piro) in cui era in esecuzione la “libertà vigilata residenziale”, previo consenso della tutrice, il giudice dichiarava cessata la pericolosità sociale e per tale effetto disponeva la revoca della misura di sicurezza.
Con la decisione del giudice di sorveglianza di Salerno la storia giudiziaria di Massimo si è chiusa definitivamente, ma il finale resta amaro. La ferocia istituzionale ne ha compromesso la capacità di relazionarsi con l’esterno mortificando la sua condizione umana. Il quadro complessivo attuale non intacca il bisogno di custodirlo, ma nelle nostre comunità non c’è posto per Massimo e per quelli come lui. Non c’era spazio quando la sofferenza si era appena affacciata e non esiste oggi che è ridotto a un vegetale. “La scoperta della libertà da parte della psichiatria – scriveva Basaglia – porta dunque il problema del malato mentale fuori dal manicomio. In realtà, vi sono ancora ovunque grate, chiavi, sbarre, cancelli, personale con scarsa preparazione tecnica e spesso umana, ma il problema è comunque aperto: la distruzione del manicomio è un fatto urgentemente necessario, se non semplicemente ovvio”. (luigi romano)
Post Scriptum
Ciao Luigi. Ho letto il tuo scritto. Ci sono molte cose che non sapevo dell’esistenza di Massimo, sia di quella precedente alla sua sommersione nel manicomio, sia dopo la sua uscita. Mi hai fatto riapparire davanti agli occhi quel corpo nudo, quel groviglio di ossa e pelle arrotolato come una lumaca senza il guscio che si intravedeva dietro la parete del bagno della sua cella quando mi affacciai per capire chi c’era lì dentro. Il materasso di gommapiuma su cui si era adagiato era scavato nel mezzo, perché Massimo, nel suo tentativo di scomparire ancora di più, cercava di entrarci dentro. Allungò il braccio per tirare a sé la ciotola di pasta che il lavorante di sezione gli aveva lasciato vicino alla grata. Fu quella mano protesa che mi diede la certezza che di fronte a me c’era un essere umano. Mi dissero che era lì, così, da tanto tempo, in una cella alla fine del corridoio di una sezione.
Tutti avevano paura di lui, anche io. Della sua vita non sapevo niente, tranne che aveva strappato gli occhi a un internato e che aveva tentato di fare lo stesso con un altro. Ma di quella vita potevo sapere qualcosa, se volevo. Cominciai così a cercare nelle carte che raccontavano della sua esistenza chiusa, perché anche al chiuso si continua a vivere. Massimo era nato e viveva a Sapri, aveva conseguito la licenza media e a diciotto anni aveva “fatto il militare” e poi aveva lavorato nel ristorante di famiglia. A ventuno anni cominciò a stare male e lo portarono in un centro di salute mentale. Seppi infine che quand’era ancora nella sua vita di prima faceva il fotografo, ed era anche bravo. All’età di ventitré anni, rinchiuso nel manicomio criminale, si è preso gli occhi degli altri.
Nella contesa tra psichiatria e giustizia penale che si giocò intorno a questa storia fu alquanto difficile trovare ragioni certe nell’uno e nell’altro campo. Se è vero che gli eventi successivi all’internamento erano una “prova” evidente della pericolosità sociale di Massimo, è anche vero che gli atti più cruenti, le aggressioni più raccapriccianti, avvennero nel manicomio, il luogo dove quella forza distruttrice avrebbe dovuto essere neutralizzata e curata. Se sia stato il vagare della mente di Massimo a condurlo a quella terrificante progressione, o se fu la vita cui venne costretto nel manicomio a farlo definitivamente precipitare verso il suo epilogo finale, è questione aperta.
Dopo qualche mese un brigadiere della polizia penitenziaria cominciò a farlo uscire dalla stanza. Non aveva paura di Massimo e Massimo si appoggiava al suo braccio, e camminavano. Lui aveva la fede e vide subito l’uomo. Io ero pieno di rabbia e percepii solo i suoi resti. La sua stanza si arredò con un letto, un tavolo, uno sgabello e un armadietto. Cominciò anche a uscire nel giardino e nel campetto di calcio. Il brigadiere gli parlava e lui sembrava ascoltarlo.
Lasciai il manicomio poco prima che chiudesse e di Massimo non seppi più nulla. (nicola staiano)





Leave a Reply