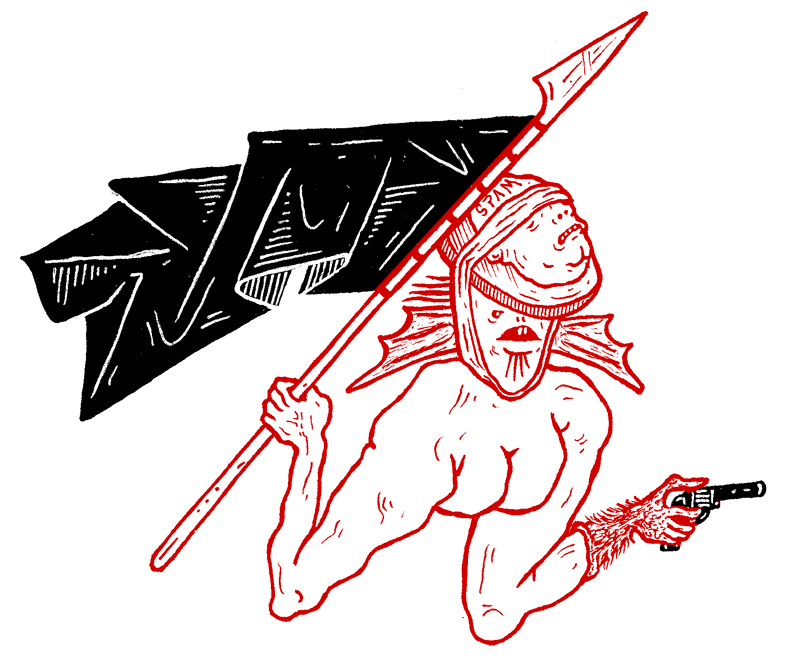
“A quindici anni imparano a sparare. A vent’anni sono dei killer. A trenta non ci arrivano”. Così vengono presentati i protagonisti di Robinù, docu-film sulla “paranza dei bambini” diretto da Michele Santoro e proiettato nelle sale napoletane il 6 e 7 dicembre scorso.
Con un’apertura sul golfo di Napoli e una colonna sonora perennemente drammatica, la pellicola prende le mosse dalle storie di alcune famiglie coinvolte nella guerra tra gli eredi del clan Giugliano e il clan Sibillo per il controllo del centro storico. Il regista cerca di mostrare lo spaccato di un mondo sconosciuto a una certa parte dell’Italia. Si inizia da non-luoghi che lo spettatore “straniero” con difficoltà riesce a collocare geograficamente: il carcere minorile di Airola, in provincia di Benevento, il carcere di Poggioreale, le strade del centro storico. Per chi non conosce la realtà napoletana, ma anche per chi è del posto, le storie narrate appaiono poco connesse tra di loro: la famiglia di parcheggiatori abusivi con quattro figli, tre detenuti e uno emigrato a Parigi; la madre per bene che ha perso il figlio perché deciso a intraprendere la strada dell’illegalità; ragazzini tra i quindici e i diciotto anni cresciuti con il mito delle armi e della violenza; donne di casa che per mantenere mariti (in carcere) e prole si inseriscono nel circuito dello spaccio di coca. Non esiste un filo conduttore che unisca queste trame, che indaghi, come lo stesso regista ha definito in un’intervista alla 73° Mostra di Venezia, «la continuità urbanistica tra vicolo e carcere», che contraddistingue la vita di questi ragazzi e non solo.
Le immagini vengono presentate come dispensatrici di una verità assoluta: se Benjamin sosteneva che a Napoli “nessuna situazione appare come essa è, pensata per sempre, nessuna forma dichiara il suo ‘così e non diversamente’”, per Santoro le rappresentazioni della sua pellicola esprimono il “così e non diversamente” delle esistenze di questi giovani e delle loro famiglie; si procede così a un’oggettivazione di quelle esperienze senza riuscire a ricondurle in un preciso contesto culturale, sociale ed economico. Non riesce a emergere la volontà di questi baby-boss di colmare un vuoto lasciato prima dalla Nuova Camorra Organizzata e poi dal Sistema post-guerra scissionista a Secondigliano; non emerge la crisi che, così come tutte le economie internazionali, ha investito anche quella extra-legale del crimine organizzato, riducendo al minimo la redistribuzione del welfare dei clan; non emerge che con tutti i capi storici in galera, in una tomba o pentiti, solo figure giovanissime potevano guerreggiare per l’ottenimento del potere. Senza questi e altri elementi, viene tutto ridotto a tragedie familiari e mitizzazione delle armi: la complessità sociale di questi giovani, che con sedici anni di pena da espiare usciranno di cella a quaranta, viene sintetizzata dall’idea che possedere «’o Kalash’(nikov) è come tenere Belèn tra le braccia».
Maggiore risalto viene dato a uno dei figli della famiglia di parcheggiatori, Michele, ventidue anni, detenuto a Poggioreale, che con la determinazione di essere autonomo, di “non stare sotto a nessuno”, non si affilia, conduce i propri affari, è riconosciuto come benefattore dalla gente del quartiere. È lui Robinù, così come viene definito dal padre. Biondo, occhi chiari e lucidi, pupille dilatate, evidentemente distrutto dalla permanenza in carcere e dalla mancanza di futuro: cosa fare dopo essere entrati in galera ragazzini ed esserne usciti adulti? Che prospettive ha un giovane come Taieb, detenuto ad Airola, figlio di una prostituta immigrata e portato via dal padre napoletano che ha condotto anch’egli una vita di extra-legalità? Che dire di madri che vendono droga perché non trovano altre “opportunità di lavoro”?
È qui che secondo l’autore dovrebbe intervenire lo stato, il grande assente di questo documentario, con tutta probabilità volutamente non rappresentato perché, come lo stesso Santoro ha avuto modo di dire, «prende tutti i vantaggi di un Pil e di un welfare criminale» e non garantisce ai suoi cittadini una strada di “emancipazione” dalla malavita.
Per il giornalista, dunque, una parte della popolazione extra-legale napoletana è priva di “colpa”, quasi come fosse incapace di intendere e volere, come animali da soma che non possono capire le ragioni dello sfruttamento a cui sono sottoposti. Chi, per Santoro, si libera da questa condizione è il fratello di Michele, emigrato in Francia per “vivere di lavoro”. È la sua figura che ci pone di fronte alla condizione razzializzata che i napoletani vivono in territorio nazionale e straniero. Come non rimanere colpiti dalla scena in cui il pizzaiolo mostra la sua prima “casa” una volta arrivato a Parigi: un cassonetto della spazzatura condiviso con un altro senzatetto maghrebino, il suo primo amico. Eppure, verrebbe da pensare, non sono bianchi i napoletani? Non fanno parte dell’Occidente modernizzato? A modo loro, sì. Il desiderio di potere e soldi, nutrito dai ragazzini della “paranza” e non solo, non è, in fondo, la versione illegale del “sogno neoliberale” di cui siamo stati nutriti fin da quando ne abbiamo memoria?
Come fare a restituire le articolazioni sociali di un fenomeno come l’extra-legalità nella nostra città, con una dozzina di interviste sommate tra loro? È proprio la volontà di rappresentare la realtà con la “erre” maiuscola, il limite più grande di tutta la produzione televisiva, giornalistica e cinematografica degli ultimi anni sulla città partenopea e da cui l’opera di Santoro non differisce granché. Ci si dimentica che dietro l’inchiesta di un giornalista o la macchina da presa, ci sono persone con una data interpretazione dei processi sociali, una data estrazione di classe, una data formazione culturale che non fanno altro che rappresentare una data idea del mondo, la loro.
A guardare il film con me, seduti nelle altre file della sala, c’erano famiglie e giovani dei quartieri popolari di Napoli, desiderosi di vedersi “rappresentati”, di sentire che si parli di loro e delle loro vite, sempre ben disposti verso qualcuno che gli dia voce, a loro che voce non ne hanno. (andrea pomella)





Leave a Reply