
È in libreria a Napoli, Roma, Milano, Torino, Firenze e Bologna il numero zero de Lo stato delle città. Pubblichiamo a seguire un’anteprima dell’articolo di Davide Schiavon: “Capire il mondo e raccontarlo”. Il grande inganno del giornalismo .
* * *
Se vuoi fare il giornalista professionista, al Suor Orsola Benincasa c’è il master giusto. È riconosciuto dall’ordine nazionale e ti abilita alla professione. Ti insegneremo a capire il mondo e a raccontarlo. Quest’anno anche una novità, ottanta crediti su centoventi da utilizzare per una laurea magistrale in comunicazione pubblica e d’impresa. Le iscrizioni sono già aperte…».
Il volto pallido di Marco Demarco, ex direttore del Corriere del Mezzogiorno, ora a capo del master di giornalismo del Suor Orsola Benincasa, fa capolino ogni venti minuti tra le pubblicità che scandiscono l’attesa dei treni della metropolitana. Lo spot è solitamente preceduto da un invito allo screening della prostata. Subito dopo viene la lettera scritta dai galeotti e indirizzata alle baby gang. Se si è sfortunati, si può vedere l’intera sequenza anche due volte prima del treno, e comunque almeno tre volte al giorno per chi utilizza l’essenziale trasporto pubblico partenopeo. Perché l’università privata più importante a Napoli reclamizza, tra i tanti corsi e master, proprio quello di giornalismo? Perché così assiduamente? Gli stage prospettati agli allievi sono prestigiosi: Rai, Sky News, Mediaset, Repubblica, Corriere del Mezzogiorno. I prezzi mediamente inaccessibili: in due anni l’aspirante giornalista dovrà pagare sei rate da duemila e quattrocento euro cadauna. Un costo di accesso alla professione giustificabile solo in caso di un eventuale contratto indeterminato in Rai.
Spesso, invece, ci si deve accontentare dello stage nel grosso gruppo editoriale, una stellina tra i fogli di un curriculum vitae destinato a centinaia di caselle di posta elettronica. Offerta di lavoro non c’è. Il giornalista per molti è colluso, prezzolato, truffatore, venduto. Allo stadio San Paolo i tifosi delle curve cantano cori ed espongono striscioni contro i giornalisti. La diffidenza trova massima espressione nell’immaginario dei grillini su Facebook – con i loro colorati meme – ma è valida per ogni campo del mestiere. Si pensi ai giornalisti tifosi, che pur di distinguersi diventano oleografie delle città d’appartenenza, per compiacere i conterranei e farsi detestare dai rivali. Eppure, anche per l’astio di cui sopra, il mestiere esercita ancora un certo fascino, che le università monetizzano. Sul sito del Suor Orsola si precisa “che la frequenza alla Scuola non comporta in alcun modo un automatico sbocco occupazionale”.
Il capocronista Cechov
«Io ho ancora voglia di sporcarmi le scarpe!», disse nell’ammirazione generale il capocronista in una riunione di redazione. Si discuteva di turni, di compensi e di straordinari, in vista del lancio del palinsesto. Lui invece parlava di passione pura, di curiosità, di moto a luogo. Ma nei tre anni successivi il capocronista Cechov non si alzò mai dalla sedia, fu il più coriaceo di tutti, premiato con la grazia nei giorni dei licenziamenti collettivi.
In una redazione televisiva c’era “la sciampista”. La chiamavano così per la sua inadeguatezza al lavoro giornalistico. Dicevano che in un negozio di borse non avrebbe sfigurato. Licenziata perché pubblicava foto dalle località sciistiche mentre risultava malata, è diventata la fidanzata dell’avvocato che per l’azienda tagliava le teste in redazione. Si è trasferita a Posillipo e gestisce un’attività di cake-design.
«Ti insegneremo a capire il mondo e a raccontarlo», assicura Demarco. Sul piccolo schermo nelle stazioni della metro scorrono immagini di allievi giornalisti impegnati in dibattiti televisivi, in diretta da una manifestazione di piazza, concentrati durante le interviste ai signori della Politica. Il video-giornalismo sembra la parte prevalente del programma didattico. Eppure in Campania le tv locali hanno perso soldi e autorevolezza. A Napoli tirano a campare poche storiche emittenti, di tanto in tanto fa capolino un nome nuovo (con un cognome vecchio) che imbastisce un’innovativa impresa destinata puntualmente al naufragio. Questi avventurieri dell’etere scontano anche l’invecchiamento del pubblico televisivo, affezionato a due o tre canali sul telecomando e poco altro. I più anziani identificano ancora la Rai come la sola rete deputata all’informazione: «Ma chesta quale Rai è?», chiedono a chiunque regga una telecamera.
Le tv locali si mantengono con i contributi Co.re.com (Comitato regionale per le comunicazioni) e con la vendita di spazi televisivi per la pubblicità. Se nel primo caso servono agganci e talento politico per aggirare le graduatorie (e lo dimostrano recenti inchieste della Guardia di Finanza), nel secondo molto sta alla bravura del reparto commerciale: si cerca di spolpare un osso sempre più magro vendendo programmi infarciti di personaggi che dovrebbero spostare fette di pubblico. Si fa largo la figura del giornalista-mercante, che trova sponsor per le sue trasmissioni (in prevalenza tribune sportive, le uniche che ancora assicurano introiti pubblicitari) offrendo la garanzia del suo viso, la sua notorietà. Quanto queste pratiche abbiano a che fare con il giornalismo è un mistero, eppure succede, specialmente in Campania, dove bisogna muoversi ben oltre il mansionario per guadagnarsi qualche soldo.
Lontano da studi televisivi e palinsesti la situazione non migliora. I grossi giornali sono in difficoltà e non assumono, anzi, licenziano anche tra tecnici, poligrafici e operatori. Entrare in una redazione innesca una competizione sfiancante tra precari che si contendono mezzo posto. I contratti sono una chimera, si cerca allora di tenere aperte tre o quattro porte contemporaneamente, piazzando un pezzo ogni tanto. Le collaborazioni sono pagate a centoventi giorni, se va bene. A volte si smette di lavorare per un giornale senza neanche salutarsi, senza aver mai conosciuto i colleghi. E se sei stabile in una redazione e da pubblicista diventi professionista, ai complimenti spesso si accompagna la lettera di licenziamento, visto che quel minimo salariale stabilito dal contratto nazionale è fuori mercato per molti, troppi editori locali.
«È riconosciuto dall’ordine nazionale e ti abilita alla professione…». Qualcuno tra i giovani in attesa alza lo sguardo dal telefonino e valuta l’opportunità offerta da Demarco. Sul display al centro della banchina compare solo il numero verde dell’Azienda Napoletana Mobilità, si comincia a percepire il ritardo. Ci si può trovare incastrati in un mestiere, caro Demarco. Lo si cerca con forza, poi subentrano i dubbi, si studiano gli inevitabili compromessi. Nella zona grigia del mestiere si trovò il napoletano Nicola Pugliese, autore dello splendido Malacqua, romanzo Einaudi 1977. Pugliese scriveva cronache sul Roma. Si “sentiva” un professionista? «Facendo il giornalista mi dovevo occupare tutti i giorni di cose di cui non mi fregava assolutamente niente – affermò in una rara intervista –. Ero poco soddisfatto di questo tipo di lavoro. Siccome la mia formazione era letteraria, unendo due mondi detti vita a Malacqua». Nella zona grigia si trovano oggi decine di cronisti che saltabeccano da una collaborazione all’altra, combattuti tra seguire la vocazione o cambiare rotta alla ricerca di stabilità, magari andando al nord, dove i profili editoriali sono più ampi: addetti alla comunicazione, social media manager, copywriter. Oppure ci si può sentire giornalisti fino al midollo, “giornalisti-giornalisti” come nel refrain di un film su Siani, il cronista ammazzato dalla camorra negli anni Ottanta. Una definizione molto in voga nell’ambiente, associata a chi ha una certa tendenza a rompere le uova nel paniere, talvolta senza raccontare nulla di particolare ma con l’obiettivo prioritario di puntare il dito verso un colpevole. A questa tipologia di cronisti l’industria editoriale riserva talvolta carriere più veloci. Come i pagliacceschi opinionisti sportivi, gli “scoperchia tori del marcio” sanno regalarci una mezz’ora di ottima indignazione e ottengono i favori del pubblico. Impareremo il loro nome, aspetteremo con ansia le nuove scoperte e seguiremo gli sviluppi giudiziari che ne seguiranno. Legalità restaurata, riqualificazione, sicurezza, benessere, trasparenza, decoro.
La curiosità perduta
«Da quanto tempo state aspettando?», chiede una signora a un gruppo di giovani seduti sul pavimento in pvc bullonato di questa stazione senz’arte. Tempo fa conobbi un ragazzo, venticinquenne, che sognava di diventare giornalista. Mi disse che voleva entrare in una scuola di giornalismo del nord Italia. Pochi mesi dopo mi contattò. Era sbrigativo: «Ciao, forse non lo sai ma io adesso sono autore delle Iene». Aspettò i miei rallegramenti per qualche secondo, poi mi chiese di partecipare a un suo servizio: bisognava andare a stanare la camorra nel rione Sanità, a mostrare con la telecamera nascosta gli affari illeciti dei clan. Avevo altri impegni.
Le redazioni, se si escludono le testate principali, a Napoli sono luoghi privi di storia, uffici spogli in palazzi di recente costruzione. Le sedi vengono lasciate o cambiate, si preferiscono appartamenti in periferia, su strade provinciali larghe e desolate. In ufficio si costruiscono rapporti usa e getta, come quando s’attende in una metropolitana. Da strumento del mestiere, la capacità di sintesi diventa la chiave per interpretare tutti gli aspetti della vita, la semplificazione un modo di pensare il mondo in cui si vive.
La redazione è una distilleria, nel processo di trasformazione delle informazioni spesso evapora la complessità di una vicenda, condensandosi in parole chiave che finiscono per essere lette da migliaia di persone. Scivola in secondo piano la curiosità, perduta tra i fumi dei macchinari della redazione. Un giovane cronista dovrà capire come trasformare quello che vede e che ascolta nelle gocce che servono alla testata per cui lavora. E dovrà capirlo in autonomia, ché il tempo di insegnarlo in redazione non c’è. In redazione potrebbe anche non entrarci mai, questo giovane. Il pezzo lo può confezionare da casa, dalla strada, talvolta inviare una semplice diretta con il telefono. Si lavora per conto proprio, senza alcun confronto, senza correzioni a meno di clamorose sviste. Conta il prodotto finito, consegnato nel più breve tempo possibile: il rischio di essere sorpassati dalle tecnologie è dietro l’angolo. Il “buco” giornalistico è un lontano ricordo, se qualcosa manca è perché non la si vuole raccontare. Negli anni Cinquanta i fogli di un giornale erano pochi, oggi sono quintuplicati; gli spazi su una pagina internet sono infiniti. I grossi giornali, impegnati in una lenta migrazione dalla carta alla rete, vengono stracciati in termini di visualizzazioni da nuove realtà in espansione, nate apposta per il web e che sulla rete trovano sostentamento e guadagni vendendo spazi pubblicitari. (continua…)

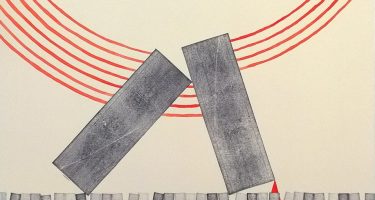


1 Comment