La notizia ha riempito i quotidiani e attirato le attenzioni del popolo dei vacanzieri italiani. Nella notte tra il 18 e il 19 luglio scorso un diciassettenne umbro muore in pista al Cocoricò, tempio della dance music romagnola. Dalle prime indagini sembra che il ragazzo abbia assunto MDMA, metanfetamina, con effetti letali.
Un diciassettenne in vacanza in Romagna, prende il treno con un gruppo di amici e se ne va a ballare al Cocoricò. Si prende una “pasta” di ecstasy e muore in pista da ballo. Inaudito. Oltraggioso. Scatta una campagna allarmistica sul consumo di droghe. Il Belpaese, già piegato dall’austerity, si scopre in balia delle droghe, i “nostri” giovani bruciati dalle dipendenze. Balle.
Secondo il Dipartimento delle politiche antidroga della presidenza del consiglio dei ministri, infatti, i morti per assunzione di sostanze stupefacenti in Italia sono diminuiti notevolmente, dai mille circa del 1999 ai trecentoquaranta del 2013. Dal 2004 in poi, il trend dei decessi per overdose è stabile e non supera mai il decennio precedente. A leggere i dati viene fuori un quadro ancora più preciso, che sbugiarda i corvi dell’informazione di regime impegnati a dipingere un’Italia di tossicomani, storditi dall’“unza-unz” diffuso dagli altoparlanti delle discoteche. Mentre l’eroina resta la sostanza più letale, con il triste primato del quarantadue per cento delle morti totali, la temutissima ecstasy finisce in un minuscolo “calderone” che non raggiunge l’un per cento insieme ad altre sostanze.
Il giorno dopo la morte del ragazzo umbro, il presidente del Codacons Carlo Rienzi dichiara che “se nel corso delle indagini emergerà che la droga è stata assunta all’interno del locale dovrà essere disposta la chiusura della discoteca”. Applausi. Secondo Rienzi, prontamente ripreso da opinionisti di ogni specie, i locali hanno “il compito di vigilare su ciò che accade all’interno delle strutture” e, aggiungendo un tocco di comico al grottesco, “vietare l’ingresso e la vendita di droghe nelle aree di loro competenza”.
Senza nemmeno l’ombra dell’emergenza, quindi, ma anzi alla luce di un caso sporadico e raro secondo le statistiche, sull’onda dell’indignazione manipolata ad arte dai media ufficiali, il Cocoricò chiude. Uno degli infermieri che ha soccorso il ragazzo quella tragica notte sfoga su Facebook la propria rabbia: “Io spero solo che un giorno si possa andare a raccogliere uno a uno tutti quelli che fanno della droga un business, per poi chiuderli nel loro caro Cocoricò e sganciare una bomba a mano che non faccia rimanere di loro neanche il ricordo”.
Ci sono tutti gli elementi del solito dibattito cialtrone italico, il polverone estivo senza alcuna base reale, il giustizialismo, la scelta di un capro espiatorio su cui concentrare la rabbia, rimuovendo l’oggetto reale della questione. Al centro di tutto il Cocoricò, cattedrale delkitsch e del divertimento easy per decine di migliaia di giovani che al suo interno ballano, vanno a caccia di prede sessuali, sfoggiano l’ultima maglietta alla moda o si abbuffano di droghe. Cocaina, soprattutto, ma anche eroina – sniffata o fumata, così si ha l’illusione di non essere dipendenti – e infine le pastiglie. Un luogo, a dirla tutta, non molto attraente. Però chiuderlo sembra veramente una soluzione solo ai barbagianni della carta stampata, che nella foga di trovare un oggetto su cui far convergere la rabbia dei cittadini, non si fanno specie di passare come un rullo compressore sulle vite, per esempio, delle decine di lavoratori che con quel tempio cafone della notte danzereccia ci portano a casa lo stipendio. Lavoratori, anch’essi spesso in condizioni terribili, in piedi tutta la notte per turni massacranti e mal retribuiti: cubiste, camerieri, barman, buttafuori, addetti alle pulizie, più l’indotto. Tutti a casa per centoventi giorni, titolano i quotidiani.
La febbricola securitaria, pronta a svanire nell’arco di due settimane, contagia un po’ tutti. Nel Cilento i giornali danno addosso a uno storico locale della costa per la morte di un altro ragazzo – si scoprirà poi, per il crollo di un muro e non per le droghe. Ma tutto fa brodo e quest’altra morte finisce nella caldaia ad alimentare il fuoco della rabbia sociale. Una follia che arriva al delirio, con la proposta dello stesso De Meis, proprietario del Cocoricò, del Daspo per chi commette reati all’interno di un locale notturno. Il tutto condito dal solito rosario di proposte inutili e al limite del comico, come la chiusura anticipata, il divieto d’ingresso ai minorenni e stupidaggini del genere.
Sicuramente colpisce la pretesa che i locali pubblici debbano vigilare sulla vendita di sostanze stupefacenti al loro interno. Come? Non ci riesce la polizia – e chiunque sia mai andato una sola volta a ballare (non al Cocoricò, ma in un qualsiasi club) può constatarlo –, non si capisce come debbano farlo i gestori. Sostituendosi alle forze di polizia? E fino a quanti metri dalle porte del locale? In che modo? Pagando milizie armate? Perquisendo i clienti o facendo test all’ingresso e all’uscita a ciascuno?
Così come le curve degli stadi, giusto per citare un altro luogo di aggregazione nel mirino delle questure e dei moralisti, le discoteche fungono, da sempre e periodicamente, come laboratorio dentro cui si sperimentano iniziative di repressione, come l’ormai famoso quanto inutile Daspo. Droghe, giovani morti, spaccio, la disperazione dei genitori. Argomenti a partire dai quali si potrebbe, invece, cominciare a ragionare su che razza di società abbiamo costruito finora.
Per chi, poi, abbia tra i suoi obiettivi quello di raccontare il mondo che lo circonda, annotandone fenomeni e accadimenti, lascia colpiti che nella gazzarra di voci che si affannano a “coprire” l’evento, nessuno abbia mai messo piede in una discoteca, o quanto meno ci abbia mai capito qualcosa. Eppure, andrebbe raccontato quel mondo delle dancefloor, dalle balere ai club off degli anni Settanta. Luoghi dentro i quali è possibile leggere la storia vera della società, attraverso la semiotica dell’abbigliamento e delle acconciature, come attraverso gli stili musicali e i modi di ballare, raccontando in questo modo la storia sociale senza filtri. Pensiamo a Napoli alla storia di club come il Trilogy al Vomero, o il Diamond Dogs. O ancora, negli anni Novanta, il Notting Hill di piazza Dante e il Velvet Underground, dove l’effervescenza sociale di quel periodo trovava palcoscenici lontani dallo scenario ormai stantio delle discoteche alla moda. Ma le piste da ballo raccontano anche la storia del potere e dei suoi figli. È immediato pensare alla chioma unta di De Michelis che svolazza nelle discoteche “in” di Roma e Milano, in quel clima da basso impero che precede di poco il crollo della Prima Repubblica; ma anche, per tornare a Napoli, i locali dove si vedeva la Napoli bene, quella dei figli dei professionisti, di quella borghesia codarda e famelica che ha divorato la città nell’ultimo secolo. I locali di Posillipo e del Vomero, quelli di Chiaia e via dei Mille, dove si agitava la classe dirigente della città. A ogni modo, come sempre, il punto è proprio cominciare a raccontarla, questa storia. Queste storie, anzi, a partire dai protagonisti, da chi quelle piste da ballo le ha calpestate per davvero. (antonio bove)

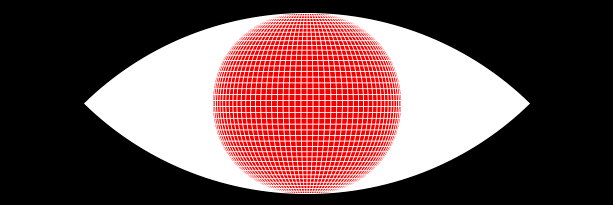
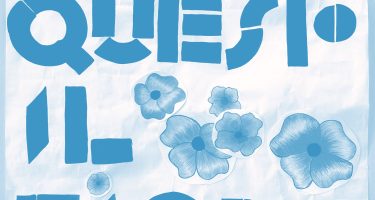

Leave a Reply