
da Napoli Monitor n. 53, marzo/aprile 2013
Erano venuti ancora, di notte, come i lupi. Bernardo lo capiva dal fetore che esalava dalla terra; con le mani incrociate sulla zappa ben piantata in un solco, guardava il rigagnolo giallo che sgorgava dal suo campo giù nel canale del lagno. Il sangue gli ribolliva, si sentiva un diavolo pieno d’odio, ma si sapeva anche indifeso come un agnello. Che doveva fare se il suo fondo coltivato tra le contrade Pantano e Lenza Schiavone nella campagna di Acerra era diventato una discarica di roba schifosa? Di chi era la colpa se da qualche tempo camion-cisterna senza insegna scendevano dall’asse mediano sulla strada poderale e si affiancavano al seminato per sputarci sopra veleno? Con altri contadini s’era appostato una notte per capire. Erano rimasti immobile tra gli alti fusti del mais. Il camion era arrivato, degli uomini erano scesi e la pompa della cisterna aveva iniziato a scaricare. Non s’erano mossi, lui era sicuro di aver notato delle armi, illuminate un istante dai fasci di luce dei fari. Finito lo sporco lavoro, il camion si era allontanato.
Bernardo s’impuntò con gli altri contadini: bisognava denunciare. E così avevano fatto, una volta, due, tre; i moduli da compilare al commissariato di Acerra li conoscevano a memoria, e quella sensazione di essere derisi dal maresciallo li accompagnava sempre fino alla porta. Loro denunciavano, ma gli scarichi continuavano. Erano esasperati, se le forze dell’ordine li pigliavano in giro non c’era altro da fare che andare da Di Fiore, uno dei boss del paese. Solo la camorra può battere la camorra, pensavano. È stato lo stesso Di Fiore, oggi collaboratore di giustizia, a raccontare ai magistrati che i contadini acerrani si erano rivolti a lui per far cessare gli scarichi dei Pellini. Ma neanche lui poteva fare molto. I tre fratelli Pellini, quindici anni fa possedevano una ditta di spurghi, qualche rimorchio, un pezzo di terra. Per campare ripulivano i pozzi neri sotto i cortili. Alla metà degli anni Novanta entrarono in affari con il clan Belforte di Marcianise, a sua volta legato ai casalesi: quelli che hanno inventato il traffico di rifiuti industriali verso le campagne di Napoli e Caserta. I Pellini erano imprenditori di poco conto ma con l’affiliazione al clan diventarono una delle ditte innestate nell’organigramma criminale dello smaltimento dei rifiuti tossici, la vacca più grassa tra le tante spremute dalla camorra.
Secondo le indagini confluite nel 2006 nel processo Carosello-Ultimo Atto, le scorie movimentate e smaltite dai Pellini ammontano a un milione di tonnellate, con un ricavo stimato di ventisette milioni di euro. Ci hanno fatto di tutto con quei veleni. Li hanno scaricati nei loro terreni a Lenza Schiavone, li hanno mischiati al terriccio e venduti come compost, li hanno buttati nelle betoniere per nasconderli nel cemento, ci hanno riempito le cave a Bacoli, Giugliano e Qualiano, e quando lo spazio mancava c’erano i canali dei lagni e i terreni coltivati a disposizione. La campagna di Acerra è vasta e la materia da trattare sembrava non finire mai. Tramite i rapporti privilegiati con i Belforte, i Pellini riuscivano a movimentare carichi da industrie della Toscana e del Veneto, e durante le fasi più acute dell’emergenza rifiuti urbani a Napoli e provincia fecero accreditare i loro impianti dal commissario straordinario per stoccarvi il rifiuto tal quale e le ecoballe. L’affitto dell’area era stato fissato a quattromila euro al giorno, per un deposito durato diversi anni. Crediti che ancora oggi i Pellini, con un piede già in galera mentre il processo a loro carico si avvia alle fasi finali, esigono dal comune di Acerra.
Si sentivano al sicuro, i Pellini. Uno dei fratelli era maresciallo dei carabinieri e per suo tramite denunce e controlli cadevano nel vuoto. Altri complici al comune fornivano autorizzazioni false, così l’azienda appariva in regola. Una rete diffusa in tutta Italia collegava siti di trasferenza e laboratori d’analisi, per oliare i passaggi dei rifiuti e camuffarne la natura, falsificando le bolle d’accompagnamento. Le protezioni importanti li difendevano dai clan locali – dei principianti a confronto –, bastava dividersi gli introiti con i boss casertani. Come altri imprenditori rampanti dell’ultimo scorcio di secolo in Campania, gente come Gaetano Vassallo, Cipriano Chianese, i fratelli Orsi, Ludovico Ucciero e molti altri, anche i Pellini erano passati da un’imprenditoria di scarto alla camorra dei rifiuti.
Il terreno di Bernardo ne aveva viste tante, ci erano passati sopra millenni di storia. Ma questa nuova destinazione d’uso come assorbitore di cromo, policlorobifenili, idrocarburi, mercurio e metalli pesanti era una novità. Il cambiamento ambientale impresso dall’azione umana era di tale portata da poter essere paragonato solo alle imponenti opere di bonifica che tra sette e ottocento avevano asciugato il terreno, sottraendolo alle piene del Clanio, con quel gigantesco progetto ingegneristico che creò i Regi Lagni. La bonifica lo rese coltivabile, i rifiuti lo condannano alla contaminazione per decenni. Curioso passaggio. Come se la terra fosse diventata solo spazio vuoto da colmare. E se guardassimo attraverso la grana nera di un fazzoletto di terra per ricostruire i processi che hanno condotto all’attuale geografia del rifiuto, vedremmo l’agricoltore lentamente declinare, insieme al valore del suo lavoro, sostituito dal compimento di progetti che seguono le vie tortuose dei capitali e dei valori di scambio. L’uomo urbanizza da sempre la natura, ma come, con quali scopi e a beneficio di chi, sono le domande da porre per catturare i nessi tra il cambiamento ambientale e le forme del potere. Guardate alla terra e capirete chi comanda.
Il padre di Bernardo era un proprietario accorto, negli anni Sessanta era riuscito a guadagnare bene coltivando pomodoro da industria. La terra faceva campare a quel tempo. Aziende e cooperative mettevano verdure, patate e pomodori. Anche la camorra era in affari: aveva imparato a spolpare i fondi statali all’agricoltura attraverso cooperative false e rese fantasma. Vista l’assenza di poli commerciali e di impianti di trasformazione in loco, i prodotti acerrani dipendevano dagli intermediari, di solito emanazione dei clan del territorio. Nonostante ciò, i piccoli e medi proprietari erano in attivo e pastori di bufale e pecore adoperavano i pascoli comuni producendo latte e lana. Con l’arrivo della Montefibre alla fine dei Settanta, una fabbrica di poliestere, alcuni terreni degli amici del padre di Bernardo vennero espropriati. I contadini rimasti disoccupati dovettero lottare per costringere la fabbrica ad assumerli. Quelli entrati nello stabilimento ci misero poco a rendersi conto della prigione insalubre in cui erano finiti. Ma era il progresso, non si poteva fermare. Quando il padre di Bernardo morì, lui non volle vendere, anche se i pomodori non andavano più così bene.
Lo spazio urbano si espandeva, tanti dei suoi amici avevano venduto a prezzi convenienti e sui loro terreni ora sorgevano palazzine dai colori pastello. C’è ancora tanta terra tra me e la città, pensava Bernardo, la campagna è ancora importante. Eppure, non poteva nascondersi che la campagna stava cambiando. Quando si fermava per asciugarsi la fronte, bastava alzare lo sguardo per vedere all’orizzonte colonne di fumo nero che si innalzavano dai campi verso le zone di Caserta, ogni santo giorno. Aveva pure incrociato un paio di volte dei furgoni mai visti prima che sfrecciavano sulle strade poderali. Bruciavano immondizia, copertoni, balle di tessuti, pellame. Quella roba aveva ormai iniziato a spuntare un po’ dappertutto, sotto le frasche, sui limiti poderali, ma pure in campo aperto. Nelle terre trovava immondizia ma non vedeva più contadini. Tra chi aveva venduto e chi lasciava incolto perché non ricavava più da vivere, a Bernardo sembrava di essere rimasto solo a coltivare. Pure i pecorari erano spariti, si diceva che un morbo strano stesse decimando le greggi. Dei tecnici con le tute bianche erano venuti a prelevare acqua dal suo pozzo per analizzarla, e uno di loro gli disse: «Ancora coltivate? qua è tutta diossina ò zì!». Lui volse lo sguardo e mugugnò qualcosa. Dopo poco, il Comune deliberò il divieto assoluto di emungimento dai pozzi. Che doveva fare, buttare la zappa? Alla fine continuò a tirare acqua dal pozzo artesiano pur di irrigare il mais e il tabacco.
Finché non arrivò la notizia che quasi gli fece venire un infarto. La lesse nel 2000 sul giornale: ad Acerra, in località Pantano, stava per sorgere una gigantesca industria per bruciare tutta la monnezza della Campania. A meno di un chilometro dal suo fondo. Cosa ci racconta la terra? Da quando l’agricoltura era stata assorbita nel mercato, e da quando il mercato s’era fatto globale, coltivare in Campania non rendeva più. Nessun progetto di largo respiro aveva accompagnato l’industrializzazione dell’agricoltura campana, privilegiandone la vocazione specifica nell’impatto con la modernità. Le monocolture dipendenti da costosi concimi e antiparassitari, il peso insostenibile degli intermediari, l’influenza della criminalità organizzata, sono solo alcune delle questioni mai affrontate e risolte nella piana campana. Alla svolta dei Novanta, la struttura produttiva dell’agricoltura locale non generava più ricchezza. Chi aveva avuto l’occasione di vendere i terreni alla zona di sviluppo industriale e alle imprese di costruzione alla fine c’aveva guadagnato.
Tra il 2001 e il 2003, Arpac, Asl, Sogin ed Enea effettuarono campionamenti dei terreni e delle acque nel territorio di Acerra, tutti riscontrando in diversi punti la presenza di discariche incontrollate e alte concentrazioni di contaminanti nel terreno e nelle falde. Anche la zona del Pantano, adiacente alla ex-fabbrica Montefibre, risultò contaminata, ma questa non venne ritenuta condizione sufficiente da istituzioni e investitori per provvedere all’opera di bonifica e spostare l’impianto altrove. C’era l’emergenza rifiuti, bisognava “fare presto”. I cittadini di Acerra riscoprirono di colpo di avere una campagna quando ormai era troppo tardi. Contadini, pastori, commercianti, disoccupati, partiti di destra e sinistra, tutto il paese guardava ora alla campagna mentre veniva espropriata campo dopo campo. Le grandi mobilitazioni, durate diverse anni, si scontrarono con tutto l’apparato dello stato, organizzato e duro, e Acerra perse la battaglia. Gli imprenditori dei rifiuti sfruttarono il caos per continuare i loro scarichi e arricchirsi con la compravendita di terre, per loro non c’era presidio del territorio in grado di fermarli.
La rete di favori, scambi e affari tra commissariato all’emergenza, imprenditori dei rifiuti e camorra si è stretta intorno alle terre di Acerra e degli altri paesi tra Napoli e Caserta, definitivamente. Ecco cosa ci dice la terra. Nel momento in cui la sua capacità produttiva agricola diventa irrilevante, sale nelle quotazioni il suo valore di scambio, scollegato da eventuali effetti di degradazione ambientale. Con un’imprenditoria nazionale affamata di smaltimento a basso costo, la transizione da economia agricola a economia della contaminazione trova la sua naturale espressione in Campania. Accumulare capitale esternalizzando le negatività sulle matrici ambientali diventa la strategia, legale e illegale, di sviluppo di un territorio. Ogni grammo d’inquinante smaltito è una scoria di ricchezza per qualcuno. Il surplus è creato esattamente nelle cellule malate di piante, animali e uomini, dove l’economia diventa biologia, e il cerchio dalla terra all’uomo si chiude ancora una volta.
Bernardo si era opposto all’inceneritore, aveva scovato gli inquinatori notturni, aveva persino provato a mettersi d’accordo con altri contadini per fare insieme una cooperativa e salvare terra e lavoro. Solo fallimenti, ormai era sfinito. Disprezzava i suoi paesani. Quando contadini e pastori vent’anni fa mettevano in guardia dagli scarichi della Montefibre nessuno gli aveva dato ascolto. La gente s’era cominciata a interessare solo quando il brutto male era entrato nelle case. E il risultato più grande di tutto quello sbraitare era stato solo che ora tutta la campagna di Acerra teneva la nomea di terra avvelenata e nessuno si voleva comprare le sue insalate, i suoi pomodori e il suo mais. Pensava, Bernardo, che forse doveva vendere pure lui. Ma per dio, non ai Pellini, a loro no. Piuttosto crepava di fame, pur di non far diventare il campo della sua famiglia una discarica. Ma a che valeva, se tutto intorno era già discarica? Mentre mangiava scarola, si fermò per osservare le foglie verdi e tenere, con timore. Lui l’aveva sempre saputo che con la fine dell’agricoltura sarebbe arrivata la fine di tutto il resto. Solo credeva che non sarebbe successo mai. E ora una domanda lo martellava, senza risposta. Che fare? (salvatore de rosa)
Il 29 marzo 2013, dopo sette anni di dibattimento e centodue udienze, il processo Carosello-Ultimo atto ha visto la sua conclusione a Napoli. A fronte di oltre quaranta imputati i condannati sono stati soltanto una decina; molte le prescrizioni, in altri casi il giudice ha stabilito che “il reato non sussiste”. (leggi l’articolo)



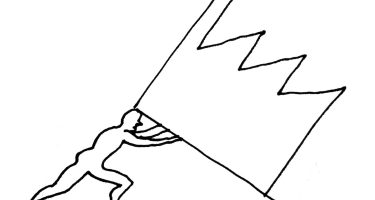

Leave a Reply