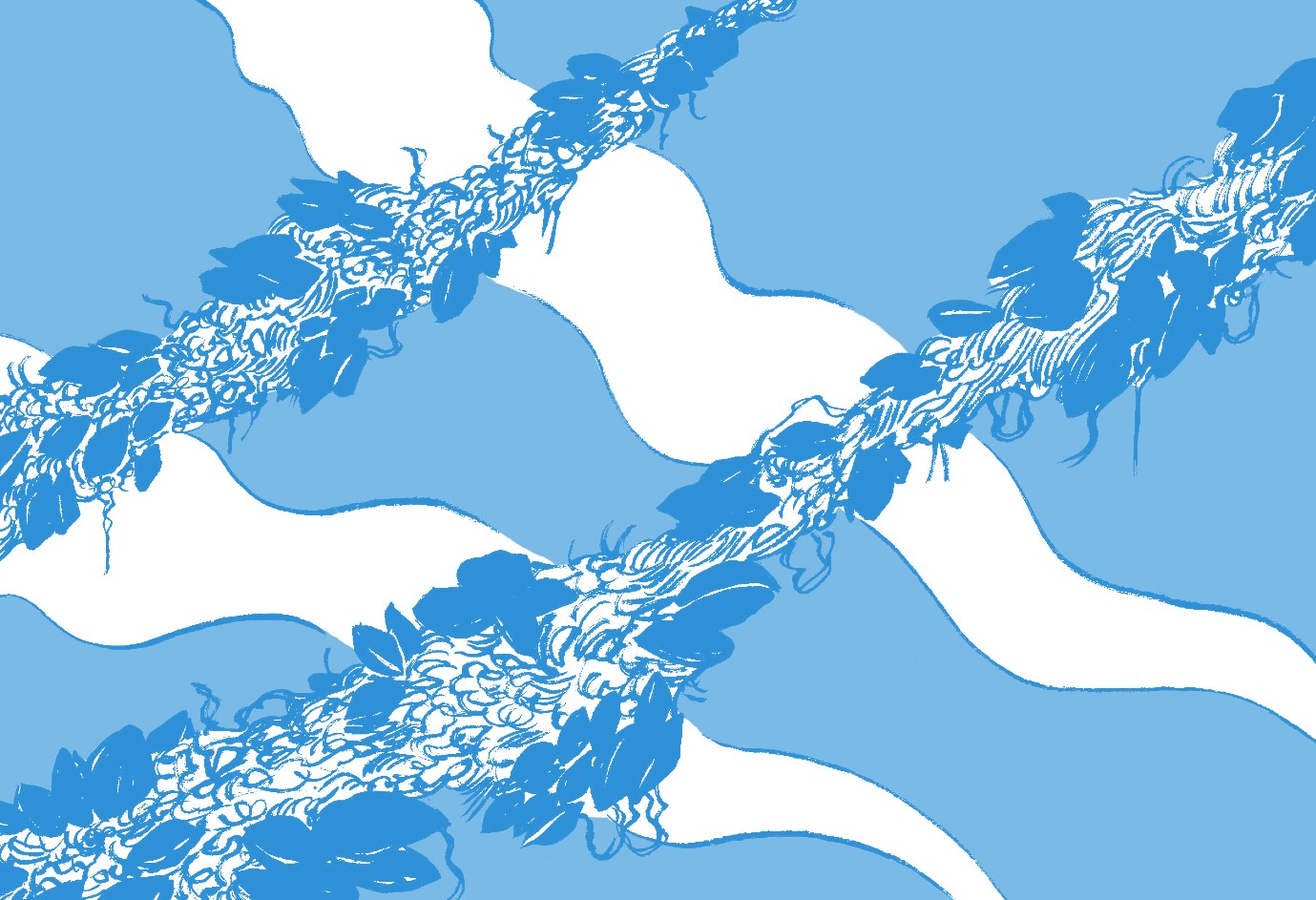
Nel discorso sul litorale di Pietrarsa, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, periferia est di Napoli, occorre innanzitutto distinguere tra l’inquinamento batterico e quello chimico-fisico.
Partiamo dai colibatteri¹. Il 23 aprile scorso Arpac afferma che i valori di escherichia coli ed enterococchi sono nella norma, ma non è la prima volta che accade. Anzi, l’ultimo sforamento registrato risale ad agosto 2022 per i primi e a settembre 2021 per i secondi: dopodiché, tutti i valori registrati restano entro i limiti legali fino a oggi. Quindi, da circa due anni, e non dal 23 aprile, il mare di Pietrarsa è “legalmente” balneabile.
Anche i valori registrati tra l’estate del 2015 e l’estate del 2017 rientravano, continuativamente, entro i limiti legali, ma negli anni immediatamente successivi numerosi e gravi sforamenti – fino a quattro volte oltre i limiti legali di escherichia coli e in un caso fino a dieci volte i limiti di enterococchi – si erano verificati nelle estati 2018, 2019, 2020 e 2021.
Insomma, i dati Arpac testimoniano del fatto che da dieci anni a questa parte a Pietrarsa la qualità delle acque è particolarmente precaria: a lunghi periodi di balneabilità “legalmente ammissibile” fanno da contraltare improvvisi picchi di inquinanti batterici.
Prima di analizzare questi dati, occorre ricordare come le comuni infezioni da escherichia coli ed enterococchi siano facilmente curabili, ma in casi più rari possano provocare setticemie, polmoniti, infezioni delle vie urinarie e persino meningiti.
Nel caso di Pietrarsa, le principali fonti di inquinamento pare siano individuabili in due scarichi, che si trovano uno a ridosso e l’altro ad alcune centinaia di metri dallo specchio di mare in questione. Si tratta, rispettivamente, degli scarichi dei collettori Sannicandro-Levante e Volla-Pollena. I due collettori dovrebbero raccogliere le sole acque pluviali, ma è noto agli ambientalisti (grazie alle indagini di Goletta Verde) e a molti residenti che negli anni siano stati realizzati allacci abusivi alla rete fognaria. Nei più recenti documenti comunali, questa possibilità non è neppure presa in considerazione. Tra l’altro, uno o più piccoli scarichi non classificati sono stati individuati anche nell’area ex Corradini, ma l’entità delle opere abusive è ovviamente ignota. Sarebbe necessario un intervento pubblico di ampia portata e il coordinamento coi comuni del vesuviano, qualora si volesse effettivamente razionalizzare la rete fognaria di un bacino di utenza che si attesta sui duecentomila abitanti.
Naturalmente bisogna anche tener conto delle maree, che dallo sbocco dei due collettori possono muovere gli inquinanti in una direzione o nell’altra, ma c’è un caso che sembra testimoniare in modo inequivocabile del possibile legame tra questi scarichi e la qualità delle acque a Pietrarsa. Nell’estate del 2018 si verificavano quattro gravi sforamenti di escherichia coli e due di enterococchi a Pietrarsa e l’unica causa rilevabile era la rottura di due condutture fognarie connesse ai collettori Levante e Volla. Il Comune, all’epoca guidato da de Magistris, si assumeva la responsabilità del guasto ma era tenuto a pagare una sanzione minima, di soli seimila euro, poiché negli anni precedenti, compresi tra il 2015 e il 2018, aveva fatto tutto il possibile per potenziare le stazioni di sollevamento e allontanare gli scarichi nocivi dagli sbocchi dei due collettori.
Il confronto tra questi eventi e i dati sopra citati testimonia non solo del possibile legame causale tra gli scarichi abusivi connessi ai collettori Volla e Levante e la qualità dell’acqua di Pietrarsa, ma anche dell’utilità della messa in opera di impianti di sollevamento che, dal 2020 a oggi, sono stati nuovamente promossi dal Comune per inviare i liquami del Volla e del Levante al depuratore di Napoli Est, situato in Zona Industriale. In ultima analisi, il completamento dei lavori garantirà certamente maggiori margini di controllo dei colibatteri, ma il richiamato censimento degli scarichi abusivi sembra essere una misura non più dilazionabile: il rischio è di essere eternamente schiavi delle incognite tecniche e degli incidenti. Al solito, mitigazione e prevenzione dei rischi sono pratiche che vanno integrate tra loro.
Prima di passare al discorso sugli inquinanti industriali, occorre ricordare che la normativa vigente e le metodologie di indagine impongono di concentrare l’attenzione sulla sola presenza di colibatteri. Qui c’è un’evidente contraddizione nella normativa, che proclama la necessità di eliminare tutti i rischi sanitari associati all’attività balneare. Inquinanti chimici, composti organici, idrocarburi policiclici aromatici, metalli e metalloidi possono, nel tempo, depositarsi nei fondali marini ed entrare in vario modo nella catena alimentare. Molto più complesso definire i rischi derivanti da un contatto diretto tra il nostro corpo e i sedimenti inquinati, perché bisognerebbe prima capire di che sostanze si tratta.
A Pietrarsa, si attende da un ventennio circa una nuova caratterizzazione degli inquinanti industriali, che comunque non è mai stata mirata. Nel 2004, una cooperativa di consulenza ambientale e la Stazione Zoologica di Napoli affermavano che tutto il litorale di San Giovanni fosse “in un evidente stato di degrado ambientale”, causa accentuati sforamenti nelle concentrazioni di cromo, mercurio, rame e idrocarburi policiclici aromatici². Poco dopo, il piano di caratterizzazione redatto dall’Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (Icram) testimoniava anche di sforamenti del parametro piombo³. Su queste basi, tra il 2006 e il 2009 si realizzavano le opere di bonifica degli arenili e dei fondali della ex Corradini e di Vigliena; a Pietrarsa, invece, nulla è stato fatto.
Dopodiché pare che l’intera questione dell’inquinamento industriale dei fondali del Sito di Interesse Nazionale di Napoli orientale sia passata sotto traccia. Nel Piano Regionale di Bonifica del 2012 non risultano attive stazioni Arpac di monitoraggio dei fondali, ai quali non è neppure attribuito un indice di rischio, cioè non sono inseriti nell’ordine di priorità da assegnare alle opere da eseguire. Nel Piano del 2018, invece, l’indice di rischio pare sia stato finalmente assegnato ai fondali di San Giovanni, ma le prime stime (forse ipotesi?) non fanno che confermare quanto detto nel 2004: ci sono metalli, metalloidi e idrocarburi policiclici aromatici nei fondali⁴. A largo, invece, le caratterizzazioni svolte dall’Autorità Portuale nel 2017 non hanno individuato particolari sforamenti⁵, ma si tratta pur sempre di dati solo indirettamente correlabili allo stato dei fondali di Pietrarsa.
Nel valutare l’urgenza di un intervento di monitoraggio, occorrerebbe forse ricordare la storia industriale dell’attuale Sito di Interesse Nazionale di Napoli orientale. Nello specchio acqueo di Pietrarsa hanno sicuramente scaricato, direttamente, le officine che fino agli anni Settanta hanno ospitato intense attività metalmeccaniche e solo successivamente sono state riconvertite in Museo Nazionale Ferroviario. Indirettamente, si può tener conto delle piccole e medie concerie, pelletterie, falegnamerie, dei fabbri e delle tintorie che in vario modo tappezzavano la costa da Sant’Erasmo fino alla foce del Sarno e che iniziavano a entrare in crisi proprio dalla prima regolamentazione nazionale degli scarichi idrici, la legge Merli del 1976, in poi. Ciononostante, una presenza significativa di queste attività è registrabile fino a ridosso della crisi del 2009. Infine, si può tener conto della filiera dell’agro-alimentare e della concia che insisteva nell’area interna e con ogni probabilità riversava i propri sottoprodotti nel “lagno”, poi nei due collettori Levante e Sannicandro.
I fattori di rischio potenziale sono, insomma, molto numerosi. Nel dubbio, per ora meglio evitare di tuffarsi nel mare di Pietrarsa. (valerio caruso)
______________________
¹ Si ringrazia Pietro Sabatino (politologo e dottore di ricerca in Sociologia dello sviluppo locale e regionale, membro dell’Osservatorio Condizione Giovanile in Campania e presidente dell’associazione Noi@Europe) per aver raccolto, elaborato ed avermi fornito i dati Arpac in serie storica. I dati sono liberamente accessibili presso: https://portale.arpacampania.it/archivio-storico
² Camera dei Deputati, Senato della Repubblica. XVI Legislatura, Disegni di Legge e relazioni. Documenti, Doc. XXIII n.14, Commissione Parlamentare d’Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, istituita con legge 6 febbraio 2009, n. 6. Relazione sulle bonifiche dei siti contaminati in Italia: i ritardi nell’attuazione degli interventi e i profili di illegalità, approvata dalla Commissione nella seduta del 12 dicembre 2012, pp. 106-11 e 133.
³ ISPRA, Seminario su “Siti contaminati: Caratterizzazione, Bonifica e Analisi di Rischio”, relazione di Davide Mosca (DEME Environmental Contractors) su Caso studio: la bonifica dei fondali di San Giovanni a Teduccio, SIN di Napoli Orientale, via isprambiente.gov.it
⁴ Regione Campania, Piano Regionale di Bonifica, aggiornamento di dicembre 2018, all. 2, p. 21.
⁵ AdSP del Mar Tirreno Centrale, Prolungamento e rafforzamento della diga Duca D’Aosta. Progetto definitivo, pp. 205.





Leave a Reply