
Prendo il treno da porta Nolana alle sei di mattina e alle sette e un quarto sono fuori al Cantiere. Giggino mi aspetta alla garitta. I guardiani esitano un attimo prima di farci entrare. Fino all’ultimo momento Giggino non sa se gli daranno il permesso, gli dicono di attendere. Poi arriva un uomo in giacca e cravatta che mi serra la mano e si presenta come il capo della sicurezza. Mi concede di entrare, raccomandandomi di non fare fotografie e di non muovermi dalla banchina. Giggino allora gli chiede il permesso di accompagnarmi. Lui sbuffa prima di esclamare: «Giggì tu tieni pure ‘sta faccia, ti riconoscono tutti». Neanche il tempo di terminare la frase che Giggino è al di qua della sbarra, e bestemmia al mio fianco, lungo il cammino che ci conduce di fronte alla nave sullo scalo. «Tieni mente, io qua ero il re. Ora per entrare devo cercare il permesso».
Siamo dentro al Cantiere. Anni passati a sentirne parlare e adesso vedo ciò che fino al giorno prima ho immaginato attraverso le storie che una schiera di operai mi hanno raccontato sul suo conto. Il peso dei trentacinque anni trascorsi da Giggino qua dentro lo percepisco non appena ci fermiamo davanti alle transenne. Oltre non possiamo andare, c’è una gru da duecento tonnellate che va avanti e indietro sui binari, accompagnata da una sirena che segnala il suo spostamento. “Stabia e basta”, c’è scritto sopra. Ci sono gli operai alle prese con le operazioni di varo. Mentre guarda la nave e le maestranze che si accalcano attorno alla chiglia, a un tratto comincia una lunga passerella di operai che si accorgono della presenza di Giggino, lo chiamano e s’avvicinano sorridenti. Altri urlano il suo nome da lontano, altri ancora da bordo. Chi s’avvicina porta i cornetti offerti dalla direzione, dicendo che sembrano di carta. In effetti, ne addento uno alla crema e mi fa schifo. Altri ci portano bottigliette d’acqua, perché siamo fermi sotto un sole cocente e non sono neanche le otto di mattina. Gli operai stringono la mano di Giggino, si prendono in giro a vicenda. «Schiarajuò che ci fai da quella parte? Vieni di qua, muoviti. Tuttapposto? L’hai vista a quella chiavica dell’ingegnere? Te lo ricordi? Eccolo là, guarda come si atteggia. Io lo chiamo Papa Francesco. Ma com’è possibile che quello deve comandare a me? Io da qua me ne devo andare, Giggì, non ce la faccio più. Qua se sei bravo vieni messo da parte». Giggino annuisce, risponde che sta bene e che si gode la pensione.
Mentre i vecchi e i giovani passano a salutarlo senza dare troppo nell’occhio, si sentono le urla d’incitazione delle maestranze alle prese con la battitura dei cunei. Hanno iniziato alle sei in punto la prima delle quattro battiture, a tempo, da un lato e dall’altro della chiglia. Luigi Scardulella si aggira intorno alla nave con il cannello sulla spalla, altri portano martelli enormi che servono a “sparare i bicchieri”, quelle zeppe che mantengono i puntelli incastrati tra la chiglia e lo scalo. Ogni bicchiere sparato, un boato euforico, un grido di esultanza. Gli operai dal lato di babordo prendono per il culo quelli che eseguono operazioni simili a dritta, attraverso il dedalo di puntelli, saettoni e taccate disseminate sotto la chiglia della nave. Non li vedo ma li sento. C’è chi se ne sta senza fare niente. Di quando in quando, la voce del direttore impartisce ordini dal palco predisposto per l’occasione. È il settore degli ospiti, con tanto di aria condizionata. «E noi qua sotto al sole. Ce li davano a noi i soldi, andavamo a mangiarceli!». I capireparto indossano tute color cachi. Poi ci sono quelli che indossano tute bianche, e sono ingegneri. Infine ci sono le tute blu degli operai diretti e quelle con i nomi delle ditte esterne. I caschetti antinfortunio sono personalizzati. Rosario ci ha scritto sopra uno dei suoi contronomi: “Cedro”. Un altro porta scritto: “Dio è amore”. Un altro ancora: “Gesù pensaci tu”.
Le sirene delle gru in manovra non smettono di suonare e ogni tanto si sentono rumori sordi come tonfi. È la nave. Più passa il tempo, più “si siede”. Le martellate si confondono tra le urla e i carrellini sbattuti sulle castagne. Grida sguaiate partono da poppa verso prua. Poco a poco lo scafo della nave si assesta. Una riga metrica in entrambi i lati misura: tre, quattro millimetri… la massa della nave scende lentamente. Quando la riga metrica indica lo spostamento in termini di centimetri, è evidente che la nave si è accomodata per bene e vuole scendere a mare. Ma fino a quando il direttore non grida alla Matrina di tagliare in nome di Dio, fino a quel momento preciso, devono accadere una serie di altre operazioni concatenate tra loro.
La nave Gauthier è stata commissionata da un armatore canadese e per questo si aggira per lo scalo una troupe televisiva del Quebec. Fa uno strano effetto vedere gli ingegneri canadesi in mezzo alle maestranze. Un operaio dice che la nave è lunga centotrentatre metri ed è un prototipo. Devo pisciare. A questo punto ci allontaniamo dalle transenne e incontriamo altri colleghi di vecchia data che salutano Giggino. Uno di questi c’invita a bere il caffè sotto al reparto degli elettricisti. Leggo le scritte dei nomi e i soprannomi sugli armadietti vicino al frigorifero. Esco fuori a girovagare. Alcuni operai pedalano con calma sulle biciclette. Mi trovo di fronte alla miniatura di una nave in una teca. È il Giovanni dalle bande nere. Poi osservo un quadro gigante che rappresenta un varo. Di fronte c’è la lapide che ricorda che dagli scali di questo Cantiere scendeva in mare il 22 febbraio 1931 l’Amerigo, “superba realizzazione, a riprova delle capacità e dell’ingegno dei figli di Stabia”.
Giggino mi raggiunge e insieme a Ciccio andiamo di nascosto sotto il reparto della sagomatura, poi sotto alla Navale, dove ha lavorato. C’è ancora il presepe, un calendario di donne nude, la scritta sul muro “Fiet e ciumm” e il poster di Gesù Cristo a fianco a quello di Che Guevara. Sul frigorifero qualcuno ha scritto: “Bar Caracas”. Usciamo fuori, verso un albero di fichi e una zona in stato d’abbandono. Giggino prende alcuni fichi dall’albero e li sbrana, sembra un bambino che ritorna nei luoghi del suo mondo perduto. Entriamo in mensa e ci sediamo al tavolo insieme ad altri operai. «Neh, banda di scornacchiati! Sono venuto a togliervi la polpetta da dentro al piatto», gli dice. Si ride con la bocca piena. Apriamo panini e ci meniamo dentro intere scatolette di tonno, addentiamo il capocollo, beviamo succhi di frutta e Seven up. Poi torniamo indietro.
Qui, dentro al Cantiere Navale tra i più antichi d’Europa, quando c’è da varare una nave le cose vanno ancora come al principio. Per la popolazione è come guardare la processione di San Catello, “patrono operaio”. I familiari e la gente comune iniziano ad accalcarsi sotto al sole, sulla banchina. Altri operai in cassa integrazione portano con sé i figli e si vantano con spontanea puerilità, mentre i figli pongono infinite domande e loro gli raccontano per sommi capi le ragioni che rendono diverse anche due navi uguali.
La nave sullo scalo è pronta e riusciamo a imboscarci sul palco per gli ospiti e le autorità. Ce l’ho di fronte, adesso. Sul bulbo di prua, quella sorta di palla sotto la linea di galleggiamento che serve ad attutire il beccheggio e ridurre l’attrito con il mare, il capo del montaggio scafo di turno ha attaccato le immagini sacre di San Catello, della Madonna di Pozzano, di Padre Pio, di Santa Maria di Portosalvo, protettrice dei marinai, e di San Francesco di Paola protettore di naviganti e pescatori. Le immagini formano due croci. Dentro al Cantiere gira voce che una volta non furono attaccate e il varo finì male, ma si tratta di una diceria. Ci sono stati incendi e vittime in corso d’opera, il prezzo da pagare al processo di produzione, ma mai un guaio grave, durante il varo.
Alzo la testa e vedo affacciati a proravia alcuni operai che restano a bordo. Ci sono centoventi operai a svolgere le operazioni di varo. C’è da guadagnarsi lo straordinario. Gli altri restano in cassa integrazione. Inizia la parte che tocca alle autorità, parlano i dirigenti, l’armatore, il sottosegretario alla difesa, un delegato sindacale. Si avvicendano uomini in giacca e cravatta al microfono. Quelli della compagnia armatoriale scattano selfie dai tablet e il sindaco prende la parola leggendo ciò che deve dire da uno smartphone. Gli armatori e i dirigenti si distinguono sul palco dai parenti delle maestranze per i loro vestiti impeccabili, perché parlano in italiano, e perché si pavoneggiano come se quella nave l’avessero costruita loro. Gli operai sono in piedi sullo scalo, sotto la palla di prua, di fronte a noi. Osservano la gente accalcata sul palco e ascoltano. Forse fingono di ascoltare. Tutti quei pizzi arrisi sembrano voler dire: «Sì, come no, certamente!». Il vero palco resta quello sul quale se ne stanno in piedi loro, in attesa del taglio in nome di Dio.
La nave è là. Un prete la battezza con l’acqua santa: «Oh Signore, benedici questa nave e tutti coloro che viaggiano con essa come ti sei degnato di benedire l’arca di Noè durante il diluvio…». Benedice e dice bene, il prete, mentre gli operai alzano tutti insieme le mani verso il cielo e recitano il Padrenostro. La sirena suona cinque volte, parte l’inno nazionale canadese, poi quello di Mameli, quando un ingegnere va a ispezionare sotto la chiglia per vedere se ci sono pezzi che possano impedire il corretto scivolo della nave dallo scalo. Nessun problema. L’ingegnere allora esce da là sotto, si avvicina a un quadretto e commuta un interruttore collegato a un altro quadretto sul palco, sul quale si accendono le due lampadine sotto le rispettive scritte: “Piano di varo libero destro”, “Piano di varo libero sinistro”. Il direttore prende atto dell’accensione delle lampadine, dopodiché alza un telefono magnetofonico e ordina: «Aprire valvole di sicurezza». Altri due tecnici commutano un interruttore che avvisa quelli di sopra che l’ordine è stato eseguito. Passano i minuti. Poi arrivano gli altri ordini del direttore. «Procedere al taglio delle taccate laterali».
Alcuni operai si allontanano dal gruppo e iniziano a menare martellate alle taccate ai rispettivi lati della carena, tagliano con il cannello e da lontano s’intravedono le scintille che divampano. La pressione all’improvviso aumenta: la nave vuole scendere. La tensione è visibile sui volti fetenti delle maestranze, le mani sporche di grasso, le tute tutte annerite. La gente sul palco osserva senza dire niente. C’è da aspettare il taglio in nome di Dio.
La Matrina è in attesa. Sembra una bomboniera dozzinale con quel suo vestito, sorride emozionata davanti agli obiettivi delle macchine fotografiche. Gli operai adesso appaiono tranquilli ma non vedono l’ora che finisca anche questa giornata di fatica. Scherzano tra loro, scambiano qualche battuta sulla bionda della troupe televisiva del Quebec. Manca poco alla fine dell’ennesimo varo dentro al Cantiere e nessuno sa se ce ne saranno altri. La prossima commessa è una serie di tronconi per una nave in gestazione nel cantiere di Monfalcone. Poca roba, si continuerà con la rotazione, il lavoro a singhiozzo, l’ozio forzato. Fincantieri ormai è quotata in borsa. Il direttore, dopo attimi di silenzio, pronuncia l’ordine alla Matrina di tagliare in nome di Dio. La Matrina taglia, la bottiglia s’infrange sulla parete della nave e partono i primi timidi applausi. Ho perso Giggino.
Adesso la nave scende accompagnata dall’ennesimo boato euforico, scivola placida come una piuma in un torrente, scorre davanti agli occhi alzati degli spettatori, la sirena suona lungo la sua discesa e la gente applaude con vigore. Quelli che assistono dalla banchina e dal palco apprezzano il rituale, ma quelli che si trovano a bordo un po’ si cacano sotto. La poppa è già a mare mentre la prora sta ancora sopra al legname, i mustacci si spezzano e ci si domanda impauriti che Madonna stia succedendo. Enormi cumuli di catene che scendono ai lati dello scalo frenano il suo scivolo. Sembra che si stia spaccando tutto e invece a un tratto la nave si ritrova a galleggiare sullo specchio di mare.
Ognuno vive a modo suo quell’attimo finale, più o meno simile a ciò che può provare un artigiano quando contempla un manufatto dopo averlo completato. Forse per qualcuno quell’attimo fa parte di una giornata di fatica straordinaria come tante. Oppure no, è tutt’altro. Sarà che ho un’ora di sonno alle spalle e la testa annebbiata per via del sole, ma mentre provo a guardarli in faccia uno a uno penso che così me l’immaginavo, che era come pensavo, che forse c’è anche una buona dose di rabbia, in quell’attimo. Un impeto irresistibile e beffardo, una forza implacabile che pressa come quell’ammasso di ferraglia sagomata sullo scalo. Tra le urla incontenibili, si manifesta nella sua semplice chiarezza quell’immagine, l’ultimo atto che nessuno, in tre anni di interviste, è mai riuscito a spiegarmi fino in fondo. Gli operai la salutano esultando con le braccia aperte nell’aria e lanciando i guanti sporchi di fatica verso la palla di prora in movimento. Alcuni si abbracciano, si stringono le mani, urlano, si scambiano gli auguri come all’ultimo dell’anno e si baciano complimentandosi l’un l’altro. Altri rincorrono la nave per qualche metro come se volessero essere al suo posto. Alla fine di tutto, tra i loro stessi applausi, c’è chi abbassa la testa, porta le mani davanti agli occhi, e mentre cerca di nasconderli si mette a piangere veramente. (andrea bottalico)


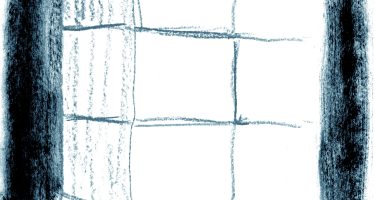


Leave a Reply