
da La Repubblica Napoli, 17 novembre 2012
In un film di recente e purtroppo breve passaggio nei cinema napoletani, “L’intervallo”, del regista Leonardo Di Costanzo, ci sono due adolescenti, maschio e femmina, rinchiusi in un grande edificio abbandonato. L’azione si svolge tutta in una giornata estiva, dall’alba alla sera. La ragazza è stata segregata lì dal boss della zona, la sua colpa è di essersi innamorata di un affiliato a un gruppo rivale. Il ragazzino, che fa l’ambulante come il padre, è stato a sua volta quasi sequestrato dai malavitosi per affidargli il compito di sorvegliare la ragazza. Nell’attesa del “chiarimento” finale, i due trascorrono il tempo insieme, passando dalla diffidenza iniziale a una pudica, sincera quanto fugace confidenza, destinata a svanire a fine giornata, quando alla ragazza non resta altra scelta che piegarsi alle velate minacce del boss.
Di Costanzo, al suo primo film di finzione dopo tanti bei documentari, afferma di aver fatto un film sulla sopraffazione, senza un riferimento preciso alla sua Napoli. E se è vero che, come ogni film riuscito, “L’intervallo” rimanda a una condizione universale, slegata da riferimenti geografici, è però innegabile che i suoi protagonisti, i loro volti, le parole smozzicate, gli sguardi strafottenti o sensuali, l’instabilità emotiva che trasmettono, sono gli stessi che intercettiamo ogni giorno per le strade della nostra città. Non è un caso che le opere più importanti maturate a Napoli in questi anni ruotino intorno agli adolescenti, alla loro profonda solitudine, agli spazi di autonomia che essi riescono a ritagliarsi e ai rari momenti di comunicazione con un mondo adulto sempre più distante. Ognuno a suo modo, “Insegnare al principe di Danimarca”, il libro postumo che raccoglie le riflessioni dell’educatrice Carla Melazzini sulla periferia orientale di Napoli, e il film “L’amore buio” di Antonio Capuano, percorrono il cammino dall’iniziale ostilità, dal conflitto anche drammatico, all’apparenza irriducibile, fino all’apertura di un dialogo, in uno spazio segreto, protetto da sguardi indiscreti, dove i giovani provano a essere finalmente se stessi uscendo dal ruolo che altri gli hanno assegnato.
In questi giorni si discute tanto di scuola, di insegnanti, di educazione, ma quasi sempre le condizioni di vita di questi ragazzi restano sullo sfondo. Nel settembre scorso il sottosegretario Rossi-Doria ha annunciato lo stanziamento di cento milioni per due anni con l’obiettivo di contrastare la dispersione scolastica in quattro regioni del sud. Il dibattito in corso non va oltre l’entità delle cifre e il modo della loro erogazione. C’è chi sostiene che sia più opportuno individuare ambiti ristretti e intermediari già sperimentati piuttosto che disperdere le risorse, come si dice, “a pioggia”, tra tanti territori con esigenze e composizioni sociali differenti; altri fanno notare che interventi del genere lasciano comunque da parte una percentuale di giovani che non rientreranno nei parametri, di esclusi tra gli esclusi; e si domandano: chi si occuperà di loro?
C’è un rischio, soprattutto, che i responsabili del ministero non possono ignorare. Questa misura potrà forse dare una boccata d’ossigeno alle organizzazioni di intervento sociale che annaspano tra crediti non esigibili dagli enti locali, tagli del governo centrale e degrado delle condizioni di vita e di lavoro degli operatori. Ma chi stanzia i soldi non può consentire che anche a questo giro le azioni previste non vengano monitorate scrupolosamente in corso d’opera, e che i risultati, sia parziali che finali, non siano sottoposti a una verifica stringente che non può essere basata solo sui parametri standardizzati stabiliti in questi casi.
Negli anni passati i finanziamenti – delle istituzioni nazionali ed europee – sono stati copiosi, ma non hanno prodotto il cambiamento sperato, lasciando in rari casi una traccia positiva nelle vite dei destinatari. Certo, molto di rado gli amministratori locali sono stati in grado di fornire un supporto affidabile e infrastrutture adeguate a queste politiche, ma la mancanza di controlli e verifiche hanno fatto in modo che anche le poche esperienze virtuose venissero considerate alla pari di quelle superflue o inefficaci. E così ogni volta si ricomincia da zero. Per questo è necessario controllare che il modo in cui verranno usati i soldi stavolta sia strettamente legato alle esigenze di emancipazione di ragazzi e ragazze, alla necessità di instaurare relazioni che durino nel tempo e di cui sia ragionevole immaginare dei frutti, privilegiando gli ambiti dove maggiore è il bisogno ma anche la corrispondenza ai loro desideri e capacità.
Qui non è in gioco solo la dispersione scolastica ma la loro vita per intero, i luoghi in cui vivono, le persone che incontrano, le piccole opportunità che è possibile offrirgli in un contesto sempre meno accogliente. Un obiettivo del genere non chiama in causa solo il governo, le scuole o le organizzazioni del sociale, ma anche gli enti locali e tutti noi adulti che attraversiamo la città. Di un’altra spruzzata di euro sulle teste di questi ragazzi, a maggior gloria di chi l’ha decisa e come misura di contenimento del disagio economico di chi lavora nel settore, non c’è davvero alcun bisogno. In molti quartieri i legami sociali – tra giovani e adulti, tra padri e figli, tra poveri e ricchi – sono allo stremo, e anzi con sempre più frequenza si vanno rompendo, come in una reazione a catena, lasciando spazio alla violenza contro gli altri e contro se stessi. Con il loro silenzio, con incerte parole che in pochi si sforzano di sollecitare, i ragazzi e le ragazze cercano una sponda sicura per uscire dalla loro muta sfiducia. Ed è inevitabile che, se non comincia a cambiare la città intorno a loro, questa afasia e questa distanza non potranno che crescere. (luca rossomando)



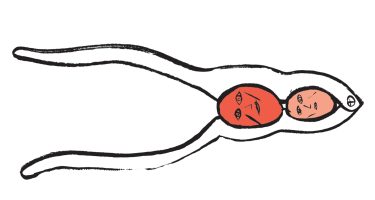
Leave a Reply