
Raccontare i mestieri del mare. Intervista a Marcello Anselmo, autore de La Zantraglia. I mestieri del mare al tempo dei container, Mesogea, 2012.
La Zantraglia è un libro costruito su un registro narrativo misto, inchiesta, finzione, reportage. Perchè questa scelta “mista” e come ci sei arrivato?
La ricerca su cui si basa il libro è iniziata lavorando a un documentario radiofonico per RaiRadio3 realizzato intervistando decine di lavoratori marittimi originari delle zone di tradizione marinara della Campania (Procida, Ischia, Monte di Procida, Torre del Greco, Ercolano) e di altre regioni (Genova). Al principio quindi, la narrazione è stata costruita tessendo insieme le parole degli altri, con brevissimi interventi “autoriali”. Erano storie di lavoro, di mestiere ma anche di vita, una sorta di immaginario diversificato tenuto insieme dallo spazio acqueo del mare, dall’avventura, dalla solitudine e dalla meraviglia che si attraversano durante gli imbarchi e le esperienze con cui si viene a contatto. In seguito ho continuato a documentarmi cercando riscontri documentali, letteratura e altri spazi di ricerca e narrativi che avessero indagato il mondo del lavoro marittimo. Si tratta dunque di un insieme di registri narrativi che mi fornivano suggestioni e piste estremamente diversificate che non riuscivo, al principio, a gestire in maniera coerente, o meglio a raccontarli attraverso un unico taglio, stile. La finzione – che poi è consistita nel definire un io narrante – si è resa necessaria nel momento in cui oltre ai racconti e alla documentazione si è aggiunta l’esperienza diretta del lavoro portuale e degli imbarchi sui cargo. Nel momento in cui ho potuto attraversare – come osservatore certo, ma privilegiato data la possibilità che ho avuto di vivere in prima persona le vicissitudini che accompagnano il lavoro marittimo e portuale – i diversi contesti (il porto, la nave) mi sono reso conto che la possibilità narrativa era quella di provare a tenere insieme le diverse sfaccettature attraverso, appunto, una scrittura che provasse a declinare i diversi punti di vista: la descrizione, gli odori, i suoni, la storia in un unico metissage narrativo.
Tu racconti dei “mestieranti del mare”, dagli scaricatori ai marinai, nel farlo descrivi una zona grigia che si inserisce come sottofondo in una economia globale delle merci e degli scambi. Che relazione c’è tra questi due mondi che racconti?
Il mare, come ha scritto il saggista statunitense William Langewiesche, è l’ultimo spazio anarchico e senza regole durevoli che ci è rimasto ai tempi della scienza, della tecnica e, aggiungo io, del container. Per cui chi lo attraversa è spinto, in prima istanza, da motivazioni di carattere lavorativo più che personali. Per quanto riguarda i marinai (e gli ufficiali) si tratta anche di una conseguenza di tradizione territoriale o familiare. Poi una volta al largo e con il passare del tempo quel mestiere diventa anche il luogo dell’avventura, della ricerca dentro sé dai tratti imprevedibili. Per quanto riguarda i portuali invece, negli ultimi trent’anni si è assistita a una profonda trasformazione della professione. Da subalterne bestie da soma i portuali sono diventati operai della catena logistica integrata. Sono diminuiti drasticamente di numero e hanno alzato il loro tasso di formazione e “automazione” nel senso che oggi lavorano manovrando macchine e dispositivi tecnici giganteschi. Nel paesaggio portuale l’uomo è diventato una piccola figura sullo sfondo. Ecco, è la posizione individuale che poi incastra i lavoratori nelle maglie di un’economia che non può che essere grigia, quella del trasporto di merci invisibili perché occultate da scatole colorate. Il controllo delle condizioni di lavoro così come dei traffici viene effettuato “a campione” e quindi ogni verifica risulta essere fallace. I turni cambiano a seconda della posizione geografica del porto o della bandiera battente. Probabilmente quello dei mestieri del mare (nelle sue molteplici declinazioni) è il settore in cui la trasformazione del lavoro e il suo definitivo derubricarsi in merce assume i tratti più marcati dell’effetto della globalizzazione economica. Il mare è un esercizio di irrobustimento dello spirito e del corpo, il luogo in cui l’uomo, a suo modo, resiste alla macchina sapendo di poter solo perdere.
Marco D’Eramo, che ha scritto che il tuo è “un libro che non solo si fa leggere, ma si fa anche ricordare”, ha osservato che il Mediterraneo e i suoi porti sono inezie rispetto ai giganti asiatici. Che ne pensi, davvero il Mediterraneo è un piccolo giardino da cui osservare il mondo?
L’osservazione, a mio modo di vedere, soffre di un approccio macroscopico al tema. È certamente vero che le quantità di Teu (misura di volume dei container, ndr) movimentate negli spazi oceanici sono di gran lunga più significative di quelle che avvengono nel Mediterraneo. Tuttavia la Zantraglia è un libro che ha voluto indagare e provare a descrivere degli ambienti prima umani e poi economici, e da un altro punto di vista gli effetti della grande trasformazione del trasporto delle merci situata in contesti che hanno, per così dire, digerito il cambiamento declinandolo in dimensioni diverse. Ho provato a raccontare aspetti microscopici (e in alcuni casi microfisici) della containerizzazione in quel territorio (il Mediterraneo) che nonostante tutto continua a essere uno snodo centrale per l’economia mondiale. Si può dire che è un tassello di una ricerca ancora in itinere, e che si propone di andare oltre i dati, le statistiche e gli aspetti macroeconomici per soffermarsi sull’insieme dei dispositivi di trasformazione che aggrediscono le configurazioni storiche collettive e individuali in contesti situati. Raccontare, in altre parole, la vita che soggiace al meccanismo della logistica integrata. Quell’elemento sfuggente che poi, altro non è, che il lavoro e la vita umana. Riaffermare il primato umano sulla razionalità tecnico-economica. (dario stefano dell’aquila)



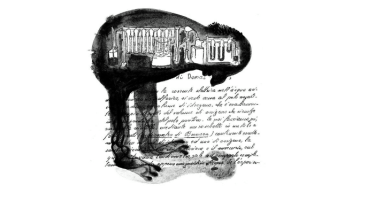

Leave a Reply