“Arriva a Milano in treno, a notte fonda, alla piccola stazione ferroviaria della Bullona. Le grandi stazioni sono ormai sotto il controllo dell’esercito sanitario a caccia di tracce del morbo. Accanto ai militari, la polizia esamina i documenti dei viaggianti e multa chi non è conforme al regolamento sanitario. Per chi non può pagare, l’unica strada è quella che conduce a una cella infetta. Sono autorizzati ad attraversare le grandi stazioni solo i facchini, i membri del direttorio sanitario, i funzionari con permesso speciale, gli autisti delle linee pneumatiche. Per i contrabbandieri del mercato nero, gli insegnanti clandestini, le prostitute e i cuochi sotto copertura restano le stazioni minori: San Cristoforo, Lambrate, Bullona, le uniche rimaste dopo la Grande Risistemazione. Lui scende sulla banchina tra scheletri di palazzi, resti di una chiesa, un discodromo abbandonato da anni e vecchi laboratori di artigiani ora abitati da invisibili. Da lì cammina fino ad arrivare al cuore del quartiere cinese, di solito brulicante di attività. Dorme in un sottoscala umido, ospite di Y., che lo nasconde tra pile di cartone. Al risveglio trova il quartiere serrato: l’epidemia sembra aver decimato la popolazione” (Dagli Appunti per un soggetto, A. B. Casarsa, undicesimo foglio, 12 gennaio 1977).
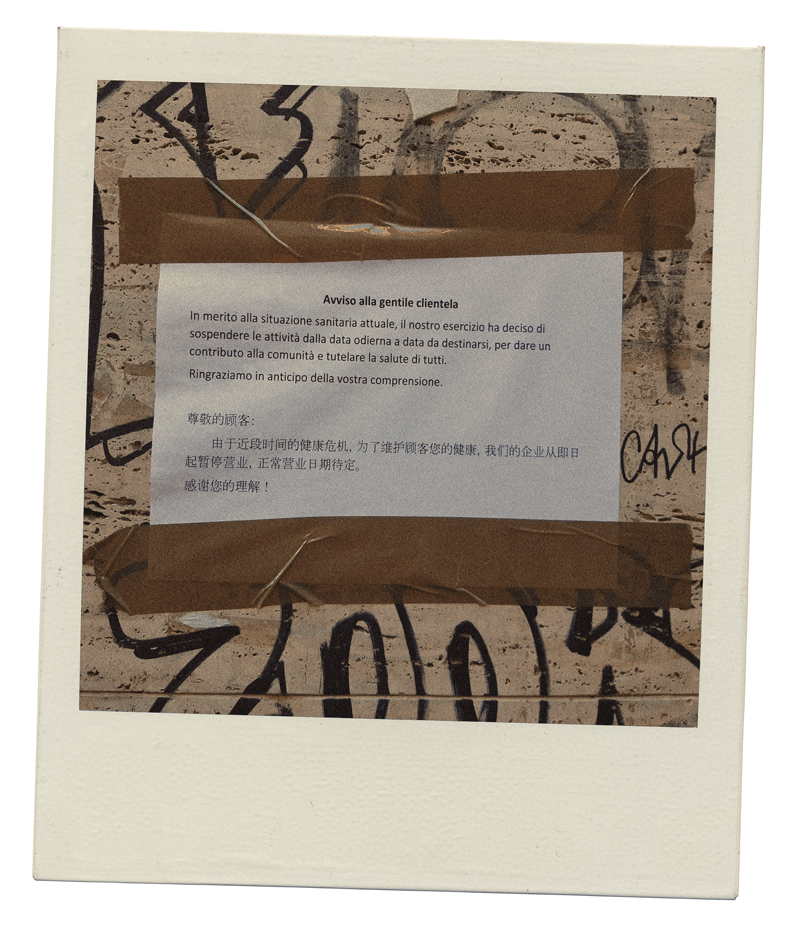
Nel diario di Borgese, assistente di regia, leggiamo che Casarsa “era rimasto fortemente impressionato dai fatti di Seveso”. Ritroviamo una ricostruzione degli avvenimenti accaduti pochi mesi prima a venti chilometri da Milano nel testo di una studiosa, scritto anni dopo: “Sabato 10 luglio 1976, a mezzogiorno e mezzo, da un reattore dell’Icmesa destinato alla produzione di triclorofenolo si sprigionò, a seguito di una reazione incontrollata, una nube di diossina, un veleno che, per quanto ne sapeva allora la scienza, avrebbe potuto produrre effetti catastrofici, non solo distruggendo vite umane, ma rendendo di fatto inabitabile, forse per anni, il territorio su cui si era depositata” (L. Centemeri, Ritorno a Seveso, 2006). Secondo Casarsa l’epidemia degli anni Venti avrebbe dovuto lasciare gli edifici intatti, la vegetazione rigogliosa, i giochi dei bambini al loro posto, ma ogni luogo sarebbe stato svuotato, disabitato, privato del senso che nasce dall’uso. Borgese scrive anche che “Casarsa vuole mostrare le scuole vuote, senza suoni, per far comprendere la portata della tragedia. Per girare la scena della scuola chiusa, trasformata in centro di raccolta dati, abbiamo dovuto lottare con genitori e insegnanti che ci accusavano di ledere il diritto allo studio dei ragazzi. Per un pomeriggio!”.
“Lui non fa che pensare a lei. L’aria pesante di Milano colpita dall’epidemia lo sfianca, ancor più che la distanza. Non riesce a prestare attenzione a Y., mentre gli confida con voce flebile quel che si dice sulla comunità cinese di via Canonica. Sarebbero accusati di aver portato l’epidemia dall’Oriente con i loro traffici di pelli, tessuti e cibo venduto a poco prezzo. Da lì il morbo si sarebbe propagato al resto d’Italia. Ma a Lui non importa nulla dell’origine di questo male né delle dicerie dei milanesi o della sofferenza di Y. Vuole solo trovare il modo per andare verso sud, verso di Lei. Il soggiorno a Milano si fa sempre più insopportabile per i controlli delle forze dell’ordine sanitario. Ogni strada è pattugliata e le uniche presenze tollerate sono quelle dei clienti dei plurimercati, che attraversano lo spazio aperto con le loro buste gialle. Infine, con l’aiuto di Y., trova il modo di partire, in bicicletta, coperto da una mantella nera e annunciato dal suono di campanacci.
Solo così, incarnando la figura del matto, è inafferrabile per chi ormai si è assuefatto alle nuove norme sociosanitarie. E raggiunge la libertà, da poeta”. Dopo di lui, il diluvio. (Appunti per un soggetto, quattordicesimo foglio, 30 marzo 1977)
(note a cura dell’Assembramento di Ricerca Cinematografica)





Leave a Reply