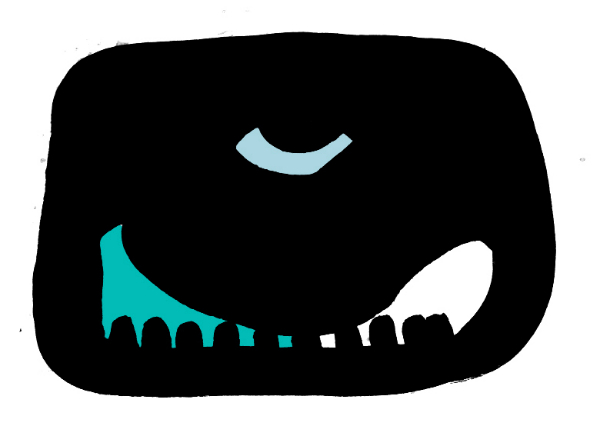
da Napoli Monitor n. 52 – Gennaio/Febbraio 2013
Il 16 marzo del 1978, mentre in Italia le Br rapiscono Moro, sulla costa bretone si consuma uno dei maggiori disastri ambientali della storia. Una petroliera americana si spacca in due riversando in mare tonnellate di greggio. A bordo quel giorno c’era un ufficiale procidano.
Sono nato a Procida. E come tutti i ragazzi procidani ho frequentato l’unica scuola che c’è: l’istituto nautico. Ancora oggi quasi tutti fanno quella scuola. Si diplomano a giugno e a settembre sono già imbarcati. Quando ho iniziato io prendevo un milione di lire. A terra, un operaio o un impiegato ne guadagnavano duecentocinquantamila. L’industria marittima ha dato il benessere a tutta l’isola, ma l’ha anche corrotta. Gli uomini sono sempre per mare, a Procida sono le donne che amministrano la casa. Anche perché dispongono di un patrimonio ingente: un comandante di lungo corso guadagna tra gli otto e i diecimila euro al mese. Mi ricordo le litigate tra mio padre e mia madre… Ogni volta che mio padre tornava, mia mamma gli faceva trovare un’appendice della casa in più, un salotto, un’altra camera da letto. Aveva la mania di espandersi.
Sono stato quasi in tutto il mondo, in Giappone, in Cina, in Arabia, in America, nei Caraibi… La gente dice: “Azz’! Ti sei girato il mondo”, ma io invece non ho visto niente. Il mio primo imbarco è stata una cosa particolare: ero in un equipaggio che doveva portare una superpetroliera appena costruita da Tokio verso il Golfo Persico. All’epoca non avevo mai viaggiato, il mio mondo era Procida. Fare Roma-Tokio, diciotto ore di volo a diciannove anni, e tutti quegli scali: Istanbul, Carachi… Comunque non fu un brutto impatto, la cosa che ci salva, a noi comunità di mare, è il fatto che ti ritrovi sempre con qualche paesano. Io ero allievo ufficiale, poi ho fatto degli esami, il patentino e sono diventato terzo, secondo, primo…
La mia prima nave era immensa: era lunga trecento metri. Tutt’intorno al ponte aveva una pista ciclabile e noi, per fare i controlli giornalieri, dovevamo usare delle biciclette. Da Tokio iniziammo a fare i classici viaggi delle petroliere: si va a caricare nel Golfo Persico, per esempio a Dubai, generalmente si attracca in questi pontili sgangherati all’estremità di una piccola isola (e nel Golfo Persico è pieno di isolette come Procida, ma nessuno lo sa, o almeno, io non lo sapevo) oppure nelle banchine surriscaldate in zone desertiche, e questo quando ti va bene, quando vedi la terra. Altrimenti, stesso al largo, c’è una pompa sottomarina che carica o svuota le stive. Noi rimaniamo in alto mare. Anche perché quando si va a terra non si trova altro che raffinerie o enormi pipeline. Il problema è che le nostre navi hanno un pescaggio pesante: non c’è bisogno di dragare un fondale quando puoi portare il carico al largo. Risparmi.
Ho navigato con equipaggi in cui erano tutti italiani, altri erano misti. Alla fine degli anni Settanta eravamo noi italiani a navigare per gli americani, eravamo un po’ come i filippini, gli indiani e gli ucraini che oggi troviamo sulle navi italiane.
A bordo dell’Amoco Cadiz eravamo tutti italiani, la bandiera era americana. Amoco è una società petrolifera americana. Avevamo un carico per la Shell, perché spesso i viaggi li fai come nave noleggiata da un’altra azienda: “Vammi a prendere quel carico e portamelo qui…”. Ecco, noleggiano nave e uomini. Caricammo nel Golfo Persico, in un’isola che si chiama Kish, e ci facemmo tutta la traversata risalendo l’Africa, le Canarie, il golfo di Biscaglia fino al canale della Manica. Ci impiegammo quarantacinque giorni.
In quegli anni il canale di Suez era chiuso per via delle tensioni tra Egitto e Israele, ma comunque una nave come la nostra – duecentocinquantamila tonnellate, classificata: Very-Large Crude Carriers (VLCC) – era immensa, non aveva le dimensioni per passare per Suez. Quindi dovevamo per forza circumnavigare l’Africa. Sull’Amoco Cadiz ero terzo ufficiale per la seconda volta in vita mia. A ventiquattro anni avevo una grossa responsabilità. Preparavo la rotta e la tracciavo sulle carte marine, dovevo trovare la via più breve per arrivare a destinazione. Un’altra cosa che gestivo erano i farmaci, come tutti i terzi ufficiali. Gli altri mi consideravano un medico, ma io improvvisavo: davo pillole per l’influenza, pillole per dormire, per digerire… Che ne sapevo io? Nulla.
Quella mattina del 16 marzo del 1978 eravamo all’ingresso della Manica. Il canale, sulle carte nautiche è diviso in due parti, come se fosse una strada con due corsie: una che sale e una che scende. In quel tratto c’è un traffico di navi incredibile, vanno e vengono come in un’autostrada e noi stavamo proprio nel mezzo, e all’improvviso si ruppe il timone.
Come ce ne accorgemmo? Innanzitutto perché quando navighi per simili tratti di mare non inserisci il pilota automatico. La nostra nave, che stava nella corsia di salita, impazzì e invase la corsia di quelli che stavano scendendo. La pala del timone principale si era messa di traverso e non ne voleva sapere di muoversi, così iniziammo a sbandare paurosamente. Sfiorammo almeno un paio di navi, tanto da vicino che riuscivamo a vedere gli occhi terrorizzati di chi stava in plancia. Allora iniziammo a suonare la sirena come dei pazzi, era l’unico modo per avvertire le navi in transito della nostra emergenza. Intanto si era alzato il mare e tirava un vento da nord che aumentava la nostra instabilità.
Quelli che lavorano in macchina, nella pancia della nave, quando si accorgono che qualcosa non va, si sentono come topi in gabbia, per cui sono i primi a controllare che tutto funzioni al meglio. Quella mattina erano stati i primi a capire che il timone era andato… Alle 9:30 del mattino, già dopo un po’ che andavamo alla deriva, mandammo SOS e tutte le navi presero a scansarci. Nel frattempo i meccanici si affannavano a smontare pannelli per arrivare all’albero del timone. Ci volle poco per capire che non c’era niente da fare, si erano rotti dei tubicini di pompaggio dell’olio che non erano più riparabili. Il timone funziona grazie alla pressione dell’olio nel sistema idraulico, senza più pressione alimentata da questi tubicini la nave non era più governabile.
Il comandante di una nave ha tutta la responsabilità di quanto accade a bordo, in porto come durante la navigazione, ma quando bisogna prendere decisioni in cui si deve spendere del denaro, il comandante deve rispettare quello che dice l’armatore o la compagnia che ti ha noleggiato per quel viaggio. Dove ci trovavamo noi, l’unica soluzione era di chiamare un rimorchiatore d’altura, quelli grossi, capaci di manovrare in mare aperto, e farci trainare nel porto più vicino – per noi era Le Havre – a riparare il guasto. Il capitano comunicò alla compagnia che la nave non era più governabile e chiese l’intervento di un rimorchiatore d’altura. Eravamo quasi tutti in plancia, c’era una tensione incredibile perché vedevi il mare ingrossarsi, la pioggia che batteva sui vetri e tutte quelle navi che passavano riuscendo a evitarci… Dopo la prima telefonata alla compagnia rimasta senza risposta, il comandante iniziò a chiamare di continuo. Non lontano da noi, all’improvviso comparve la sagoma di un rimorchiatore. Solo che noi ci muovevamo e non era facile raggiungerci in tutto quel traffico. Una volta che il rimorchiatore fu vicino ci mettemmo in comunicazione con il loro comandante: “Guarda, dacci una mano, intervieni…”. Lui non rispondeva, ci mandava a dire se andava bene il suo prezzo.
Poi il nostro comandante iniziò a contrattare con il responsabile della compagnia che doveva autorizzare la spesa del noleggio del rimorchiatore. E quello tirava sul prezzo, il rimorchiatore non mollava di un dollaro… Questa negoziazione andò avanti per quella che a me sembrò un’infinità: il rimorchiatore arrivò in zona verso mezzogiorno e fino alle diciotto non si era sbloccato niente. E noi alla deriva. Il rimorchiatore si era avvicinato, era lì, qualcuno di noi addirittura gridava: “Lancia la cima! Dacci il cavo…”, ma quello ci girava intorno e diceva: “Se non mi dite quanto mi date non vi porto a terra”.
Il rimorchiatore non interveniva perché quello che gli voleva dare la compagnia per lui era niente rispetto a quello che avrebbe ottenuto in una situazione di pericolo – e noi tecnicamente la mattina non eravamo ancora in piena emergenza perché rimanevamo al largo, lontano dalla costa. Così il rimorchiatore aspettava che noi ci avvicinassimo sempre più agli scogli fino a quando sarebbe dovuto intervenire per forza e fare un salvataggio ben retribuito. Avevano calcolato tutto ma sottovalutato il pericolo.
Era una situazione inverosimile. Vedevamo la Ile Verte, un minuscolo arcipelago di scogli del mar celtico, di fronte al paese di Portsal, che si avvicinava sempre più minacciosamente. E pensavamo: “Ma questo è così un caino che non ci dà la cima?”. Quando praticamente eravamo arrivati tra gli scogli dal rimorchiatore dissero: “Adesso interveniamo, siete in pericolo e ci dovete dare tot…”. Ma il comandante non poteva assumersi la responsabilità di accettare, e si mise a richiamare la compagnia. Altrimenti poi la compagnia avrebbe potuto rivalersi su di lui. Intanto, durante questa diatriba, arrivammo in un punto che costrinse il nostro comandante a dire alla compagnia: “Guarda che se questi non ci prendono tra poco affondiamo e ci areniamo sugli scogli”. Alle 21 la compagnia autorizzò l’intervento e dal rimorchiatore iniziarono a tirarci i cavi. Intorno c’era buio, pioggia, vento e scogli. Eravamo in mezzo a queste piccole isole a pelo d’acqua. Io avevo il compito di dare il “punto nave”, cioè comunicare l’esatta posizione e la distanza da terra grazie all’ausilio del radar. È stata un’angoscia che non ho mai più avuto in tutta la mia vita: “Siamo a un miglio, mezzo miglio, duecento metri, stiamo per andare a fondo…”, ero io che dicevo a tutti questo genere di cose.
Tutti guardavano me, io guardavo loro… Il cavo ce lo lanciarono a un miglio dagli scogli, lo agganciammo, lui iniziò a tirare ma la Cadiz non ne voleva sapere di fermarsi. Il rimorchiatore mise i motori al massimo, intorno era come se il mare ribollisse dalla schiuma che produceva lo sforzo delle sue eliche, ma l’effetto fu quello di spezzare il cavo. Quindi il dramma… Tutti erano in lacrime… Sono momenti che non si possono più cancellare… Dopo la rottura del cavo, in meno di dieci minuti finimmo sugli scogli. È come essere al centro di un terremoto, ma dura molto di più… Vibrazioni fortissime per alcuni minuti, poi la nave si spezzò in due.
Quando il ponte si frantumò iniziò a fuoriuscire il gas. E che è questo gas? Noi avevamo cinque cisterne, e queste funzionavano come dei serbatoi normali. Così quando si spezzò la nave tutto il metano che si era formato tra il petrolio e il tappo cominciò a uscire, a spandersi intorno a noi, che infatti iniziammo a sentirci male… È stata l’unica volta in vita mia che mi sono cacato addosso, sul serio, fu un moto naturale. Ho veramente capito perché in una situazione di pericolo si dice: “Ma ti sei cacato addosso?”. Perché sai che stai per morire… In plancia ci furono persone che uscirono proprio di testa, ma nonostante tutto nessuno accese una sigaretta, perché altrimenti saremmo esplosi. Un botto e via… C’era quest’odore penetrante di gas e poi iniziò a uscire il petrolio. Ci furono degli spruzzi improvvisi di greggio dalle stive. Noi, che a quel punto eravamo usciti all’esterno, ci ritrovammo coperti di greggio. Oramai eravamo tutti e quarantaquattro in coperta perché l’acqua entrava senza freni nel locale macchine. La plancia è il punto più alto della nave e noi vedevamo il ponte scendere sempre più sott’acqua: quaranta, venti, dieci metri… Poi per fortuna la nave si adagiò sugli scogli e si fermò. Così non andammo a fondo ma restammo lì in mezzo alla tempesta.
Alcuni volevano mettere le scialuppe a mare, altri dicevano di no perché il mare era così in burrasca che sarebbe stata la fine. L’unica possibilità che avevamo era di rimanere in plancia e aspettare la buona sorte. Non c’era più elettricità né radio, l’unica cosa che riuscimmo a fare fu lanciare l’ultimo SOS. Intanto il rimorchiatore era lì a vista, e infatti vide tutto. Anche i suoi luridi soldi diventare una massa scura che si disperdeva in mare.
Dopo qualche ora, verso mezzanotte, arrivò un grande elicottero della marina francese e ci calarono una cima con l’imbracatura e iniziarono a tirarci su uno alla volta. Appena lo vedemmo iniziò tutta una storia incredibile a chi doveva essere preso per primo. Io fui il terz’ultimo, il comandante invece rimase a bordo fino all’indomani. L’elicottero fece due viaggi. Ci fu una specie di calca fatta da quelle persone più fragili che volevano salire subito. Comunque quando arrivò il mio turno, mi misi quest’imbracatura e iniziarono a tirarmi su a un’altezza incredibile. Man mano che salivo e nonostante il buio, vedevo l’intera scena sotto di me e capii che c’era andata fin troppo bene.
L’elicottero ci portò a terra e ci misero in una specie di ospedale, poi ci portarono in un albergo. La mattina dopo l’albergo era circondato dagli abitanti che ci volevano linciare. La marea nera aveva impiegato poche ore a riversarsi sulla costa. Erano incazzati neri e volevano prendersela con noi. Siamo rimasti in Francia per due mesi per via dell’inchiesta. Alla fine è stato condannato il comandante del rimorchiatore per omissione di soccorso… Io non sono mai più salito su una nave e, chiaramente, ho trovato un modo diverso di guadagnarmi il pane. (-ma)





Leave a Reply