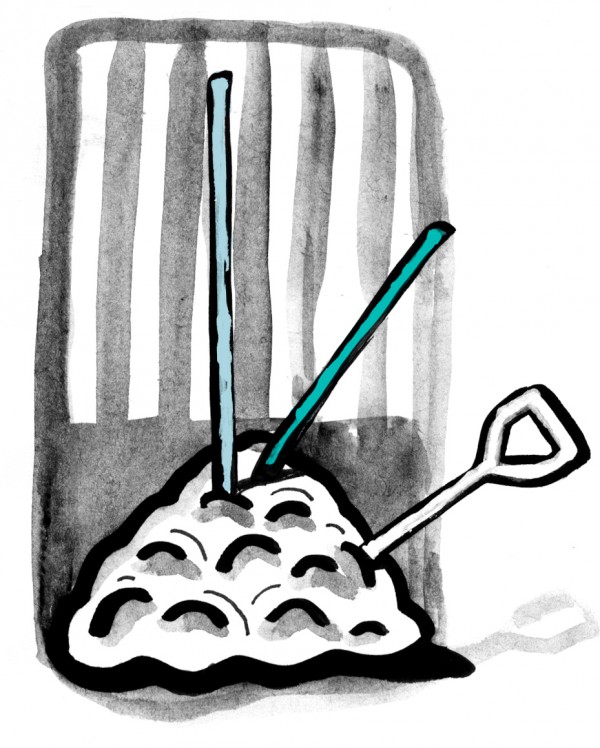
Un giovane uomo viene arrestato, preso in consegna da un altro corpo di polizia (penitenziaria), portato in un tribunale, visitato da un medico e poi portato in un ospedale dove incontra altri medici e infermieri. Quest’uomo ha attraversato i luoghi dove si dovrebbero dare cura e giustizia e invece ha trovato lividi e violenza, ha incontrato la morte. Ma prima ancora di chiedersi chi ha ucciso Stefano dovremmo chiederci: cosa l’ha ucciso? L’ha ucciso il carcere con le sue regole di violenza non scritte, con le tecniche diffuse di botte e intimidazioni, con l’opacità dei luoghi di transito e la palude delle celle lisce? L’ha ucciso l’ospedale, dove sei un numero come tanti in una sala d’attesa? E parliamo di un caso eccezionale o di un episodio frequente, tanto da poter essere considerato normalità?
Chiunque conosce le istituzioni totali di questo paese sa bene che, al di là delle patine dei discorsi ufficiali e dei giochi cerimoniali, sono luoghi dove si determina una vera e propria economia dei diritti sospesi. Luoghi dove domina la materialità dei rapporti di forza, l’arbitrio dei singoli, l’impunità e l’impermeabilità dei corpi di polizia, dove manca anche formalmente ogni previsione di tutela reale. L’assenza di una fattispecie del reato di tortura ha forse il solo merito di rendere manifesta la natura violenta delle carceri, ma anche degli ospedali, dei reparti psichiatrici. Lo smantellamento di ogni forma di welfare ha proceduto di pari passo a un mandato politico e culturale che il carcere ha ricevuto in questi anni. Quello di essere un luogo in cui nascondere e contenere una vasta area di disagio sociale alla quale non si possono o non si vogliono dare risposte.
E in questo senso lo sforzo compiuto dall’allora ministro Giovanardi (e poi riutilizzato più volte nel corso del processo) di etichettare Stefano Cucchi come tossicodipendente mostra in maniera lampante come è lontana dal vero la frase “la legge è uguale per tutti”. Come la tutela dei diritti, nella pratica quotidiana, si infrange di fronte alla stigma. Prima ancora di accertare i fatti bisogna mettere in piedi una teoria che dimostri l’inferiorità della vittima, che giustifichi ogni violazione dei tuoi diritti. Così come a un paziente psichiatrico, in quanto matto, si possono applicare per ore le fascette di contenzione, così per un “tossico” si possono applicare procedure particolari (per esempio l’isolamento o l’astinenza in bianco). Basta un’ etichetta di diversità (immigrato, straniero, gay, trans, tossico, matto) da comprare al mercato dei luoghi comuni e il gioco è fatto. E del resto sperare che chi è più vulnerabile da libero, nella società, sia più tutelato, da recluso, in un carcere, richiede un atto di fede più che di fiducia. Se non è calato il silenzio su questa morte lo si deve solo alla forza e alla dignità di una famiglia. Ma sono centinaia i casi di violenze (che grazie al cielo non necessariamente portano alla morte) consumati nel buio di un reparto detentivo che non hanno mai trovato nemmeno lo spazio del racconto.
Questo non vuol dire che bisogna smettere di lottare di chiedere riforme, l’introduzione del reato di tortura, i numeri di identificazione degli agenti, l’introduzione di protocolli di intervento, di sostenere ogni forma di difesa e tutela dei diritti, di richiedere la modifica del codice Rocco. Significa che dobbiamo avere la consapevolezza che non è una lotta che si da una volta per tutte, ma che si deve combattere ogni giorno, al di fuori delle aule dei tribunali, nella società. Una lotta politica contro lo stigma e contro le politiche di reclusione sociale, contro la miseria e l’abbandono.
La sentenza di mercoledì lascia amarezza e dolore, ma ci costringe ad alzare la testa anche con gli occhi pieni di lacrime. Perché se vogliamo impedire che Stefano Cucchi venga ucciso ancora, se vogliamo impedire che ci siano altri casi come questo, non dobbiamo smettere mai di guardare e di cercare giustizia ogni giorno. (dario stefano dell’aquila)





Leave a Reply