
A colloquio con Leonardo Di Costanzo, in occasione del suo ultimo documentario, Cadenza d’inganno, storia di un adolescente napoletano che rifiuta il ruolo di protagonista border line. Metodo di lavoro, idee e retroterra di uno dei migliori documentaristi italiani
L’ultimo documentario di Leonardo Di Costanzo si chiama Cadenza d’inganno. È stato presentato il mese scorso al festival di Nyon in Svizzera. Qualche giorno dopo, nella sede di Napoli Monitor, ai Quartieri Spagnoli, c’è stata la prima proiezione napoletana.
Il protagonista del film è un dodicenne di Montesanto, Antonio, che vive in un basso, va male a scuola e passa felicemente il suo tempo per strada, salvo alcuni pomeriggi che trascorre in casa di una ragazza più grande, una studentessa che dovrebbe aiutarlo a fare i compiti ma spesso finisce per farsi coinvolgere nei suoi giochi e nel suo girovagare. A un certo punto Antonio si ribella al meccanismo del documentario e rifiuta di farsi seguire dalla telecamera, non vuole più essere filmato. Il regista è costretto a interrompere il lavoro. Lo riprenderà solo dieci anni più tardi, ovvero l’anno scorso, quando lo stesso Antonio lo inviterà a filmare il suo matrimonio, consegnandogli in questo modo un degno finale per il suo documentario.
Come in un suo film di qualche anno fa, che si chiamava A scuola, Di Costanzo rende evidente attraverso poche sequenze il fallimento della scuola dell’obbligo con i ragazzi come Antonio, ma stavolta lascia trasparire anche la possibilità di un incontro tra mondi diversi, quello di Antonio e della ragazza, fuori dagli schemi dell’educatore di professione e del giovane da redimere; ma soprattutto riconosce il diritto e la concreta possibilità di scegliere, e quindi anche di sottrarsi, a chi viene relegato nel ruolo del bisognoso, del marginale e, dal punto di vista cinematografico, dell’oggetto da filmare. Sarà Antonio, infatti, a decidere come e quando si concluderà il film, di cui in fin dei conti è il protagonista.
Con Leonardo Di Costanzo ci eravamo incontrati circa un anno fa, in occasione di un ciclo di conferenze nella vecchia redazione di Monitor, nella Sanità. Il regista aveva raccontato ai presenti il suo modo di lavorare, la genesi di alcuni suoi documentari e il retroterra delle sue idee.
«Mi sono formato come regista a metà degli anni Ottanta in Francia frequentando gli Atelier Varan, una scuola-laboratorio di cui facevano parte registi, cameramen, tecnici del suono, produttori e montatori. La scuola nacque all’epoca in cui i portoghesi lasciarono il Mozambico. Il responsabile culturale dell’ambasciata di Francia invitò allora dei registi francesi – Godard, Rouche, ma anche un brasiliano, Guerra – a filmare la trasformazione del paese che usciva dalla colonizzazione. Guerra non ci andò mai. Godard andò per una settimana e non fece niente. Rouche ebbe un’idea. “Invece di andare a filmarli, disse, insegnamogli le regole che sono alla base del cinema; portiamo le telecamere – allora c’era il superotto –, facciamo corsi di formazione per i giovani, e che siano loro a raccontare la trasformazione del paese in cui vivono”. L’esperienza andò bene, uscirono dei film interessanti, girati in un periodo di tempo ampio, sei sette mesi, con la supervisione dei francesi che ogni tanto andavano lì. Esperienze successive furono fatte nelle miniere in Bolivia, in Sudafrica durante l’apartheid. Insomma, finora sono stati fatti laboratori in una cinquantina di paesi. Il metodo non è cambiato. Si arriva con i macchinari, si insegnano i rudimenti del cinema e si aiuta la gente del posto a costruire un film, però il film lo fanno loro, e i materiali alla fine si lasciano là. Nel frattempo è nato un centro a Parigi dove passano i ragazzi di questi paesi. Io ci entrai per caso, perché il ministero degli affari esteri dava i soldi solo per i paesi in via di sviluppo. Avevano pagato per un camerunense che poi non andò. Così feci i due corsi che c’erano allora, nell’87 e nell’88, e sei anni dopo sono entrato come insegnante.
«Una delle idee cardine di questo modo di fare documentari è che per fare cinema non c’è bisogno di anni e anni di studio, nè di mezzi e conoscenze tecniche enormi. Fino ad allora il cinema si immaginava come una grossa macchina, ci volevano soldi, macchinari e chissà quali conoscenze, ma loro arrivarono a una tale essenzialità di mezzi che si poteva fare cinema veramente con poco. Per dire, nel primo corso che ho fatto, l’asta che seriviva per reggere il microfono era una mazza di scopa. Era tutto fabbricato in casa. A quel tempo anche per la televisione si spostavano sette persone, uno che portava il piede, uno la lampada, uno il microfono, un altro andava a prendere il caffe, uno diceva solo azione… Questa idea di cinema si incontrò a un certo punto con quello che stava succedendo nel mercato, con l’invenzione delle telecamera leggera, ovvero la camera video che cominciarono a usare le famiglie alla fine degli anni Ottanta, con la quale tutti possono fabbricare immagini a un costo relativamente basso. Questo provocò un’accelerazione enorme nella trasformazione del linguaggio cinematografico, che di fatto realizzava l’idea di “cinema diretto” nata negli anni Cinquanta.
«Nel ‘93 ho cominciato a insegnare negli atelier Varan. Il corso dura sempre tre mesi, divisi in una fase di preparazione, riprese e montaggio. Però bisogna adeguarsi al posto in cui si va. Io sono andato a Tbilisi, per esempio, che era il serbatoio cinematografico dell’Unione Sovietica; oppure a Belgrado dove c’era la quarta cinemateca piu grande del mondo, tu dicevi una parola e i ragazzi ti citavano tutti i film in cui era stata pronunciata… Spesso il problema con gli allievi è di togliere questa patina polverosa che circonda il documentario. Fargli vedere che esistono documentari che nulla hanno a che vedere con la propaganda, con l’ideologia. In Cambogia o in Vietnam, per esempio, dove c’è ancora la censura, il documentario è lo strumento privilegiato della propaganda e se tu gli dici: prendi la telecamera e vai a intervistare le persone, loro hanno paura perché le persone non si possono intervistare in questi regimi, allora bisogna lavorare molto con loro e con le spie infiltrate nel corso… Mi è capitato in Cambogia, ma le abbiamo cacciate.
«Ho fatto un corso anche a Marsiglia, un posto meno esotico, più vicino a noi. Lì la cosa interessante era la varietà degli allievi. C’era un critico cinematografico del posto, una donna che aveva visto migliaia di film, insieme a due ragazzi da poco usciti di prigione che appena accendevano la telecamera accadeva qualcosa, mentre questa donna non riusciva a mettere un’immagine dietro l’altra che avesse un senso. Questi avevano un istinto immediato nel relazionarsi all’altro, nell’inquadrarlo, un istinto che poi va educato naturalmente… Noi diamo indicazioni, ma ognuno deve trovare la sua modalità di racconto. Cerchiamo di distruggere i riflessi immediati di chi è cresciuto con la tv, quel modo di fare inquadrature, di mettere il corpo all’interno del quadro; diamo esercizi che rompono questi automatismi. Lavoriamo sulle immagini non facciamo teoria, partíamo dal desiderio di chi filma, non dalle categorie di documentario che esistono.
«Quando ho cominciato a fare film su Napoli, i registi della mia generazione o anche quelli prima di me non volevano piu filmare la città. Napoli è stata molto filmata, e ogni volta che la filmi quella si mette in posa, piange a comando, come se avesse capito cosa buca lo schermo. Il problema quindi è come rompere questo meccanismo. In Prove di Stato, un documentario sull’azione dell’allora sindaco di Ercolano Luisa Bossa, mi sono detto che non potevo fare interviste, sarei partito battuto, questi ormai hanno capito come rispondere e ti dicono quello che ti fa piacere sentire e tu fai da megafono per qualcosa che non controlli e che in generale serve a nascondere la verità. Allora se voglio avvicinarmi alla verità devo evitare l’intervista e filmare le persone in confronto tra loro, però deve esserci una posta in gioco, per cui la presenza della telecamera diventa secondaria rispetto al conflitto tra i due personaggi. Per esempio, la signora senza casa che va dal sindaco per convincerla a dargli una casa e il sindaco che cerca di spiegargli che può averla se ha i punti necessari per l’assegnazione… Filmare le persone in conflitto: con questo sistema ho fatto due film. Ho cominciato a lavorarci con Prove di stato e l’ho perfezionato in A scuola.
«Io volevo fare l’insegnante, non ci sono riuscito, ho fatto un po’ di supplenze poi ho smesso, e avevo sempre questa idea di voler raccontare la scuola. Un giorno ho chiamato una preside di cui mi aveva parlato un’amica, la preside della scuola media Cortese a San Giovanni a Teduccio. La mia intenzione era di filmare gli insegnanti. Sono andato a parlare con loro, ma mi sono accorto che quello che mi raccontavano del loro lavoro non lo riscontravo nella realtà. Mi sembrava tutto falso. Allora mi sono ricordato di quello che avevo fatto a Ercolano e ho deciso di filmare in contrasto, in conflitto. Nei romanzi il personaggio, l’eroe, si definisce attraverso il superamento di alcune prove. Ho pensato che per descrivere un insegnante dovevo mettergli davanti uno studente, e in particolare uno studente che ha dei problemi, che non ha voglia di studiare. Ho scelto dei ragazzi di questa scuola, poi ho parlato con gli insegnanti. Una parte non voleva essere filmata, una parte ha accettato. Ho detto loro che avrei mostrato il lavoro man mano che andavo avanti, ma non assicuravo che se mi avessero chiesto di togliere qualcosa l’avrei tolta. Quando ho fatto la proiezione del film finito, per loro è stata dura perché nel film non vedono riflessa l’immagine che hanno di se stessi ma nessuno mi ha accusato di averli spiati o di essere stato morboso. Nel montaggio ho tolto le scene piu violente, le punte estreme. Volevo fare un film sui limiti della scuola pubblica in generale e quindi ho tolto tutto quello che caratterizzava l’ambiente come napoletano, i riferimenti alla camorra, le scenate, le mazzate. Il film ha girato molto in Europa. All’inizio dicevano: come siete messi male a Napoli, poi lo vedevano le insegnanti delle periferia di Amsterdam o di Parigi e dicevano guardate che da noi è la stessa cosa.
«Nel film ci sono dei genitori redarguiti dalla preside. Io quei genitori li avevo già visti prima nei consigli di classe, gli avevo mandato una lettera tramite la preside per chiedere il permesso di filmare i loro figli. Non so se sapessero esattamente quello che stavo facendo, ma filmare in fondo è un atto di responsabilità, tu stai rubando qualcosa a qualcuno, dipende dalla tua onestà. Per esempio, c’è una scena dove una madre è ricevuta dalla preside. È una scena terribile, io l’ho pulita molto, la donna è sotto calmanti, a un certo punto sono proprio uscito, la parte dei suoi problemi personali non c’è, tra lei e la preside si parla solo del bambino. Spesso le preoccupazioni etiche nasconodono una non volontà di assumersi responsabilità. Filmare è un atto anche violento, tu ti appropri dell’immagine di un altro. Io, per esempio, ho grossi problemi a filmare il nemico, la persona che non stimo, a cui non voglio bene: filmare un razzista, non so come fare; per filmare qualcuno bisogna entrarci in relazione e in qualche modo volergli bene, questa persona ti deve parlare prima di parlare alla telecamera; filmare il nemico per amore di oggettività, per sentire anche la campana dell’altro, non riesco a farlo. Si è discusso molto su questo, Lanzmann ci ha fatto nove ore di film sui nazisti, un film che racconta la Shoa… Sono stati fatti dei tentativi nella storia del documentario ed è meglio andarseli a vedere se si vuole fare qualcosa del genere».
Dopo aver visto Cadenza d’inganno abbiamo posto a Di Costanzo ancora qualche domanda su questo film. A cominciare dalla genesi piuttosto travagliata.
«L’idea quando ho cominciato a girare, dieci anni fa, era di raccontare l’adolescenza a Napoli; cercare di capire una mentalità in formazione, per questo non c’era l’idea di una trama ma solo quella di accompagnarli durante la giornata. Abbiamo visto decine di ragazzi e ragazze a Montesanto. La cosa che funzionava con Antonio era il fatto che lui rispondeva a domande con altre domande. Fin dall’inizio ha rifiutato il ruolo del personaggio che si fa modellare, non stava lì a dire va bene devo fare il ragazzo difficile e lo faccio. Ci faceva penare, non veniva agli appuntamenti oppure veniva di cattiva voglia, per certi versi era molto seduttivo, si negava, ma la scommessa era proprio questa: è posssibile fare un film con un personaggio che si nega? Che cosa dice questa storia, che cosa racconta? A un certo punto avevamo pensato a delle proposte di scene, non delle vere e proprie finzioni, c’erano dei dialoghi e poi si improvvisava. Questo, credo, lo fece scappare, perché lo avvertì come un tentativo di incasellarlo in un ruolo. Scomparve da un giorno all’altro. Il film si interruppe. Il produttore francese, Richard Copans, ci aveva investito dei soldi e ogni tanto mi diceva che dovevamo finire il film, e io dicevo sì, ma poi non avevo voglia di andare a cercare Antonio per filmarlo cinque o sei anni dopo, perché a me interessava fare un film sull’adolescenza. Di Antonio mi dicevano che lavorava nei bar di notte nella zona di piazza del Gesù ma non l’ho mai incontrato. Poi un giorno mi arriva questa telefonata, ci diamo appuntamento per un caffè, che ha voluto pagare lui per rimarcare che era diventato grande; mi ha chiesto del film, mi ha detto che si stava per sposare. “Ma ti serve qualcuno che ti fa il video del matrimonio”, gli ho detto. “No ce l’ho già, quindi se vieni è per te, per finire il tuo film”, fece lui. Io avevo imparato a diffidare, ma mi faceva piacere, gli ho fatto un regalo, sono andato al matrimonio, ma più come invitato, non avevo nemmeno interesse per il film… Poi ho cominciato a pensare al senso di questa richiesta e mi sembrava molto coerente con il progetto originario di non voler imbrigliare un personaggio in una storia, ma soprattutto era divertente che fosse lui a decidere che la storia dovesse finire in quel modo. A Napoli la gente è molto propensa a farsi filmare adeguandosi al desiderio di chi ha di fronte. Antonio di questa cosa se ne fotteva. Io per lui ero come gli altri adulti che in qualche modo volevano incasellarlo. Questa per me è stata una grande scuola. Spesso noi registi cerchiamo di far quadrare tutto, prendiamo un personaggio e ci mettiamo a raccontare la nostra storia, questo ci rassicura, ci dà la sensazione illusoria che il mondo abbia un ordine… Il produttore mi ha detto che la scena del matrimonio che chiude il film è una scena triste se paragonata alla vivacità di Antonio da ragazzino; ma secondo me questa è ancora una volta una proiezione nostra. È la scelta che ha fatto lui. Magari lui è felice. Non sta a noi di giudicare, sono fatti suoi». (luca rossomando)


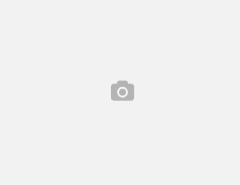


Leave a Reply