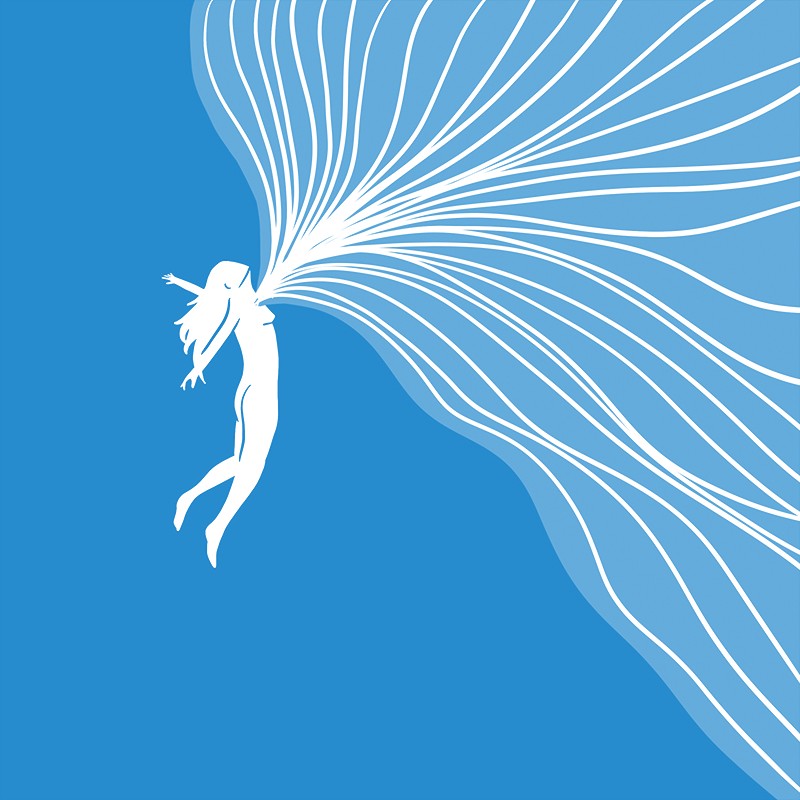
Claudia Brignone è una documentarista napoletana formatasi in quei circuiti che sono i soli a Napoli a offrire una reale esperienza per capire cosa significhi “farsi un film”, cioè per imparare facendo. La sua attenzione è sempre stata per il racconto di piccoli gruppi in relazione a grandi temi o grandi spazi (La malattia del desiderio, 2014, sull’esperienza di un Sert; La Villa, 2019, che esplora l’uso da parte dei giovani della villa comunale di Scampia). Di prossima uscita, e per quanto possa circolare un documentario in Italia, è il suo nuovo lavoro dal titolo Tempo di attesa che si concentra sul tema della maternità. Lo fa con uno sguardo dal basso, raccontando l’esperienza di preparazione al parto di alcuni gruppi di mamme guidati da Teresa de Pascale, un’ostetrica molto nota a Napoli, che rappresenta una di quelle funzioni più anarchiche e di cura che, agli occhi di un esperto, caratterizzano questa città.
Tempo di attesa è un percorso emotivo che ruota intorno alla figura di Teresa come catalizzatore di esperienze di maternità molto diverse tra loro e includendo anche i maschi, anche se non sempre questi ci sono o sono d’accordo. Il film è uno spaccato su particolari universi femminili alle prese con il miracolo della nascita, con le ansie e le paure ataviche che lo caratterizzano e che trovano in Teresa un approccio profondo e materno. Si tratta di una corrente, o se vogliamo tradizione, che ha solide radici nel nostro paese (dalla Montessori a Grazie Fresco fino al movimento femminista più anarchico) malgrado lo strapotere delle altre forme più istituzionali. Tempo di attesa è una testimonianza che si offre attraverso la figura di Teresa, temporanea madre delle madri in gestazione, ma che si dipana nell’ambito di quella sorellanza, civile e politica, con cui le donne mettono insieme i saperi a partire dalla fisiologia e dalla gestazione come base di una cultura centrale per l’esistenza umana.
Segnalare questo bel film ci sembra un modo per riportare il senso della parola “mamma” a una sua forma concreta e rivoluzionaria, come del resto è la nascita o meglio il dare alla vita. Riproponiamo così l’intervista a Teresa realizzata da Carola Pagani e pubblicata in Napoli a piena voce, un libro collettivo di Monitor del 2012. Viene in mente che una festa della mamma sarebbe più giusto definirla “festa della madre” non solo per ricordarne più chiaramente le motivazioni ma anche per assonare questo termine a quello della natura e delle sue meraviglie. (maurizio braucci)
* * *
Mia madre era morta quando avevo dodici anni, poi era morto pure mio padre quando ne avevo ventuno. Io lavoravo e decisi di andare a vivere con questo fidanzato che veniva dalla società bene di Napoli. Questo fu un grave errore. Era subito dopo il ’68, si pensava di poter fare tutto, soprattutto mi sentivo forte perché lavoravo, guadagnavo, mi facevo bastare poco… però, insomma, una famiglia bene che fa un figlio medico spera di fare un matrimonio adeguato. Avemmo l’ostilità di tutti i suoi parenti. Diciamo che facemmo un po’ parlare. Per fortuna avevamo un giro di persone intorno, di amici, non eravamo isolati, non avevamo il peso del giudizio… insomma, non avevamo proprio a che fare con la società bene. Però quindici giorni prima del matrimonio decisi di non sposarmi più perché mi sembrava di andare a infilarmi nella tana del lupo. Pensai che potessimo convivere senza sposarci, ma non funzionò. Io non avevo genitori a cui dover rendere conto, invece per lui era difficile far accettare questo alla famiglia. Il rapporto finì dopo un po’, andò in crisi soprattutto dopo questo matrimonio imminente, già organizzato, che non si realizzò.
A ventitre anni non mi sentivo capace di fare la caposala in un reparto di pediatria appena aperto, quindi andai al Gaslini di Genova per tre mesi, il mio mese di ferie più due mesi dati da loro, e vidi come si organizzava un reparto del genere. Allora queste cose erano possibili. Riprodussi la struttura di un reparto del Gaslini e la cosa funzionò. Facevamo incontri a ogni cambio di turno, quindi tutte le infermiere sapevano quello che succedeva in tutte le stanze. Ogni riunione durava un quarto d’ora. Era una prassi indispensabile perché il personale era giovane, anche il personale medico. Oggi questo non si fa, a stento si scrive qualcosa o si dà qualche ordine.
Al Policlinico c’era ancora tanto spazio, c’erano i prati e così decidemmo di fare l’asilo del personale organizzando dei turni. Diventammo un gruppo che aveva uniformità di comportamento. Allora, per esempio, le mamme si tenevano fuori dal reparto, non potevano essere ricoverate con i bimbi; e noi dovevamo sorvegliarle, queste mamme che cercavano di entrare; dovevamo cacciarle, una cosa tristissima. Così facemmo una lettera alla direzione sanitaria, firmata da tutto il personale, dicendo che per noi le mamme erano terapeutiche per i bimbi e che non le avremmo più tenute fuori. Loro potevano decidere come volevano, pero noi non le avremmo più cacciate. Avevamo dei bimbi lungodegenti, qualcuno abbandonato dalla maternità, così a volte prima di essere destinati da qualche parte stavano anche sei, otto mesi con noi, e la domenica li portavamo fuori insieme alle mamme che venivano, al sole nei prati, perché altrimenti erano bimbi che non sarebbero mai usciti. Dopo alcuni mesi se ne accorse il direttore: “Ma chi se la piglia questa responsabilità?”. E chi se la piglia. Noi ce la pigliamo! Era proprio l’opposto di adesso, dove sembra che per responsabilità si intenda qualcosa di male.
Erano anni belli. Poi, però, proprio lavorando in pediatria, capii che non erano né i farmaci né la struttura sanitaria che guarivano i bimbi, anzi. Nel frattempo le malattie stavano diventando croniche, aumentavano i tumori. Erano i primi anni Ottanta. Mi ricordo questi bimbi belli, floridi, che venivano con le diagnosi per accertare la leucemia e dopo due mesi di trattamenti erano depressi, svuotati. Erano dolorose le terapie e poi i farmaci li debilitavano e siccome molti venivano dalle campagne c’era un bel contrasto da come uno arrivava a come lo avevamo ridotto; e poi naturalmente la morte di questi bimbi… Qualcuno si salvava, ma molti morivano ed era difficile, soprattutto perché pensavi che non era quello il sistema di curarli. Lo avevi torturato per gli ultimi tre anni della sua vita, ma che avevi ottenuto? Allora era normale che un bimbo quando stava molto male non si lasciasse morire in ospedale, ed era normale che a turno andassimo a casa sua per non sospendergli le terapie, per mettergli le flebo, per idratarlo, perché non mangiava più… Tutto questo era molto forte e stimolante. Ciò nonostante capii che non era quello che volevo continuare a fare, quindi mentre stavo lì feci il corso di ostetrica al Policlinico. Le lezioni erano pomeridiane, facevo la pratica di notte, nei giorni di riposo. Non avevo figli, ero libera. Il corso di ostetrica durava un anno. Però il modo di trattare le donne mi sembrava che… insomma, che non fosse efficace, semplicemente non fosse efficace, e quindi cercai qualcosa d’altro.
Era il tempo della filosofia di Leboyer, di Odin. Così attraverso il gruppo dei “reichiani” – allora Napoli era una specie di parrocchia, ci si conosceva tutti – arrivai in un ospedale di Parigi, il Lilla, dove c’era un direttore sanitario che faceva il parto secondo il metodo di Leboyer. Questo nel ’77, avevo ventisette anni. Anche lì presi il mio mese di ferie e altri tre di permesso e mi misi al seguito di un’ostetrica della maternità del Lilla, che per caso lavorava anche da Odin. Non spesi una lira di alloggio perché allora c’era questa sorta di solidarietà che se volevi fare una cosa entravi in un giro… non conoscevo nemmeno chi mi dava la casa. Stavo in queste case nei sottotetti a Montparnasse che in genere affittavano ai portoghesi o alle ragazze alla pari. Quando c’era una casa vuota me la davano, si organizzavano tra loro e mi comunicavano: “Adesso vai in un’altra casa”. Insomma, siccome tu credevi in una cosa condividevi con gli altri e davi quello che avevi, non c’era il danaro come modalità di scambio, c’era altro. Questa facilità di viaggiare ha permesso una diffusione enorme, uno grande scambio tra le persone.
L’esperienza al Lilla non fu una rivelazione, certe idee già le avevo, quelle del movimento femminista secondo cui il modo di partorire in ospedale era violento e non dava spazio alla donna. Ma il parto poteva essere rischioso, quindi bisognava organizzarsi. Quando tornai cominciai a fare i parti in casa a Napoli. C’era un ginecologo che mi aiutava, era una sperimentazione, in realtà erano le donne che volevano farlo. All’inizio quelle del movimento: come decisero di fare l’aborto tra di loro, poi decisero di partorire tra di loro. Era una élite. Cominciammo e ci andò sempre bene… insomma, guai non ne facemmo. Io continuavo a lavorare in pediatria, finché non rimasi incinta del compagno dal quale ho avuto i miei quattro figli. Io stessa partorii in casa, con un medico del Policlinico amico mio che sapeva che se non veniva lui ad aiutarmi avrei trovato un altro sistema. Non c’erano tante ostetriche che lo facevano, anzi a Napoli non ce n’erano proprio.
Mi ricordo il primo parto che ho fatto da sola. Era una donna di Roma, perché poi eravamo collegati, facevamo degli incontri con le donne in parecchie città, anche incontri internazionali. Insomma, fu nel ’79, lo feci insieme a un’ostetrica di Roma, Valeria, che allora non era ancora ostetrica. Questa donna viveva con i genitori e loro non volevano, così andammo a farlo in una casa a Ischia. Era dicembre e io avevo Lucio, il mio primo figlio, di un mese. Ho delle foto. Una casa umida, senza riscaldamento, quindi rimanemmo tutti rigorosamente vestiti. Alla fine questa donna partorì e poi allattammo insieme. Era una donna al primo figlio, quindi fece un travaglio lungo ma non ebbi difficoltà per essermi portata un bimbo di un mese, c’erano altre quattro o cinque donne con noi. Non avevamo paura, neppure di essere denunciate. Era anche un gioco, in qualche modo, un mettersi alla prova. Era un momento in cui ci sentivamo forti se portavamo avanti le nostre idee. Se mi beccavano, come ostetrica finivo di lavorare, venivo incriminata, perché loro dicevano che eravamo matte, che ritornavamo ai guai che facevano le mammane. Noi dicevamo che c’erano altre condizioni, che adesso la donna era sana, prima facevano cinque figli di seguito, non c’erano i controlli, non si poteva paragonare l’ostetricia di prima con quella di adesso.
A un certo punto il padre di Lucio andò a fare il servizio civile di due anni in Mozambico come medico e io dopo un po’ lo raggiunsi. Andai a lavorare per il governo, perché non essendo sposata non potevo avere il posto al CUAMM, una Ong di gesuiti. Presi l’aspettativa senza assegni per tre anni – allora gli statali potevano farlo – ed ebbi un contratto da centocinquantamila lire, però con quei soldi in Mozambico ci vivevi. Era subito dopo l’indipendenza, e lì c’era veramente tutto il mondo. Era il primo governo comunista in Africa, quindi sostenuto da Cuba, i russi, i cinesi… insomma, i cinesi un po’ in disparte perché c’erano i russi. Ovviamente niente di buono, figurati che i russi tenevano una striscia di terra sul mare, quindi avevano il monopolio della pesca; la gente di là poteva usare solo le barchette, le navi da pesca erano tutte per la gerarchia politica russa e poi al mercato ci mandavano i sardoni del mar Baltico, e quando andavamo a fare la spesa il venditore ce li scalpellava perché erano ghiacciati, ci scalpellava il pesce al mercato in un posto così… Però era un punto d’incontro di gente di tutto il mondo: svizzeri, olandesi, cubani. Dopo l’indipendenza si era spopolato, non c’erano più medici, né ingegneri, le fabbriche non avevano più dirigenti, perché i portoghesi erano andati via. Anche lì fu un momento speciale, poi dopo tre anni cominciò la guerriglia. C’erano i mercenari assoldati dal Sudafrica, dieci persone ti mettevano in ginocchio un paese: girando, ammazzando, bruciando i villaggi. Dovemmo andar via, non si poteva più girare per le strade, uccidevano soprattutto i cooperanti; agli altri tagliavano le orecchie perché andassero in giro e trasmettessero la paura, ma i cooperanti li ammazzavano perché non volevano più testimoni dall’estero.
È in Mozambico che ho imparato a fare l’ostetrica e ho imparato come un’altra cultura può relazionarsi con i bimbi senza innescare la competizione. Ho scoperto quanto ero autoritaria e quanto stimolavo la competizione nei miei figli. Per me era normale dire di no a un bambino, invece non ho mai sentito la signora che lavorava con noi in casa dire di no, cercava di distrarli piuttosto… ovviamente erano bimbi piccoli, uno di un anno, uno di tre anni. Il mio secondo figlio è nato lì. In Mozambico sono animisti e la signora che lavorava con noi diceva che Paolo era africano perché era stato concepito lì. Per loro il concepimento significa che un’anima si fa posto, decide di nascere in quel posto con quella persona, e quindi era proprio un’anima africana.
E poi il loro modo di partorire, il loro modo di separare rigorosamente la fisiologia dalla patologia perché in ospedale c’era tanto lavoro e se il parto andava bene cercavamo di favorirlo, anche perché l’alternativa, se proprio la cosa non andava, era di chiamare un chirurgo russo con il quale non si riusciva nemmeno a parlare, perché le categorie mediche erano per nazionalità e la chirurgia era russa; facevano un sacco di guai, ma soprattutto non parlavano il portoghese, potevamo solo dirgli: “Opera”, e quindi cercavamo di evitare il più possibile di far operare le donne; questo nelle guardie di notte, poi di giorno c’erano gli olandesi, c’era la capo ostetrica svizzera, che ha assistito anche al mio parto, stava lì da tanto tempo… Ho imparato molto da loro. Soprattutto come riuscire a riportare alla fisiologia un processo, perché operare una donna era molto rischioso.
Insomma, alla fine siamo dovuti andar via per la guerriglia, ma sono tornata in Africa, nello Zimbabwe, che era l’ex Rodhesia, una colonia inglese che stava facendo la transizione economica. In realtà i bianchi avevano conservato tutto, stavano solamente organizzandosi con la borghesia nera per mantenere l’influenza che avevano senza rimetterci gli investimenti di una colonia. Si erano dati dieci anni per fare la riforma agraria e che io sappia non è stata fatta ancora. È uno stato che ha il filo spinato nella bandiera… Tu coprivi una distanza tipo Napoli-Roma, che è la distanza che c’era tra dove abitavamo noi e la capitale, ed era un continuo di filo spinato, non finiva mai, perché chi arrivava delimitava le terre con il filo spinato ed erano intere colline, bastava il filo spinato per dire “questa è proprietà mia”. Gli inglesi non hanno lasciato terra libera.
Sono stata un anno, era impossibile dopo il Mozambico stare lì, perché in realtà il razzismo c’era ancora. Lavoravo in un ospedale, andavo nei “posti di salute”, più o meno l’organizzazione sanitaria era quella di prima, solo che prima tenevano i neri giù e ti invitavano in casa a prendere il tè perché eri bianco, adesso portavano il tè giù perché non potendo far salire il nero, non facevano salire neanche te. Tu facevi quattro ore di jeep sotto al sole dopodiché andavi là e quella ti portava il tè fuori, perché c’era un’infermiera nera insieme a te… Non si poteva collaborare con un paese così. Noi ci siamo andati perché allora il ministero ti dava queste possibilità. In Mozambico la colonizzazione portoghese era fatta da avventurieri. L’inglese colonizza veramente azzerando la cultura locale, il portoghese si mischia, ne approfitta, c’era il portoghese ubriacone che teneva tre mogli nere, però faceva i figli misti che avrebbero avuto la terra dopo di lui. In Mozambico c’era la terra libera e la terra libera permette a una cultura di mantenersi. In Zimbabwe la riforma agraria non è stata fatta. Nelle farm degli inglesi non esisteva possibilità di lavoro per i neri, se non fare lo schiavo.
Così tornammo a Napoli e mi rimisi a lavorare nell’ospedale come caposala in pediatria. Però la città mi stava stretta e feci dei concorsi fuori, vinsi a Vico Equense e andai a vivere lì, lavorando come ostetrica nell’ospedale di Vico, e nel tempo libero assistevo ai parti delle donne che vivevano nelle comuni in campagna. Era un modo per conoscere gente. Partivo con uno, due figli più piccoli e andavo in Puglia, nelle comunità di Shanti Das, di Urupia. Le donne di queste comunità avrebbero fatto i figli da sole, ed era un po’ rischioso perché le comunità sono lontane dagli ospedali, era importante che ci fosse una persona che desse un margine di sicurezza. Anche a Napoli c’erano richieste, però non riuscivo a lavorare molto, abitavo a Vico e nel frattempo mi ero separata e quindi stavo da sola con quattro figli, dopo sei anni mi sono anche licenziata dal lavoro per poter stare con i figli.
All’ospedale di Vico Equense mi hanno fatto battaglia. Loro pensavano che un’ostetrica dovesse stare all’organizzazione del medico, in realtà per legge non è così: nel travaglio e nel parto fisiologico l’ostetrica ha autonomia, è sua la responsabilità di quello che avviene. L’ostetrica deve avvertire il medico solo quando ritiene che ci sia una patologia. Cercavo di mettere in pratica questo, ma non era facile. Andai anche dal direttore sanitario a dirgli: “Abbiamo il cinquanta per cento di cesarei e quello che dovremmo avere è il dodici-diciotto per cento, qui si operano donne che non dovrebbero essere operate, io mi rifiuto di portare le donne in sala operatoria”. Ho avuto rapporti perché non costringevo le donne a salire sul lettino, ma le lasciavo partorire a terra. Mi dicevano che facevo partorire le donne come in Africa. Alla fine le donne erano contente, partorivano bene. Poi ho scoperto che questi rapporti non passavano al direttore sanitario, ma arrivavano solo a me, cioè erano intimidazioni. Ed è per questo che quando poi mi separai, quattro figli, battaglie a casa, battaglie in ospedale, la cosa più semplice fu lasciare… Forse con me hanno forzato la mano perché sapevano che non mi avrebbero convinto facilmente, però se a una giovane ostetrica che si vuole ribellare al sistema fanno quello che hanno fatto a me, è chiaro che diventa difficile sopravvivere.
Mi licenziai e cominciai a lavorare assistendo ai parti. Eravamo solo in due, un’ostetrica di Caserta, Wanda, e io che assistevamo ai parti in Campania. C’è stato un periodo che era un’avanguardia che pensava al parto in casa, alla gestione della propria vita sessuale, alla relazione con i bimbi in autonomia. Poi mi hanno chiesto di partorire in casa anche donne di una cultura molto semplice. Mi ricordo di una donna che vive a Cicciano e che ha fatto tre figli a casa. Lei è figlia di contadini, il marito è contadino. Il primo figlio l’ha fatto in ospedale e l’hanno trattata così male che si è messa a cercare qualcuno che facesse i parti in casa, anche perché la sua mamma aveva partorito in casa… All’inizio non facevo i gruppi, anche se i corsi di preparazione al parto erano molto diffusi. Poi mi sono ricreduta perché ho capito che le donne avevano l’esigenza di rafforzarsi man mano che la gravidanza avanzava, per contrastare un sistema sanitario che affinava sempre di più le sue ingerenze. Poi c’erano le donne con un pregresso cesareo che volevano partorire spontaneamente e lì veramente se la donna non si rafforza è impossibile arrivare alla fine.
Quando ho cominciato a fare i gruppi ho messo su un’associazione con un paio di donne che avevo assistito e con un’altra che era infermiera professionale pediatrica. Nel corso del tempo è stato bello vedere le donne che si sostenevano tra di loro, anche nel periodo dell’allattamento. La solitudine dell’anno seguente al parto in qualche modo poteva essere attenuata da questa rete. Abbiamo case faticose, impegnative, i bimbi non hanno un ambiente libero dove vivere, vanno seguiti continuamente, non ci sono spazi dove possano autogestirsi, questa città non ha spazi non pericolosi per i bimbi e tutto questo resta solamente alla coppia, spesso esclusivamente alla donna.
Negli anni si è formata una rete e io mi sento inadeguata a utilizzarne tutte le potenzialità. Quando si partorisce bene si vuole delegare di meno. Una donna che ha partorito bene instaura una relazione di piacere reciproco con il figlio che alla fine la incastra, quindi c’è bisogno di trovare delle condizioni di non solitudine. Questo significa diventare più forte rispetto a come vuoi partorire, visto che scegli tu, secondo come il tuo corpo lo richiede, che carattere hai, che rapporto hai con la tua sessualità; se vuoi stare da sola, in compagnia, col compagno, con un’altra donna, se vuoi riappropriarti del rapporto con tua madre. Devi essere libera di scegliere, però per scegliere devi sapere cosa vuoi, e per sapere cosa vuoi devi sentirti accompagnata, che un’altra donna capisca le tue esigenze, perché se le vai a raccontare a uno qualsiasi, quello dice: “Ma che stai dicendo? Tu hai solo bisogno di fare un figlio sano e di uscirne viva”. Ci si deve rafforzare in questa conoscenza. Tra donne, tra uomini che siano disposti ad accogliere quello che non conoscono, perché poi lo vedono, lo percepiscono, lo sentono. È l’unico modo di avere dei bimbi soddisfatti e che probabilmente avranno bisogno di poco perché la relazione è così importante e sarà così importante nella loro vita che perseguiranno quella. Per le donne l’unico rischio potrebbe essere quello di volerne fare troppi, di figli. (carola pagani)

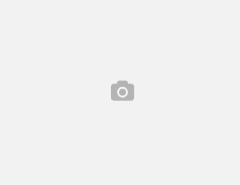



Bellissima questa intervista alla meravigliosa donna che è Teresa.
Unica richiesta: correggete “Odin” in “Odent” – altro pilastro del parto rispettato. Grazie 🙏