
Pochi lo sanno, ma a Napoli c’è un Centro Donna afferente alle Pari Opportunità del Comune, nato alla fine degli anni Settanta e ancora attivo. Dopo vari spostamenti di sede, il centro oggi si trova dentro il Palazzetto Urban, alla fine di Salita Montecalvario, nei Quartieri Spagnoli. Il Palazzetto negli anni è stato tante cose. Lina, la dirimpettaia che porta un po’ le memorie di tutto il quartiere, mi ha raccontato che negli anni ante guerra era un deposito di grano, poi un centro sfollati, un asilo nido per i figli dei dipendenti della pubblica amministrazione e ancora la sede di un consultorio, tanto che molti ancora lo chiamano “il Policlinico”.
Il Centro Donna è un posto abbastanza unico: contiene una biblioteca di genere e un archivio di documenti sul movimento femminista nazionale e internazionale. Nella stessa sede, c’è anche un centro antiviolenza frequentato da molte donne, del quartiere e non. Dico pochi lo sanno, perché non c’è neanche una targa che indichi il Centro dall’esterno. Quest’estate ci è passata, invitata dai volontari che ci lavorano, MP5, artista visiva, muralista, illustratrice molto vicina al movimento queer femminista che si è innamorata del centro e del quartiere. Sono passati sei mesi. Oggi sulla facciata del Centro Donna si staglia in tutt’altezza la figura di Ipazia, astronoma, matematica e filosofa greca vissuta nel V secolo dopo Cristo. Una figura proto femminista che, in un’epoca in cui erano sempre le menti maschili a primeggiare nelle discipline più nobili, portò avanti con coraggio il proprio desiderio di conoscere e far conoscere agli altri la bellezza del sapere. Sfidò il potere prettamente maschile del tempo e fu uccisa da una folla inferocita.
Durante la settimana di lavorazione del murale, tra un caffè e un invito a pranzo delle signore del quartiere che hanno praticamente adottato sia MP che il muro, ci fermiamo per una chiacchierata.
Tu sei nata a Napoli e hai vissuto tra Roma, Bologna, la Francia. Che tipo di formazione hai?
Gran parte della mia formazione l’ho avuta a Bologna, dove ho studiato scenografia all’Accademia di Belle Arti. Gli anni dell’accademia sono stati fondamentali per la mia preparazione. Era un momento in cui nascevano riviste a fumetti come Canicola e Hamelin, c’erano persone che iniziavano a fare murales di grandi dimensioni come Blu ed Ericailcane e c’erano le mie amiche del gruppo To/let con le quali collaboravo. Più che l’accademia mi hanno formato le persone che vivevano la città e i gruppi che si stavano formando. C’era Inguine MAH!gazine di Costantini, Donna Bavosa di Tuono Pettinato e Ratigher, Paper Resistance. Era un buon momento per Bologna, un bel momento.
Come hai iniziato a disegnare sui muri?
Agli inizi del 2000, durante un’occupazione dell’accademia, entrai in una saletta abbandonata e iniziai a ricoprirla con dei grandi disegni in bianco e nero. È stato un lavoro che è durato dei giorni e in questo lasso di tempo le persone iniziarono a interessarsi, a ripassarci, a rendere la saletta un luogo frequentato. Capii che dipingendo degli spazi si potevano anche creare dei nuovi luoghi d’incontro. Quel mio primo lavoro fece sì che le persone iniziassero a cercarmi per dipingere altri spazi occupati e centri sociali. Parallelamente vinsi un residence d’artista in Francia. Lì realizzai la mia prima installazione di grande formato in bianco e nero ispirata al dispositivo dello zootropio. ZOOT II era un lavoro la cui preparazione mi ha permesso di interagire con i bambini di un quartiere che ospitava migranti temporanei senza risultare invasiva. In quel quartiere la situazione non era delle più semplici, le persone non erano interamente integrate e odiavano essere riprese con la macchina fotografica; ma amavano il disegno ed essere ritratti. Considero questo lavoro il mio primo progetto di public art. Ora il termine si è un po’ perso e la street art sembra aver inglobato entrambi i significati.
Cosa intendi per public art?
Per public art intendo tutti quei progetti artistici pensati sul/per il territorio, che entrano nel tessuto sociale e nella struttura urbana della città. Sono chiaramente progetti che richiedono un tempo considerevole di sviluppo e preparazione. Io mi sono diplomata all’accademia proprio con una tesi sulla public art e su le forme d’intervento artistico sul territorio. Per realizzare l’installazione in Francia sono stata in residenza otto mesi durante i quali ho intessuto diverse relazioni con gli abitanti del posto. È da allora che ho capito quanto sia importante la collaborazione con i locali e il giusto tempo per poterla sviluppare.
A cosa pensi quando dici che la street art ha inglobato la public art ?
Ho iniziato a lavorare a progetti di public art agli inizi del 2000. Quello che m’interessava era lavorare nello spazio pubblico, cercando di applicare il disegno all’architettura e alla scenografia. Gli interventi illegali o quelli nei centri sociali sono venuti poco dopo.
Lavorando su dei progetti di public art mi sono resa conto del lungo iter burocratico a cui erano sottoposti, dalla ricerca di fondi alle autorizzazioni. Fare street art è stato per me un modo di liberarmi di tutto questo, andare in un posto che normalmente vivevo (come gli squat e i centri sociali) e riattraversarlo artisticamente evitando lunghe trafile.
Ho sempre lavorato in spazi poco visibili, interni di posti occupati, fabbriche abbandonate. Mi è sempre piaciuto vedere come cambiano gli spazi dopo i miei interventi. La città dovrebbe cambiare continuamente. Per molto tempo ho vissuto la street art come qualcosa di genuino ed estemporaneo. Poi è scoppiato il fenomeno e ha iniziato a essere seguita dal grande pubblico – complici anche i social network e il potenziale virale che questi forniscono alle foto. Ora ci sono i festival di street art, le commissioni pubbliche, i comuni che riqualificano le città attraverso interventi di street art, insomma quello di cui prima si occupava la public art.
Oggi succede che le amministrazioni chiamano degli street artist per fare degli interventi di abbellimento e riqualificazione che magari costerebbero molto di più e invece la risolvono con dei murales. Che ne pensi?
Nel momento in cui un’amministrazione ti contatta per fare un lavoro pubblico c’è il solito iter di cui parlavamo prima. Tu parli di abbellimento. In effetti, alcune volte nelle intenzioni delle amministrazioni può esserci principalmente quella di decorare, di “abbellire”. Credo che ci sia un distinguo da fare. È ovvio che uno street artist non può “recuperare” un muro. Le amministrazioni dovrebbero prima preoccuparsi di restaurare un muro e in seguito chiamare un artista a intervenire. In secondo luogo lo street artist è principalmente un artista, con una propria ricerca e poetica. Un artista in quanto tale ha delle responsabilità. Nel momento in cui ti viene chiesto di lavorare in uno spazio pubblico hai la responsabilità di essere fedele alla tua pratica artistica. Alcune persone si ritrovano a pensare di dover compiacere il pubblico. C’è questa questione del consenso con cui l’amministrazione pubblica deve fare sempre i conti. Per esempio, a me è successo di essere contattata dal comune di Londra per un progetto nella metropolitana; nonostante stessimo già prendendo accordi, le informazioni contenute nella mia biografia sono state sufficienti a far ritirare la richiesta per il timore che i miei disegni avessero un contenuto politico.
Quindi non si deve lavorare con le amministrazioni?
Il punto non è se lavorare o meno con le amministrazioni. Credo che un artista debba agire secondo la propria responsabilità, anche politica. L’arte di per sé è politica. La cosa fondamentale è rimanere fedeli alle proprie idee e alla propria pratica artistica. Se questa è in accordo con le richieste delle amministrazioni, ben venga il lavorare assieme; dal mio punto di vista il reale problema si pone quando un artista svilisce il proprio lavoro pur di ottenere commissioni o quando lo stravolge pur di soddisfare determinate richieste.
D’altro canto è pratica comune che l’underground venga inglobato dal mainstream per il successo commerciale, è successo anche con l’hip hop. Penso che gli artisti si dividano in categorie e che ci siano anche quelli che cercano di continuare ad essere il più possibile coerenti con loro stessi, nonostante il successo commerciale.
Blu ha cancellato alcune delle sue opere a Bologna che stavano rimuovendo per farle finire in un’esposizione museale. Sei d’accordo?
Secondo me quello che ha fatto Blu è perfettamente coerente con la sua pratica. Ritengo che la sua azione artistica abbia lasciato un segno potente, risultando più esaustiva di un qualsiasi comunicato.
I tuoi disegni hanno spesso soggetti gender queer. Come mai?
Negli anni ho attraversato tanti gruppi e collettivi del movimento queer femminista, in Italia, Svezia, Spagna. Il mio attivismo è attraverso quello che faccio, le mie opere non sono altro che una manifestazione del mio pensiero politico. Allo stesso tempo, sento una responsabilità nel modo in cui decido di rappresentare il mondo. Le immagini che ci vengono proposte ogni giorno, dalla pubblicità alla tv, al web, tendono ad essere stereotipate; a me interessa cercare di costruire dei modelli nuovi lasciando spazio al fruitore, spingerlo a farsi delle domande in più. Parte della mia ricerca si basa sulla scelta di nuovi codici comunicativi e in particolare di nuovi modi di usare il corpo per rappresentare esperienze e situazioni non conformi.
Parliamo di quest’esperienza napoletana
Care of Knowledge è un lavoro che prosegue il filone di ricerca che seguo da alcuni anni che richiama il Classicismo e che mi riporta a quella che era l’arte monumentale, ossia pubblica. È stato il mio primo lavoro murale a Napoli. L’interesse nel fare un lavoro nella mia città natia c’era da tanto tempo. Ero già venuta a vedere degli spazi ma non avevo ancora trovato il giusto luogo fino a quando non mi si è presentata l’occasione di lavorare al Centro Donna dei Quartieri Spagnoli. Questo non è un bel momento per gli spazi per le donne. Vedi la minaccia di chiusura al Lucha y Siesta di Roma, uno spazio che offre e ha offerto servizi e supporto gratuito alle donne, e alla stessa Casa internazionale delle donne. Questa situazione ha fatto sì che mi interessasse ancora di più l’idea di sviluppare un progetto che desse visibilità a un posto come il Centro studi Donna di Napoli che non è abbastanza valorizzato e conosciuto dalla cittadinanza. Luoghi che ospitano centri sportelli antiviolenza, supporto alle donne e biblioteche di testi femministi dovrebbero essere considerati una ricchezza dalla comunità. So che un disegno non cambia il mondo ma può essere una delle tante cose che contribuiscono al cambiamento. Durante i giorni di lavoro a Napoli ho interagito con molte persone, non solo con le donne del centro ma anche con le/gli abitanti del vicolo, è stata un’esperienza molto forte. Napoli è una città senza filtri, l’ho sempre amata per questo. Una città in cui cammini per strada parlando da sola e ti rispondono in quattro dal balcone. Nei giorni di lavoro mi sono ritrovata a ricevere caffè passati direttamente dalla finestra al braccio meccanico, a essere invitata nelle case della gente e ad ascoltare le loro storie. Queste interazioni fanno sì che il mio lavoro acquisisca un significato più completo. (francesca saturnino)


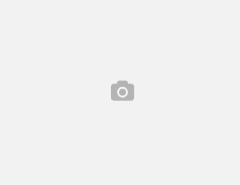


Leave a Reply