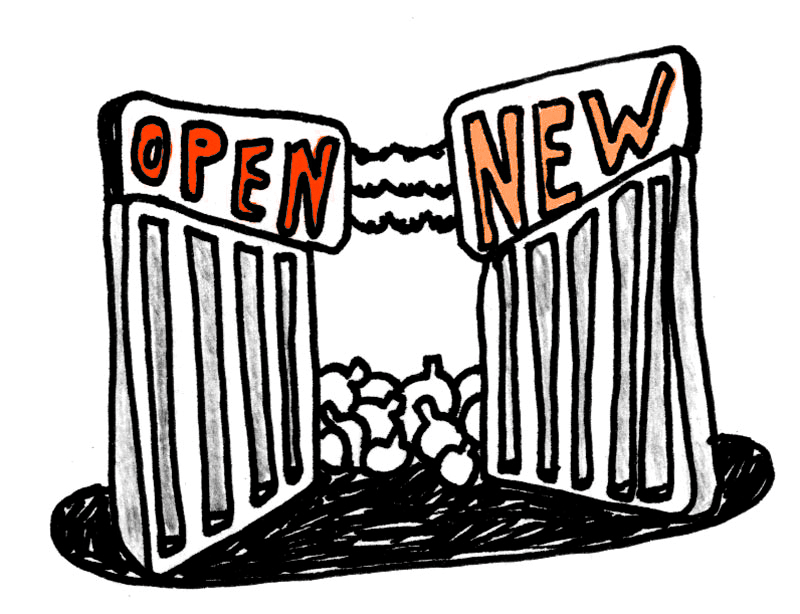
È fin troppo facile ridicolizzare il ministro degli interni italiano nel suo impeto di promozione di nuovi inceneritori. In effetti, non citare uno straccio di dato e confondere le tipologie di rifiuto – gli speciali con gli urbani, e quindi i relativi cicli gestionali – in breve, non avere idea di ciò di cui si parla, può sembrare un passo falso dell’ubiquo leader della Lega. Eppure, anche questo exploit è in linea con la strategia comunicativa che persegue da anni – parlare alla pancia e polarizzare il discorso –, ma stavolta, sui rifiuti, Salvini ha sbagliato regione, momento e forse anche pianeta.
Va detto che conferire nuovo vigore alla proposta di inceneritori non è una strategia solo salviniana. Qualcosa di più ampio si muove. L’intervento del ministro si innesta sugli spunti suggeriti da quotidiani nazionali, come il Sole24Ore e Repubblica, che recentemente hanno animato una campagna fatta di reportage ed editoriali tesi a instillare la necessità di nuovi impianti di incenerimento. A rimettere in circolo i rifiuti nei media è stato l’allarme sociale suscitato dai circa trecento incendi in tre anni in siti di stoccaggio, aziende di riciclo, depositi di eco-balle e impianti di trattamento rifiuti su tutto il territorio nazionale. Siti diversi, che affrontano criticità diverse. In molti casi, azioni dolose legate a strategie criminali. Ma la pubblicistica italiana dei grandi gruppi editoriali, insieme al ministro leghista, offre un’unica diagnosi e relativa prognosi: troppi rifiuti ergo bisogna costruire più inceneritori. I fatti, però, restituiscono un quadro più complesso.
Nel caso dei depositi di carta e plastica differenziate andati in fiamme – centinaia, e più al nord che al sud –, che vi sia dolo o il risultato di accumulo oltre i limiti di capacità e sistemi di sicurezza inefficienti, resta il fatto che si sconta il progressivo stallo del sistema del riciclo. Da un lato, il commercio internazionale di materiali differenziati si è contratto enormemente a causa della svolta di Cina e paesi del sud-est asiatico, passati da riciclatori del mondo a produttori di immense quantità di rifiuti cui viene data la precedenza su quelli stranieri. Inoltre, la pratica di mescolare materiali differenziati e rifiuti tossici nei container che prendevano la via delle catene globali di trasformazione ha rotto la fiducia degli operatori economici e spazientito i governi locali. Dall’altro lato, a livello nazionale, vi è sia un’effettiva carenza di aziende in grado di dare nuova vita ai materiali differenziati, sia una debole domanda di mercato di materie prime seconde che assorba il frutto del riciclo permettendo al contempo la sopravvivenza economica degli operatori. Tutto ciò si traduce in depositi di materia differenziata al collasso, che si incendiano più facilmente, e alla convenienza economica per imprenditori senza scrupoli di distruggere tutto per mancanza di sbocchi sul mercato, per fare spazio a ulteriori conferimenti e guadagnare i risarcimenti delle assicurazioni.
Discorso diverso per gli impianti pubblici intermedi di trattamento dei rifiuti urbani, come gli Stir di Casalduni, Battipaglia, Giugliano e Santa Maria Capua Vetere e i depositi di eco-balle, per restare sul caso campano, oggetto di incendi negli ultimi mesi. In questi casi, la strategia criminale appare palese: mettere in crisi sistemi rodati di gestione, fragili ma funzionanti, per creare artificialmente crisi di conferimento e allarmi atti a motivare la richiesta di più inceneritori. Eppure dovrebbe essere chiaro che in tali eventi il fallimento, più che del sistema nel suo complesso, riguarda supervisione, manutenzione e sicurezza degli stabilimenti, il cui ruolo nei sistemi integrati di smaltimento industriale per la frazione non riciclata è al momento fondamentale.
Risulta quindi evidente che gli incendi a cielo aperto non si risolvono attraverso altri fuochi tra quattro mura. Se poi si guarda al caso campano, sulla base del quale Salvini si è lanciato nei suoi proclami, la questione appare interamente travisata. Il problema della “terra dei fuochi”, dei roghi di rifiuti in regione, una piaga di almeno tre decadi, deriva dallo smaltimento di rifiuti speciali da parte di aziende o formalmente inesistenti o altrimenti operanti in regime di evasione fiscale. Questo lo sa chiunque sia andato a farsi una passeggiata nelle campagne tra Napoli e Caserta sui luoghi dei roghi, trovandovi scarti di pellame e tessuti, rifiuti edilizi, fusti di vernice, rimasugli di gomma e plastica, pezzi di carrozzeria. Si tratta quindi di rifiuti speciali, che includono anche quelli tossico-nocivi, cioè scarti di industrie e manifatture la cui destinazione non può essere un inceneritore di rifiuti urbani. Ben altre contromisure vanno attuate per debellare la “terra dei fuochi”, evidenti a chi da anni studia questo fenomeno. I comitati campani a difesa del territorio le hanno delineate in maniera chiara: implementazione di un sistema di tracciamento nazionale digitalizzato per i rifiuti speciali dalla fonte al terminale; movimentazione dei rifiuti pericolosi tra regioni solo sulla base delle strutture di trattamento registrate; censimento di tutte le attività a nero che insistono in territori particolari; rimozione e bonifica di tutti i micro-siti di scarico abusivo; controllo del territorio tramite collaborazione tra comuni, aumento della vigilanza e tecnologie dedicate come droni e videocamere; inclusione delle conoscenze delle comunità sullo stato dell’ambiente locale; e infine, l’attuazione di una strategia nazionale per la prevenzione e riduzione dei rifiuti pericolosi promuovendo al contempo, attraverso incentivi economici e visibilità, quelle imprese che si conformano ai regolamenti vigenti. Altro che inceneritori.
D’altronde, la Campania è autonoma per capacità d’incenerimento rispetto agli obiettivi di riciclo regionali, con 750 mila tonnellate all’anno bruciate dall’unico inceneritore di Acerra, fonte di guadagni milionari per il gestore A2A e alibi per quei comuni (come Napoli, ferma al trenta per cento di differenziata) che ancora non hanno raggiunto la soglia di legge del sessantacinque per cento. Nonostante ciò, la Campania è la regione meridionale con il più alto tasso di riciclo (più del cinquanta per cento) le cui performance continuano a migliorare pur con situazioni internamente molto differenziate. Ciò di cui il ciclo dei rifiuti campano ha bisogno per raggiungere autonomia sono impianti di compostaggio e compostiere di comunità, organicamente collegate alla raccolta differenziata e al settore agricolo regionale cui fornire il compost, e un aumento della raccolta differenziata. Per una raccolta di frazione organica che a livello regionale arriva a più di 650 mila tonnellate, vi è una capacità di circa 60 mila. Per quella frazione secca che ancora finisce in discarica è necessario aumentare gli sforzi di separazione alla fonte per destinare gli scarti recuperati verso il riciclo. È in questi ambiti che si deve lavorare, per costruire i presupposti dell’autonomia regionale completa e per abbattere i costi delle tariffe pagate dai comuni per conferire, i quali lievitano proprio a causa delle esportazioni di rifiuto organico differenziato e di tal quale verso impianti fuori regione che impongono tariffe al rialzo.
Mettendo insieme i pezzi dello stato effettivo del sistema rifiuti e confrontandoli con i tentativi di riportare in auge gli inceneritori, si dipana quello che può essere definito un progetto condiviso, forse nemmeno pianificato da un’unica mente, certamente reazionario e fuori tempo massimo. Se ne avevano le avvisaglie già con il governo Renzi, durante il quale, con lo Sblocca Italia, si intimava il raggiungimento della capacità termica massima per gli inceneritori esistenti e ne venivano pianificati dodici ulteriori. Ora ci risiamo. Vi è una convergenza d’interessi nell’attaccare, delegittimare e rallentare il sistema del riciclo a vantaggio di un ritorno all’economia dell’incenerimento, che fa gola alle multi-utility italiane in cerca di reinvestimenti produttivi consistenti. I sistemi del riciclo e i tentativi di andare nella direzione di riduzione e riuso, hanno in Italia esempi fulgidi di cambiamento in atto nelle relazioni con la materia, anche oltre la differenziata, che coinvolgono produttori ed esercenti locali. Come a Treviso, la città con la più alta percentuale di riciclo al mondo, che ha rifiutato l’inceneritore a suo tempo ed è arrivata a quasi il novanta per cento di raccolta differenziata. E come nella stessa Campania, dove la popolazione ha contribuito ai successi e al costante aumento delle percentuali del riciclo in anni recenti. Il sistema è forse in affanno, ma perché non si è coordinato e supportato il segmento del riciclo nelle sue varie declinazioni, alimentando l’economia alternativa del rifiuto che cerca di farsi spazio tra i giganti piromani. L’intervento governativo avrebbe dovuto creare i presupposti per una convenienza crescente della sottrazione di materia all’incenerimento e alla discarica tramite incentivi ai comuni e agli operatori, finanziamenti alla ricerca nel settore del recupero dei materiali, e una strategia industriale nazionale per ridurre la produzione a monte di rifiuti speciali e urbani. In Italia si sente ancora parlare della “rivoluzione culturale” che sarebbe necessaria per espandere la raccolta differenziata, ma questa è una valutazione da incompetenti, in quanto nelle scienze dell’organizzazione e nelle evidenze empiriche è chiaro da tempo che il rifiuto è una questione strutturale, non individuale, cioè sono i sistemi di gestione, differenziazione e riciclo intuitivi, funzionanti e chiusi, frutto di partnership condivise e privi di contraddizioni interne, a guidare le azioni delle comunità. Le persone sono pronte, a languire sono la pianificazione e il coordinamento. È necessaria più intelligenza piuttosto che più inceneritori.
Anche perché proporre oggi gli inceneritori è come promuovere il telegrafo nell’era dello smartphone. Costruire un impianto di incenerimento comporta alti costi iniziali che determinano tempi lunghi di ammortamento dell’investimento, imponendo la garanzia di un flusso costante di materia in entrata, anche in virtù del periodo di operatività medio di circa vent’anni. È dimostrato dalla ricerca e dalla pratica che tali impianti disincentivano la riduzione dei rifiuti, l’elaborazione di nuovi design degli oggetti che facilitino il riciclo e il riuso, e la raccolta differenziata. La Danimarca, tanto citata ultimamente, illustra bene le contraddizioni insite in tale modello di gestione. L’inceneritore da 400 mila tonnellate/anno inaugurato da poco è stato il frutto di un’aspra battaglia politica che ha visto come maggiore oppositrice la ministra dell’ambiente Auken, ed è in aperta contraddizione con gli obiettivi di uscita dalla pratica dell’incenerimento contenuti nella strategia nazionale Denmark without waste: recycle more, incinerate less emanata nel 2014. Inoltre, secondo i calcoli degli stessi danesi, imporrà l’aumento dell’importazione di rifiuti da paesi terzi per essere alimentato, dato il progressivo miglioramento di riduzione e riciclo ma anche per il sovradimensionamento della capacità di incenerire della Danimarca, che è attualmente fanalino di coda dell’intera Europa e uno dei luoghi al mondo con la più alta produzione di rifiuti urbani pro-capite.
Come se non bastasse, occorre ricordare che gli inceneritori non distruggono i rifiuti, ma li producono: secondo un’analisi di Agostino di Ciaula, l’inceneritore di Brescia produce 163 mila tonnellate di rifiuti nocivi in forma di ceneri e residui di abbattimento fumi, poco meno dei rifiuti urbani che l’intera regione Veneto (al 72,9% di differenziata) smaltisce in discarica (233 mila tonnellate). L’inceneritore di Acerra produce oltre 150 mila tonnellate di residui tossici, più di tutti i rifiuti urbani smaltiti in discarica dalla Liguria (144 mila tonnellate). Senza contare le emissioni di inquinanti in atmosfera.
Gli inceneritori ritardano o impediscono la transizione verso un tipo di rapporto tra società e risorse fondato sulla circolarità dei processi produttivi e di consumo (una transizione che è la strategia continentale dell’Unione Europea) in cui si prospetta che la nozione di rifiuto sparisca quasi definitivamente, attraverso la riprogettazione integrale dell’economia industriale. Coloro che giustificano la propria posizione pro-inceneritori dicendo che bisogna pensare ai rifiuti che ci sono ora, in realtà sta ipotecando il futuro tramite sillogismi falsi. Sono le scelte di oggi che determinano la direzione futura. E chi, in fondo, ha interesse a mantenere le cose come sono? Chi dai rifiuti ci guadagna economicamente e chi vuole guadagnarci politicamente. Una multinazionale che gestisce un inceneritore ha a sua disposizione un’unità compatta e localizzata dove confluisce un costante flusso di materia tramite le piattaforme logistiche del rifiuto. Pur essendo un sistema di distruzione altamente inefficiente, è centralizzato e produce una rendita costante. Diverso il caso dell’industria del riciclo, dinamica, spezzettata in miriadi di piccole e medie imprese, e contigua all’industria del re-design e alla ricerca industriale, i nodi centrali che bisogna affrontare.
Fa sorridere, o piangere, che mentre a livello internazionale si discute ogni santo giorno di fine del mondo e cambiamenti climatici, di come l’attuale sistema economico stia portando al collasso socio-ecologico e vada cambiato, in Italia si parli ancora di inceneritori. Siamo rimasti alla scoperta del fuoco. Si sconta il provincialismo, ma anche la presenza di una classe politica e intellettuale aggrappata al potere e del tutto incapace di capire, figuriamoci di affrontare, le sfide planetarie attuali. Se vogliamo rimanere al di sotto di 1,5°C di riscaldamento globale, il picco delle emissioni di gas serra può avvenire al massimo entro il 2020. Meno di quattrocento giorni da oggi. Da quel momento, le emissioni devono necessariamente essere dimezzate entro il 2030 e azzerate entro il 2050, secondo stime prudenti. Un inceneritore costruito oggi continuerebbe a emettere, e ad alimentare un’economia della produzione e del consumo altamente entropica, fino al 2038 come minimo. Chissà se per allora ci sarà ancora la Lega. Chissà se ci sarà ancora l’Italia. (salvatore de rosa)



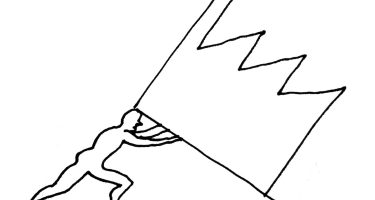

Leave a Reply