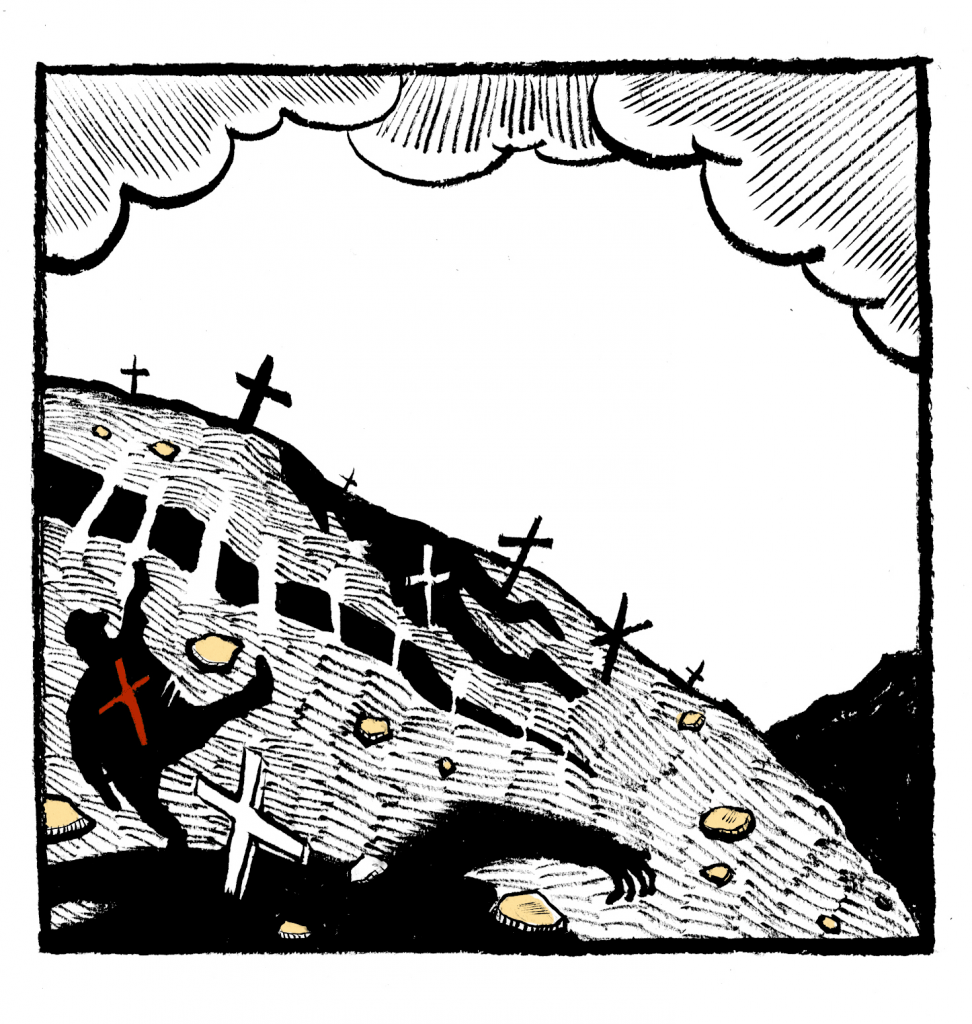
Napoli in cronaca nera, edizioni Newton Compton, è l’ultimo libro di Simone Di Meo, già autore di L’impero della camorra. Vita violenta del boss Paolo Di Lauro e di Faida di camorra. Stavolta il giornalista scrive in coppia con Giuseppe Iannini che nel risvolto di copertina viene indicato come appartenente a un importante gruppo investigativo dello Stato. Nel libro si alternano i recenti fatti di malavita alle riflessioni su come narcotrafficanti, killer e spacciatori rendono più proficui i propri traffici: a volte gli episodi sono poco più che aneddoti, raccolti in capitoli di due o tre pagine, altre volte sono storie più articolate. La narrazione è quasi sempre in prima persona, e tutto l’insieme appare come la rielaborazione di una lunga intervista, del giornalista all’investigatore, integrata da citazioni di atti giudiziari, intercettazioni, interrogatori. La scrittura è rapida, il tono oscilla tra lo sdegno per i crimini e il compiacimento per l’azione di contrasto, contraddicendo qua e là una meritoria dichiarazione d’intenti che gli autori affidano alla prefazione: “Un solo obiettivo abbiamo cercato, accuratamente, di evitare: impressionare il lettore facendo leva sul fascino del male”.
È evidente la consapevolezza di iscriversi in un filone sensibile della produzione libraria di questi anni, e quindi si mettono le mani avanti, alludendo con velata polemica al libro-matrice di questa produzione, il fortunatissimo Gomorra. Nonostante ciò, indignazione e compiacimento si insinuano tra le righe di Napoli in cronaca nera, così come in tante pagine del libro di Saviano, ma a un livello letterario molto meno raffinato. Non a caso i titoli dei capitoli – “Pronto, chi spaccia”, “La droga di Batman”, “La testa decapitata che parla”, “Morte di una caramellaia” – fanno pensare piuttosto a ipotetici B-movie di malavita tutti da girare, e la loro proliferazione un po’ disordinata, che scandisce le duecentocinquanta pagine del libro, non contribuisce a rendere più chiaro il discorso.
Ed è inevitabile citare Gomorra, da un lato perché Di Meo è il giornalista che ha portato in tribunale Saviano accusandolo di plagio, dall’altro perché confrontare l’ispirazione di autori che lavorano su materiali simili, ci consente di riflettere sugli esiti di questo tipo di produzione. Se in Saviano, infatti, il lavoro sullo stile e sulla struttura del libro in qualche modo conferisce equilibrio e credibilità anche alle parti più enfatiche e appiccicose, in Di Meo – e in tanti altri che, anche senza volerlo, hanno provato a intercettare la scia di quel successo – le storie si sfilacciano rapidamente, i protagonisti non acquistano spessore, i picchi dell’emotività a volte schizzano incontrollati, altre volte faticano a decollare, e il libro finisce per essere solo un altro tassello nella lista di un genere ormai abusato.
Certo, i libri di malavita e di camorra abbondavano nei cataloghi anche prima di Saviano, dopo però, hanno avuto una visibilità, e alcuni un mercato, mai raggiunti. Volumi scritti con mano rapida da bravi e documentati giornalisti specializzati in cronaca nera: raccolte di materiali accumulati negli anni che hanno trovato poco spazio sulle pagine dei quotidiani, approfondimenti delle vicende di questo o quel clan, di questo o quel boss; nei casi migliori dei buoni libri d’attualità, destinati a scolorire con l’avvento di nuovi clan e di nuovi boss. Il titolo più noto del pre-Gomorra è certamente Il camorrista, di Giò Marrazzo, edito da Pironti negli anni Ottanta, dal quale Tornatore trasse il suo primo film, con Ben Gazzara nella parte di Raffaele Cutolo.
Roberto Saviano, nel novero di questi giornalisti-scrittori, ha provato a far evadere le vicende criminali dal recinto del genere, conferendo loro, mediante la scrittura ma anche attraverso la concezione, la struttura del libro, una serie di valenze più ampie, sul piano analitico (la camorra non è un fenomeno locale), simbolico (la lotta tra il bene e il male), letterario (la confusione tra finzione e realtà), e così via. Non dimentichiamo che Saviano nasce giornalista, anche se nella fase iniziale della sua consacrazione da Vip farà di tutto per rinnegare questa origine, accreditandosi puntigliosamente, e in ogni occasione, come scrittore, scrittore e basta, qualifica evidentemente di grado superiore nelle gerarchie dell’industria culturale.
Con l’aumentare della popolarità anche Saviano è diventato per tutti solo uno scrittore, facendo dimenticare il suo passato da cronista. Eppure, come free lance e seppure per pochi anni, è stato un ottimo giornalista, il prototipo del reporter solitario che va nei posti a cercarsi la notizia, trovandosi con tenacia le fonti, studiandosi le carte fino a notte per poi comporre inchieste o reportage che avessero – proprio attraverso lo stile, per quanto discusso e discutibile – la dignità di “storie”, e non semplici articoli di cronaca nera.
Quel che rammarica, al di là dei molti libri sullo “spettacolo del male”, più o meno riusciti, più o meno sinceri, più o meno curati (la gran parte meno), è allora il fatto che ben pochi giornalisti, sia tra i vecchi che comandano dalle scrivanie che tra i giovani cronisti di strada, abbiano dato l’impressione in questi anni di aver recepito l’esempio, vincente da un certo punto di vista, del Saviano giornalista (naturalmente quello del pre-Gomorra, non il noioso predicatore di adesso).
Si è generato un grande – e spiacevole per i lettori – equivoco. Il successo di un libro ha generato un profluvio di non eccelsi libri, mentre quasi tutti hanno dimenticato che le storie da cui il libro era composto nascevano dal lavoro di un cronista e spesso erano apparse sui giornali, o in rete, prima ancora di essere accorpate in volume. Allora, se ha avuto successo quel libro, perché non dare credito al modello di giornalismo che l’ha ispirato? (luca rossomando)



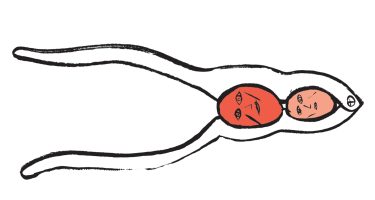
Leave a Reply