
È circa l’una di notte quando arriviamo al motorino parcheggiato nel vicolo di fronte al Conservatorio. Ci troviamo seduta una ragazza, avrà al massimo quindici anni. Sul motorino accanto ce ne sono due di ragazzi. Uno ha gli occhiali, entrambi un cappello nero. Tuta Minimal e bomber nero. Stanno scherzando tra di loro, ci vedono e si scusano per quella che percepiscono come una brutta figura: «Ja nun facimme figure ‘e merda!». Capiscono che qualcuno tra loro dovrà alzarsi dalla sella usata come sdraio. Tocca alla ragazza, che mentre va via urla qualcosa di volgare all’indirizzo dei due. Quello con gli occhiali si alza, fa per inseguirla e intanto le urla dietro: «Sta zingara ‘e mmerda!». Mi metto davanti a lui per evitare che la raggiunga, il gesto inaspettato lo stupisce e stranamente invece di travolgermi si ferma.
I due rimontano sul motorino accanto al nostro e riprendono a parlare. Vogliono farsi un selfie ma poi non viene il motorino, che invece gli piace e vorrebbero immortalarlo. Mi offro di fargli la foto. Uno dei due, il più magrolino, mi dà il suo cellulare senza esitare. La foto gli piace e gliene faccio altre. «Siete fotografa?», chiede il magrolino. «Ja se n’anna ji, nun facimme figure ‘e merda», dice quello più grosso. Ma di andarmene non ne ho più nessuna intenzione e ci mettiamo a parlare. Come salvaschermo del cellulare c’è una foto di lui in posa a piazza Bellini in atteggiamento affittato, da comparsa di una delle serie tv che hanno invaso il nostro immaginario sulla criminalità negli ultimi anni.
«Comme staje bello! – gli dico – Chi te l’ha fatta sta foto?».
«Nu fotografo americano», è la risposta fiera. Poi me l’ha passata ‘ncopp ‘a Whatsapp. Già immagino il fotografo raccontare di quando un pericolosissimo quindicenne really very napolitan è stato immortalato dalla sua Nikon.
V. e G. hanno rispettivamente quindici e diciassette anni. V. ha preso il nullaosta, frequentava ragioneria ma in quella scuola non ci vuole andare più. Forse andrà all’alberghiero. A scuola si scoccia. G. invece a scuola non ci va, vuole fare cinema.
«Pecchè sta a int frateto?».
«E vuje che ne sapite?», è la sua risposta stupita.
Non si è neppure reso conto che mentre parlava con V. ha usato come intercalare, a conclusione di una frase, «m’adda murì fratemo carcerato».
V. non è il fratello di un carcerato qualunque. Di fratelli che stanno “dentro” ne ha due, e sono detenuti eccellenti. Chi conosce un po’ le vicende criminali dei quartieri del centro storico non può dimenticare le faide del 2015. I fratelli di G. sono stati tra i protagonisti di quegli eventi. Su di loro, sulla loro ascesa criminale, esiste un documentario dalle grandi pretese evocative, filmiche, di denuncia. Avevo mostrato quel documentario ai miei alunni di terza media circa un anno fa. La domanda che ci ponevamo tutti era sul futuro dei ragazzini dei clan rappresentati in quella come in altre produzioni cinematografiche. La loro vita, G. me ne dà conferma, non è mutata.
V. e G. descrivono la loro realtà con questa frase che uno dei due comincia e l’altro completa: «È una giungla, piena di serpenti, si salvi chi può!». Fanno un po’ ridere nel loro perfetto sincronismo da rapper improvvisati, se non intravedessi la possibilità che quanto hanno appena detto potrebbe configurarsi come un tragico epitaffio.
Il fatto che io conosca la storia del fratello di G. crea una prossimità che lo rassicura e quindi si confida. Parliamo di scuola, di futuro, del suo tentativo fallito di fare il pizzaiolo: «M’aggio scurdato ‘e pizze e me ne so fujuto co ‘o motorino», dice. Poi, velatamente, accenna a quella che capisco essere stata la sua prima rapina (ma non voglio interrompere la sua narrazione) e di quando si è fatto mandare via da un corso di formazione regionale perché ha litigato con un ragazzo e ha “cacciato” il coltello. Parliamo del cinema, che gli piace, sì, forse, ma non abbastanza, perché «se sfasterea ‘e tutte cose». Parliamo dell’assistente sociale con cui va a parlare una volta al mese e che gli chiede perché si comporta male e cerca di calmarlo… «jà!», conclude a troncare la frase, con un’espressione che aggiunge ogni volta che vuole sfumare il racconto lasciandolo alla mia interpretazione. E allora glielo dico: «G., ma si scemo? Vulisse fa ‘a fine ‘e Ugo Russo?».
«Era nu cumpagno r’ ‘o mio», dice, e si incupisce.
Mentre lui parla delle disastrose esperienze lavorative e scolastiche, sue e dei suoi fratelli, una serie di domande si agitano nella mia testa. Quali provvedimenti ha messo in campo lo stato per evitare che G. segua le orme del fratello M. che ha provato a fondare un clan, o del fratello S. che giovanissimo si è affiliato? E non segua invece il quarto fratello, quasi disconosciuto dai suoi familiari, perché «se n’è jute for’ ‘a fatica’?». Quale supporto gli è stato dato affinché non si trovi nella condizione di non avere altra scelta che la devianza?
Queste domande sono però da “buonista”. Buonista è la parola che viene apposta come etichetta a chiunque cerchi di interrogarsi sulle responsabilità collettive nella predestinazione alla criminalità dei giovani marginali. Allora di domande ne pongo altre, stavolta da “stronzista”: cosa ha fatto il mio stato per evitare che io mi ritrovi tra qualche anno rapinata di notte da G.? Cosa per evitare che G. fondi una “paranza” tutta sua insieme a V.? Cosa perché non si faccia uccidere dalle forze dell’ordine e più in generale non diventi un carico economico per lo stato e quindi anche per me?
A San Gaetano, piazza Bellini, lungo i Tribunali. Le vie sono le stesse e le attraversano individui di tutte le classi sociali. V., G. e i suoi genitori parcheggiatori. Io e l’amico penalista, che dovevamo prendere il motorino. «Con rispetto parlando – dice V. –, l’avvocato se zuga ‘o sanghe de ‘e carcerate!». «E tu vire ‘e nun t’ ‘o fa zugà», gli rispondo salutandolo.
In questi quartieri si svolgono esistenze parallele, separate da uno specchio, che non si toccano, non si destano dal torpore, dal grande sonno che avvolge tutti coloro che non vedono e soprattutto non capiscono pur percorrendo le stesse strade, tracciando con i piedi gli stessi perimetri. Quegli stessi che sono pronti a indignarsi per qualche minuto quando la notizia è troppo cocente per non essere commentata prima di passare al post successivo. Ho detto a V. e G. che la prossima volta se ci vedono devono avvicinarci e salutarci senza vergogna. Perché di certo loro non stanno facendo «nisciuna figura ‘e mmerda». (marilisa moccia)



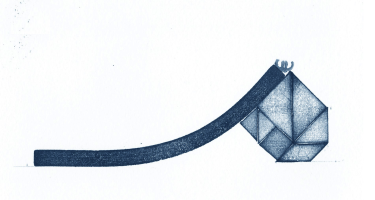

Leave a Reply