
Qualche mese fa, una fondazione benefica che disponeva di una somma da investire in un quartiere del centro storico, convocò una riunione con le associazioni attive in quel quartiere, chi a sostegno dei minori, chi degli immigrati, chi in altri settori come la musica o il turismo. Invece di incontrare una persona per volta e stare ad ascoltare, avevano riunito tutti in un ampio salone e dopo un rapido preambolo avevano posto la domanda a bruciapelo: “Di che cosa c’è bisogno nel quartiere?”. Ognuno dei presenti aveva pochi minuti per raccogliere le idee e dire qualcosa di sensato al cospetto degli altri. La sala, situata all’interno di un impianto comunale, chiudeva a metà pomeriggio.
Gli interventi si susseguivano in modo disomogeneo: qualcuno andava fuori tema, parlando a lungo e a sproposito; altri, rappresentando entità molto diverse tra loro, avanzavano proposte inconciliabili; gli ultimi a prendere la parola l’avevano fatto incalzati dai custodi che reclamavano il rispetto dell’orario di chiusura. Due settimane dopo, una mail della fondazione annunciava che i soldi sarebbero andati a un gruppo di ricercatori dell’università, con il compito di facilitare i rapporti tra le suddette associazioni per arrivare a progettare qualcosa insieme. A chi gli contestava l’assurdità dell’investimento, uno dei responsabili della fondazione sintetizzava così la ragione di quella scelta: “Noi napoletani non riusciamo ad andare d’accordo su nulla, questo è il vero problema della città”. Vagli a spiegare che il fatto che esistessero associazioni, e quindi gruppi di persone, operose da anni nel quartiere con discreti risultati era già una smentita a quel luogo comune; e che entità così diverse per dimensioni, composizione, ambito di intervento, non sarebbero andate d’accordo nemmeno a Copenaghen; ma soprattutto che non era per nulla indispensabile che andassero d’accordo, bastava che operassero nel modo migliore perseguendo ognuna la propria ragione sociale.
* * *
Il libro di Antonio Pascale, Non scendete a Napoli (Rizzoli, 2015), mi sembra basato sullo stesso tipo di equivoco, che il discorso sulla città debba partire sempre dai suoi caratteri all’apparenza immutabili, dai suoi eterni luoghi comuni, e che questi vadano interpretati (e combattuti) con grande profusione di energie, anche quando davanti ai nostri occhi si profila un panorama del tutto nuovo, inedite figure sociali, nuovi rapporti tra le persone. Accade così che i risultati di tale impegno risultino spesso modesti. A guardarla dall’alto, in effetti, la città sembra sempre la stessa, i suoi punti di forza e le sue debolezze sempre uguali nel tempo, ma a viverci dentro, e con le antenne dritte, non è difficile registrare microscopici, continui cambiamenti, che a lungo andare ne cambiano il volto, la trasformano dall’interno, e che richiedono spirito d’osservazione e strumenti aggiornati, altrimenti si finisce per girare intorno alle solite vecchie storie, sempre più datate e sempre meno utili.
Anche Pascale, come i responsabili di quella benemerita fondazione, dispone di notevoli risorse: sa scrivere, sa farsi ascoltare, si è costruito negli anni un pubblico affezionato. Perché allora dedicare un altro libro a discettare sui luoghi comuni, veri o presunti, che condizionano l’immaginario sulla città? È lo stesso Pascale a chiederselo ironicamente nel primo capitolo, invitando il lettore a lasciar perdere. Ma è solo un’esitazione di maniera, un attimo dopo lo scrittore si è già addentrato nel solito intrico di storielle paradossali attraverso le quali i napoletani parrebbero compiacersi del proprio “essere diversi”, in un miscuglio di vittimismo e autoindulgenza, sentimentalismo e approssimazione.
È lo stesso genere di storielle che Luciano De Crescenzo ha fissato per sempre in alcuni libri e film, facendole divenire dei classici della chiacchiera da bar. A suo tempo ci siamo divertiti a leggerle e ascoltarle, ma il tempo è trascorso e abbiamo imparato a dare il giusto peso a quei simpatici tormentoni, preferendo altri modi, più articolati, di interpretare la città. Pascale sostiene che quel modo un po’ caricaturale e paternalista di rappresentare i rapporti tra le classi alte e quelle basse della città rispecchia il modo in cui l’intellettuale napoletano sublima il suo desiderio di essere popolo, cercando allo stesso tempo di tenerlo a bada, di controllarlo e dirigerlo. Dalla frustrazione che segue la scoperta di non essere popolo né di poterlo dirigere scaturiscono, secondo Pascale, due conseguenze: fuggire (dalla città e dalle responsabilità); oppure raccontare un popolo migliore di quello che in realtà è, una sua versione edulcorata: quella di De Crescenzo.
A questo approccio romantico Pascale contrappone giustamente quello “analitico” di Massimo Troisi, la sua convinzione, espressa nei modi propri alla sua arte, che si debba squarciare il velo degli stereotipi sulla città e affrontare finalmente i fatti, nudi e crudi, così come si presentano. Non a caso, Pascale dissemina il suo saggio di analisi, cifre, apporti da molteplici discipline. Ma allo stesso tempo il tono generale del libro, il modo di procedere e le sue conclusioni, appaiono molto più vicine all’approccio dell’ingegnere-filosofo che a quelle dell’attore.
A un certo punto lo stesso Pascale entra in scena, diventa protagonista di una storiella alla De Crescenzo, protagonista negativo perché infrange la legge, ma in fondo innocuo, bonario, giustificato dalle circostanze. Non importa se la storia è vera o se l’autore se l’è inventata. È il suo modo per rassicurarci, per dirci che siamo tutti uguali; anche lui, che ha sempre vissuto tra Caserta e Roma (ma è nato a Napoli), ha i nostri stessi difetti, che ci porteranno dolcemente alla rovina, anzi ci hanno già rovinato. Ma non c’è niente da fare, siamo fatti così. Inutile opporsi, inutile cercare altre strade.
Su altri tipi di storie, invece, Pascale appare molto meno indulgente e ci comunica tutto il suo disappunto: per esempio, le storie che su Napoli hanno raccontato alcuni intellettuali, napoletani e non, infarcendole di metafore affascinanti e imprecise, e tenendo in scarsissimo conto i dati scientifici, le statistiche, i numeri; o quelle che racconta una certa sinistra, che sostiene di parlare a nome del popolo ma si rivela poi del tutto incapace di rivolgersi agli esseri umani in carne e ossa, quelli che abitano i vicoli o le periferie della metropoli.
È un procedimento abbastanza diffuso, in questo modo di fare polemica, di individuare una sfilza di obiettivi già ampiamente screditati nell’opinione pubblica (per esempio i politici, gli intellettuali o la sinistra), isolare alcuni dei loro più scoperti punti deboli e cominciare a tirare le proprie bordate, posizionandosi “a destra” sulla linea di tiro; poco importa che gli stessi obiettivi siano stati ampiamente sottoposti a critica, attraverso riflessioni e pratiche, da chi si colloca sul lato opposto rispetto a quella posizione. Lo stesso schema, per esempio, aveva usato qualche anno fa Adolfo Scotto di Luzio, che non a caso Pascale cita alla fine del libro come una sorta di ispiratore.
Scotto di Luzio aveva pubblicato nel 2009 un agile libro dal titolo Napoli dei molti tradimenti (Laterza), che mandò in visibilio molti vecchi tromboni negli ambienti culturali cittadini, perché metteva alla gogna con uno stile vivace e beffardo – di cui loro non sarebbero stati capaci – alcuni dei tic più ridicoli degli intellettuali e dei giovani arrabbiati della sinistra napoletana, dal mito dei “figli di Annibale” alla fissa per il Mediterraneo, fino all’ossessione per il popolo coltivata dal piccolo borghese che si crede rivoluzionario. Il punto di vista scelto, di chi in gioventù è stato immerso fino al collo in certi ambienti e poi se n’è decisamente allontanato, conferiva al libro un tono spassoso, che gratificava il lettore benpensante, confermando con arguzia – e con quel filo di amarezza che non guasta – le sue più radicate avversioni. Lo stesso punto di vista, in fondo piuttosto scontato – la maturità, la saggezza conquistata con l’età –, lo rendeva però anche un libro inerte, senza speranza.
Nel 2011 è uscito il libro Insegnare al principe di Danimarca, raccolta postuma di scritti di Carla Melazzini, ordinati per Sellerio dal suo compagno di vita Cesare Moreno. L’esperienza di cui racconta Melazzini – un modulo di Chance, la scuola della seconda opportunità, con un gruppo di ragazzini della periferia orientale di Napoli – era già in corso da anni quando Scotto di Luzio pubblicava il suo libro. E naturalmente non era l’unica esperienza di quel tipo che si svolgeva in città. Ma concediamo pure il beneficio dell’ignoranza. Quel che sembra impossibile, dopo l’uscita del libro di Melazzini, è continuare a scrivere del rapporto che esiste a Napoli tra le “due città”, tra borghesia e popolo, come se fossimo in un bozzetto di De Crescenzo o in una canzone di Tony Tammaro, con i primi idealisti e impacciati al cospetto dei secondi, malandrini e paraculo.
In Mistero napoletano Ermanno Rea ha raccontato quanto fosse assoluto il pregiudizio del mondo comunista – borghesi e operai accomunati in questo – verso gli ambienti sottoproletari della città, abbandonati senza combattere nelle braccia di Lauro e della destra, sebbene ancora lontani da quella deriva criminale che si farà col tempo più spietata e pervasiva. Erano gli anni Cinquanta. E già allora c’era chi non la pensava a quel modo, e si dava da fare nei vicoli del centro storico o in periferia – che allora erano veri e propri paesi –, al margine degli schieramenti politici maggioritari, per creare le condizioni di un incontro con l’altra città, all’apparenza immobile nei secoli, eppure inafferrabile e sconosciuta. Ne ha scritto, per esempio, Fabrizia Ramondino (L’isola dei bambini, e/o). Su quella scia si sono inserite esperienze simili negli anni Settanta, poi negli anni Novanta, fino a quelle attuali: sempre ignorando gran parte della storia precedente, eppure seguendo una traccia riconoscibile dall’esterno, un sentiero già battuto dalle generazioni passate.
Da decenni a Napoli settori non trascurabili della classe media si sono posti il problema di come mettere in comunicazione i diversi “mondi”, contigui ma distanti, che formano la città. Possiamo classificarli come borghesi, come intellettuali, come gente di sinistra? In alcuni casi sì, anche se non sempre. Eppure non assomigliano in nulla agli intellettuali, ai borghesi, ai “comunisti” che descrivono Pascale o Scotto di Luzio nei libri di cui parliamo. Sono persone che hanno individuato nella relazione tra quei mondi diversi uno dei nodi decisivi da sciogliere per cambiare la città e si sono lanciati nell’impresa, andando verso “l’altro” senza farsi troppe domande; con il tempo alcuni di essi hanno elaborato delle forme codificate per rendere questo incontro più costruttivo; hanno dovuto mettersi in gioco e ricominciare daccapo molte volte; in tale sforzo non hanno forse rivoltato la città come speravano, ma hanno prodotto almeno un denso arcipelago di esperienze umane e pedagogiche innovative; e, tra le altre cose, come un effetto accessorio, come un piccolo gioiello grezzo, anche il libro di Carla Melazzini. Basta leggerne qualche pagina per capire che continuare a interpretare la città attraverso la storiella del pescatore pigramente adagiato sullo scoglio di Santa Lucia, equivale a dibattere sul problema della tubercolosi ignorando che da decenni esistono gli antibiotici.
* * *
Libri come quelli di Pascale (e Scotto di Luzio), dopo avere combinato in maniera brillante una selva di materiali eterogenei e averli usati contro bersagli già ampiamente bucherellati, al momento di tirare le somme si afflosciano di colpo. La conclusione, infatti, non può che essere la ritirata nel guscio accogliente del privato, oppure la fuga dalla città, al massimo per scriverci sopra qualche libro che ne illustri a volo d’angelo gli aspetti antropologici e di costume – un modo come un altro per accettarla così com’è.
Quest’ultima è appunto la strada che imbocca Pascale. Egli stesso ci dice che esiste una terza via: quella di rimboccarsi le maniche, insediarsi in un punto qualsiasi della città e provare a darsi da fare. Non è un’opzione che il nostro autore prende in considerazione, ma non è questo che ci sentiamo di rimproverargli, quanto piuttosto la scelta che sta a monte di un libro del genere, il suo restare in superficie, saltabeccando con maestria da un punto all’altro della mappa, senza mai tentare l’immersione, l’esplorazione di strade meno levigate ma più promettenti, e comunque alla portata di un bravo e coscienzioso scrittore. Senza mai “scendere” davvero – appunto – all’altezza della realtà indagata. (luca rossomando)



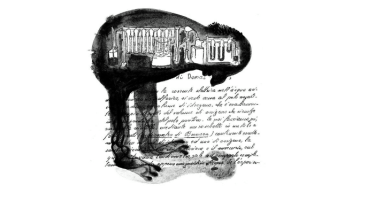

La lucidità di uno che sa di cosa scrive e che scrive di ciò che conosce.
Complimenti, Luca.