
da: Horatio post
Due grandi foreste ha la città, a oriente e occidente, ecosistemi e mondi completamente diversi, dove puoi veramente ancora perderti nel verde, e ognuna ha una storia, e un futuro possibile da raccontare. Se Capodimonte è il bosco del re, restituito ora alla città nella sua magnificenza, il Parco urbano dei Camaldoli è il bosco repubblicano, un lembo di selve appenniniche che miracolosamente si incunea tra i vulcani, figlio di storie e conflitti più recenti.
Il Parco dei Camaldoli è esteso quasi quanto Capodimonte, circa cento ettari, ma pochi napoletani ancora lo conoscono, e infatti non incontriamo nessuno, in questo sabato di primavera, camminando i sentieri tra le grandi ceppaie di castagno con Riccardo Motti, il direttore del Real Orto Botanico di Portici, solo pochi cani ansimanti e felici, a spasso coi padroni. Riccardo è alto, pacato nella voce e nei gesti, ha la figura di un moschettiere, accarezza con gli occhi il groviglio vegetale, si china su un’Ajuga, una pianticina elegante del sottobosco, dai fiori blu, sta crescendo all’ombra di un cespo giallo di ginestre, tra gli steli verdi e freschi di festuca. «È la bordura perfetta di un giardino, solo che il progettista è la natura, hanno iniziato gli inglesi a imitare nei loro giardini queste combinazioni spontanee, assolutamente perfette. A queste specie e a queste composizioni mi sono ispirato ora per realizzare i giardini del museo di Pietrarsa».
Il bosco dei Camaldoli è questo, una miniera di continue, piccole sorprese di biodiversità, negli anni Riccardo le ha censite e studiate proprio tutte, ed è qui che devi venire allora, se davvero vuoi capire il senso delle primavere e degli autunni sulle colline di Napoli, coi gruppi di violette e ciclamini, e il tappeto color cielo della pervinca, le orchidee spontanee maculate di sanguigno, e la chioma del bosco che vira con la stagione dal verde tenero al giallo oro all’arancio. Nel silenzio del bosco, davanti a noi s’alza all’improvviso in volo una poiana, da vicino appare enorme, mi sembra un segno miracoloso, come in una poesia di Montale, e tutto questo accade a meno di dieci minuti dal frastuono e dal caos brulicante del sabato di città.
Si, il Parco dei Camaldoli è un miracolo, ma è anche il frutto delle battaglie di un ventennio, dalla metà degli anni Settanta, di un pugno testardo e coraggioso di cittadini e associazioni, che vedeva questo tesoro erodersi giorno dopo giorno per le lottizzazioni abusive, le frane, le antenne selvagge, le discariche, le cave, gli incendi, e lottò per l’acquisizione pubblica, per conservare alla collettività ciò che restava, dopo le mani sulla città, delle millenarie e gloriose selve flegree.
Ed allora sono venuto al Vomero, nella bella casa di Pio Russo Krauss, pediatra, il nostro maggiore esperto di medicina pubblica, gli ho chiesto di raccontarmi ancora una volta come andarono le cose, e lui pazientemente ha recuperato i dossier, le denunce, insieme a fasci di vecchie, bellissime foto. Tutta la vicenda è riassunta in un dattiloscritto ingiallito: Camaldoli: una collina indifesa. La prefazione è di Ugo Leone, le foto oramai sono macchie sbiadite, ma è una delle testimonianze più importanti dell’ambientalismo napoletano, leggo i nomi degli autori, con Pio c’erano Giovanni Lubrano Di Ricco, Hermes Ferraro, Nicola Gaglione, Corrado Garbi, Gigliola Golia, Roberto Langella, Enzo Miano, Casimiro Monti, Roberto Radice, il grande Francesco Luccio.
Sull’onda della pressione pubblica il parco viene istituito nel 1981, è Giovanni Dispoto, giovane urbanista del comune, a suggerire al vicesindaco Di Donato di impiegare un residuo di fondi della Cassa del Mezzogiorno per espropriare i suoli e realizzare recinzioni e attrezzature, ma ci vorranno comunque più di quindici anni per il faticoso completamento dei lavori.
In ogni modo ora il parco c’è, ma non sappiamo che farne, ed è proprio in quell’opuscolo ingiallito del 1986 che è lucidamente descritta la principale difficoltà, che è poi quella “della gestione dell’area, col rischio quanto mai probabile che, una volta ultimati i lavori, il parco resti chiuso a degradarsi, poiché non si sa chi e come deve gestirlo”. Si tratta di parole che a distanza di trent’anni suonano profetiche perché, da allora, un sistema di gestione dell’antico bosco non è mai stato definito, il ceduo non è stato curato e tagliato, e ora sta morendo, con le ceppaie che si spengono una a una, in un intrico selvaggio di pali avvinti dall’edera, che franano e smottano giù tristemente, assieme a lingue di terra, in uno sfacelo grandioso, da giungla tropicale.
«In realtà gli ecosistemi non si fermano mai» mi dice Stefano Mazzoleni, ecologo vegetale della Federico II, che allo studio di queste dinamiche lavora da un trentennio. «Se la cura del ceduo, dopo duemila anni si interrompe, il bosco abbandonato troverà un suo nuovo equilibrio, il castagno muore e arriva la roverella, o magari specie aliene come l’ailanto, ma la fase di transizione dura decenni, nel frattempo anche la geomorfologia e i suoli si mettono in moto, con le frane e le erosioni, prima che un nuovo equilibrio si instauri». È evidente che una cosa simile può andar bene forse per l’appennino rimasto senz’uomini, non nel cuore della terza città d’Italia, visto poi che il dissesto della collina, col fuoco, le acque selvagge e le frane, minaccia la sicurezza dei nostri quartieri più popolosi, Pianura e Soccavo, assieme agli agglomerati di Marano e Quarto, malamente cresciuti senza regole, giusto al piede dei versanti.
Come poi spesso accade in Italia, a complicare le cose ci si mette anche la selva delle leggi, più intricata di quella vegetale, perché i castagneti dei Camaldoli, essendo un parco pubblico, non rientrano nella definizione giuridica di “bosco” secondo le leggi forestali, «e questo crea un equivoco colossale», mi spiega Fabrizio Cembalo Sambiase, agronomo paesaggista, «perché ci si illude di poter gestire l’area come fosse un giardino pubblico qualsiasi, dimenticando che si tratta pur sempre di un bosco, che come tale va trattato e curato».
Fabrizio di queste cose ha lunga esperienza, gestisce i vasti castagneti di famiglia, sui versanti del Monte Stella, in Cilento. Per il comune di Napoli ha redatto nel 2005 un piano di gestione del Parco dei Camaldoli, mi mostra le cartografie dettagliate, l’idea era quella di fare del bosco una grande azienda forestale multifunzionale, per la produzione di pali e assortimenti legnosi, assai richiesti per l’ingegneria naturalistica e i pergolati agricoli tradizionali, e di energia rinnovabile, con gli scarti forestali che diventano prezioso combustibile, in grado di riscaldare un polo ospedaliero, o un grande plesso scolastico. Si creerebbe così lavoro per una cooperativa giovanile, sul modello della Paranza, alla Sanità, con il risultato di tenere in ordine, perfettamente fruibile il bosco, accompagnare i visitatori, governare le acque, fare la manutenzione dei versanti e dei suoli, prevenire gli incendi, proteggere la fauna e la biodiversità.
Il piano di Fabrizio è finito in un cassetto, e invece sarebbe il caso di recuperarlo in fretta, perché proprio mentre sto scrivendo, il comune ha provveduto a interdire a tempo indeterminato il grande parco al pubblico, i cancelli di Camaldolilli, Ignazio di Loyola e dell’Eremo li trovi mestamente chiusi, con la motivazione del rischio di schianto degli alberi e della mancanza di personale, che poi è il gatto che si morde la coda, perché è evidente che senza manutenzione la città ti si ritorce contro, nelle sue parti in pietra come in quelle verdi: diventa impraticabile, ostile, e la soluzione non può essere ogni volta quella di dismettere progressivamente i luoghi dei quali non riusciamo più ad aver cura, abdicando sistematicamente all’incapacità e all’impotenza.
Così, le due grandi foreste urbane continuano a parlarci della città e di come siamo, e dei futuri possibili, con il bosco di Capodimonte a mostrarci che c’è ancora forse occasione di riscatto, di migliorare la vita delle persone, offrendo loro nuove opportunità e servizi, e diritti concreti di cittadinanza; e il Parco dei Camaldoli che è invece la pagina scura, quella del declino della città pubblica e del suo governo; di un’amministrazione che chiude uno alla volta ai cittadini i paesaggi e gli ecosistemi più fragili e belli, che è poi, al netto di chiacchiere e slogan, la forma più desolante e intollerabile di povertà. (antonio di gennaro)



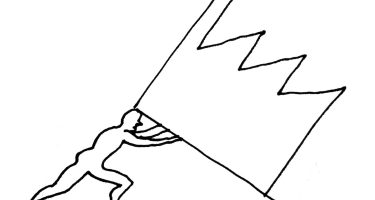

Leave a Reply