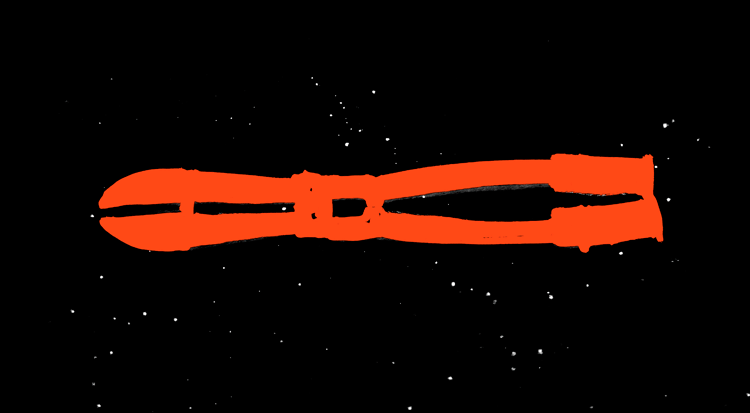
Un mese fa erano vent’anni dall’occupazione del Damm, centro sociale a Montesanto. Un luogo che ancora esiste, spinto avanti nel tempo da un’inerzia sempre più flebile. Una delle sue caratteristiche, inedita per i posti occupati a metà degli anni Novanta, era il lavoro di animazione, e in generale la vicinanza con i bambini e gli adolescenti del quartiere. Quel modo di stare con i ragazzini aveva qualcosa di antico – a cinquanta metri dal Damm era sorta la Mensa bambini proletari nei primi anni Settanta – ma anche di nuovo e promettente. Un piccolo gruppo di giovani, con scarsa preparazione in quel campo, cominciò a organizzare la propria formazione, invitando educatori e artisti a tenere dimostrazioni, spettacoli e seminari. Bruno e Rosellina Leone vennero a insegnarci come costruire burattini e guarattelle con materiali poveri, Ugo Pugliese (non) ci svelò i segreti dei giochi di prestigio e della magia, Peppe Carini ci mostrò alcuni giochi all’aperto, Francesco Silvestri l’arte di narrare le storie, Pasquale Amato alcune tecniche per i laboratori teatrali, Linda Martinelli le danze e gli esercizi con il corpo, Felice Pignataro fece un murales con i bambini, Laura Magrassi diede un saggio dei suoi laboratori per i più piccoli, e così via. Altri ancora venivano invitati a discutere, in assemblee più allargate, su quel che stava accadendo in quegli anni nell’ambito del cosiddetto lavoro sociale: le esperienze ancora isolate in periferia, il dibattito sui finanziamenti pubblici, il rapporto con la politica e con le istituzioni.
In modo parallelo, il gruppo cominciò a mettere a frutto con i bambini quegli insegnamenti e nacquero così giochi, laboratori, scambi e inviti reciproci in altri luoghi e occasioni. Allo stesso tempo prendeva corpo una riflessione su come posizionarsi in quel panorama, che vista l’attività quotidiana nel quartiere sembrava riguardarci sempre più da vicino. Il lavoro sociale era percorso proprio allora da una sorta di frenesia e nel giro di poco tempo cambiò radicalmente volto.
Uno dei capisaldi del lavoro, in linea con la concezione che avevamo del centro sociale, era di non chiedere soldi a nessuno, né di partecipare a bandi o gare che mettevano in concorrenza le diverse cooperative e associazioni. Per quel che ci serviva, bastava l’autofinanziamento. Apprendevamo il mestiere, ma rifiutando lo status del “professionismo” che si andava stabilendo allora, a cominciare da quel lessico pieno di eufemismi e banali etichette usate come rivestimenti della realtà, a volte brutale, in cui s’interveniva: un vestito “nuovo” che da un giorno all’altro indossarono tanti coetanei e compagni d’avventura. Ci concentrammo piuttosto su come approfondire la relazione con i ragazzini e con le loro famiglie, ma anche sul tipo di responsabilità che questo comportava e sui limiti imposti da quei punti fermi a cui non volevamo rinunciare.
Forse ci facevamo troppe domande, mentre altrove si procedeva senza andare troppo per il sottile; forse eravamo poco ambiziosi, o troppo pigri, ci accontentavamo di passare dei buoni pomeriggi inventando qualche gioco insieme ai bambini, o seduti su un muretto ad ascoltarli, per chiarirci le idee su mondi che non conoscevamo affatto. Programmavamo ogni cosa, anche a lungo termine, ma ci bastavano accordi di corto raggio, con la scuola, con le famiglie, con gli stessi ragazzi, per garantirci l’incontro quotidiano, la continuità della nostra presenza. Le affinità su questo tipo di impostazione si fecero sempre più rare, ma le soluzioni a certi quesiti non potevamo trovarle da soli, certe strade bisogna percorrerle in compagnia. L’esperienza rimase ristretta a chi ne era stato direttamente coinvolto, un bagaglio buono da usare anche in altri contesti, e infatti nel giro di qualche anno ce ne servimmo un po’ tutti, ma ormai lontano da Montesanto.
Altrove si pensava in grande, ci si espandeva, si “gestivano” più soldi, e sempre più persone; l’attenzione degli adulti si spostava un po’ alla volta dai ragazzini – ma anche dai disabili, dai matti, dagli anziani – al progetto da presentare, ai parametri del bando, al mandato dell’istituzione da rispettare; la priorità divenne tenere in vita l’associazione, la cooperativa, la comunità, anche quando il senso delle proprie azioni cominciava a sfumare, e tutto convergeva verso la pura e semplice auto-riproduzione. Certo, qualcuno aveva in mente interventi innovativi, e l’ambizione di influire sulle politiche, di cambiare davvero le cose attraverso strumenti che in quegli anni acquisivano una portata mai raggiunta prima; bisognava stare al gioco, sostenevano, starci dentro fino in fondo per ottenere risultati buoni per tutti. In quegli anni era un approccio che non ci convinceva, mentre oggi possiamo riconoscerlo, e anche apprezzarne alcune realizzazioni. La realtà, però, è che oggi anche le esperienze più virtuose nate in quel periodo si sono ritratte spaventosamente; i territori conquistati a fatica sono andati perduti, e nelle retrovie c’è lo stesso sbandamento che altrove.
Il prosciugamento del welfare italiano e meridionale sta segnando di fatto la scomparsa dei mestieri di educatore, animatore, operatore sociale, e insomma di tutte quelle figure professionali emerse con la crescita abnorme del settore non profit, portandosi via le illusioni di chi aveva creduto di poter vivere con un lavoro bello, quasi nobile, e uno stipendio fisso, quasi intero – sempre con un piede dentro e uno fuori, però; nel caso di complicazioni –, e tra questi tante persone oneste e preparate, che adesso sono le prime a scivolare via, mentre i più disincantati fanno finta di niente cercando qualche appiglio, e si può stare certi che saranno gli ultimi a staccarsene.
E proprio nell’ambiente di quelli che stavano allora, o che stanno ancora, dentro o intorno ai movimenti sociali, qualche barlume di consapevolezza, forse tardivo, comincia a farsi strada, insieme alla rabbia e allo sbigottimento per le attese tradite. Non qui a Napoli, purtroppo, dove una riflessione costruttiva su quel che è accaduto in vent’anni è ancora secondaria o terziaria rispetto alla rivendicazione di denari sempre più ipotetici, o al lamento puro e semplice, senza altre prospettive. A Milano invece un gruppo di operatori si è riunito in un cantiere sul “mal di lavoro”, in cui lavoratori e lavoratrici delle imprese sociali hanno cominciato a narrare e analizzare in prima persona le esperienze fatte e quelle in corso. Il primo incontro si è svolto il 22 dicembre del 2013 nello spazio del PianoTerra, con una quarantina di persone, la maggior parte provenienti da Milano ma qualcuna anche da altre provincie e regioni del centro-nord. A quel primo incontro ne sono seguiti otto, all’incirca uno al mese, sempre nello stesso posto. Il libro La rivolta del riso. Le frontiere del lavoro nelle imprese sociali tra pratiche di controllo e conflitti biopolitici, curato da Renato Curcio per Sensibili alle foglie (2014), è un tentativo di mettere ordine nei materiali prodotti e offrire degli spunti per andare avanti in questa esplorazione di un universo andato in frantumi, forse per decidere di abbandonarlo o per provare a ricostruirne i pezzi, ma in un modo del tutto diverso.
Le parole dei partecipanti al laboratorio definiscono dapprima il contesto, il salto enorme tra le esperienze pionieristiche degli anni Settanta, promosse da chi “aveva per così dire ‘un problema col mondo’ – nota il curatore –, con quella società capitalista che era la vera fonte del malessere individuale dei primi utilizzatori di quegli improvvisati servizi”, e le odierne imprese sociali, che, racconta un operatore,“ti dicono che il problema non è nel mondo ma nella persona…”.
Da queste premesse, tra le tante conseguenze, la guardia bassissima tenuta dalle imprese sociali nei confronti dell’istituzione che affida il servizio, che spesso è un’istituzione totale e come tale preme per subordinare gerarchicamente tale lavoro. “Sempre più – scrive Curcio – le comunità orientate verso la libera accoglienza vengono considerate inaffidabili. Le pressioni del Servizio sociale istituzionale sugli operatori della comunità affinché garantiscano turni di notte, vigilanza continua e fax di denuncia pongono a chi gestisce queste imprese una domanda: siete abbastanza affidabili o dobbiamo rivolgerci ad altri? Una domanda insidiosa che allude apertamente anche a un ricatto economico”.
Le storie individuali tracciano così il profilo paradossale di un lavoratore che si muove in ambiti estremamente differenziati, dai centri estivi per bambini ai penitenziari, dalle comunità di accoglienza per minori agli ospedali psichiatrici, spaziando tra compiti educativi e di animazione, fino a quelli di sorveglianza, contenimento e controllo, alle prese con una umanità variegata e con esigenze, codici di condotta, abilità richieste sideralmente differenti tra loro. Eppure, con il passare del tempo, tale profilo è andato suo malgrado uniformandosi, e sempre più sbiadendo: l’attitudine flessibile, la natura polifunzionale e intercambiabile, al di là di ogni eventuale qualificazione (anche se le nuove norme, fuori tempo massimo, insistono su titoli e certificazioni); la disponibilità a lavorare senza protezione normativa, talvolta senza contratto, con salari bassi o bassissimi, spesso differiti nel tempo; e poi la confusione ipocrita con il militante di una causa, di una missione di vita, operata dai superiori, ma talvolta dagli stessi operatori pur di non interrompere il lavoro; questi e altri fattori compongono un’identità incerta, lontana dai sindacati e soprattutto da quella “sicurezza di rappresentanza” che dovrebbe caratterizzare ogni lavoro dignitoso.
Per quale obiettivo ultimo agisce l’operatore sociale, quello di integrare le persone nelle istituzioni esistenti oppure di metterle in conflitto con le istituzioni stesse? Come deve comportarsi quando i cosiddetti utenti si oppongono al suo intervento, perché evidentemente non lo desiderano, non lo ritengono adeguato alle proprie esigenze o lo considerano addirittura punitivo e umiliante? Vengono prima i valori che l’operatore considera propri o quelli imposti dal ruolo e ribaditi dal mandato dell’impresa che lo impiega e dell’istituzione che lo delega a operare?
Somigliano molto alle domande che ci facevamo un tempo e che ci lasciavano sempre qualche angolo scoperto, come una coperta troppo corta, ma sono anche le stesse che ritornano nelle testimonianze, talune ai confini della realtà, snocciolate in questo esperimento di “socio-analisi narrativa”, come la definisce il curatore. Episodi in cui tali dilemmi sono portati al parossismo, in un crescendo di tensione che coinvolge colleghi e superiori, insegnanti, assistenti sociali, dirigenti dell’impresa o altri referenti, e che quasi sempre generano compromessi al ribasso, frustrazione, accettazione pura e semplice delle condizioni date, quasi mai un rifiuto; al massimo un’uscita di sicurezza per resistere in qualche modo senza rischiare il posto.Si tratta spesso di strategie di sopravvivenza basate sulla dissociazione, sullo sdoppiamento dell’identità,in cui la militanza politica o il lavoro intellettuale si riducono a miseri alibi per credersi ancora integri, diversi, accettabili prima di tutto a se stessi; un autoinganno che permette di affrontare pratiche e complicità che in condizioni normali sarebbero decisamente rifiutate. Fino al ricorso estremo, quello di “spegnersi” (“Io mi sono spenta!”, racconta una delle partecipanti, segnalando una forma dissociativa tipica di chi opera in contesti estremi, come carceri o manicomi).
Alla fine del libro spunta anche qualche esperienza di opposizione, di sindacalizzazione quasi clandestina, di condivisione creativa, di festa. Il tono generale però resta pesante, connotato dalla riproposizione di scelte drammatiche alle quali non si sa come sfuggire. Questa sorta di accumulo aiuta a mettere in chiaro che siamo al punto di non ritorno, e quindi la necessità di cambiare rotta. Eppure, la nostra esperienza a queste latitudini prevede anche esempi di accomodamenti, che pur nello sfacelo, nella disfatta totale delle premesse e degli obiettivi, consentono di mandare avanti la baracca, tenendo sotto il livello di guardia le nevrosi e le tensioni. Fatto sta che gli esempi finali sollecitano qualche domanda sul futuro, sull’alternativa. Vengono prefigurate così “comunità cooperanti a partire dai luoghi in cui si svolge la propria vita quotidiana, come controtendenza allo smantellamento del sistema di protezione sociale istituzionale”. Rispunta la possibilità di un’alleanza tra utenti e operatori, o per dirla con parole più vere, l’incontro tra persone al di là di ruoli e gerarchie, oltre l’ipocrita “distanza” professionale; un’alleanza che richiede di mettersi profondamente in gioco, di pronunciare dei chiari rifiuti e di lanciarsi senza paura in ambiti non ancora definiti.
Passati vent’anni, il cerchio si chiude. Si ricomincia dai principi alla base di tanti centri sociali di un tempo. Niente di eclatante: il piccolo gruppo, l’apertura verso l’altro, lo scambio mutuo, la costruzione di alternative. Forse, in tanti potevano pensarci per tempo. In ogni caso, non sembrano esserci più alternative all’isolamento. E allo “spegnimento” definitivo. (luca rossomando)



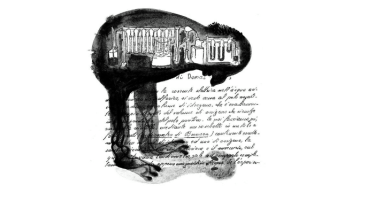

si credette che portando il resto delle persone, della società, verso i luoghi della sofferenza e del disagio essi avrebbero aiutato, forse risolto. Era il principio di un’idea progressista della storia, dove chi stava male lo era perché non era stato ancora raggiunto dalla “grazia” dello sviluppo, a causa delle inefficienze, dei ritardi, delle ingiustizie. E invece poi si scoprì un’ovvietà che la disperazione ci rendeva poco visibile, e cioè che questo disagio, quelle sofferenze erano causate dallo sviluppo, chiamiamolo così, dal modello sociale acclamato o cmq assecondato. Esso lo produce, lo utilizza, lo gestisce e quindi noi si aveva creduto male a chiamare quei pompieri, quei loro delegati, perché essi stessi appicavano il fuoco le cui fiamme si rispecchiavano sui nostri volti, brucianti, e ci rendevano non martiri, non fantasiosi, non ingenui ma tragici buffoni se visti dal punto dell’incendio, di chi bruciava per davvero. Ora che il tempo è passato, insieme ad altri che pure hanno visto da vicino l’incendio, siamo però almeno più bravi, più scaltri, più disillusi con le nostre ferite, più umili nei nostri propositi, almeno così credo.