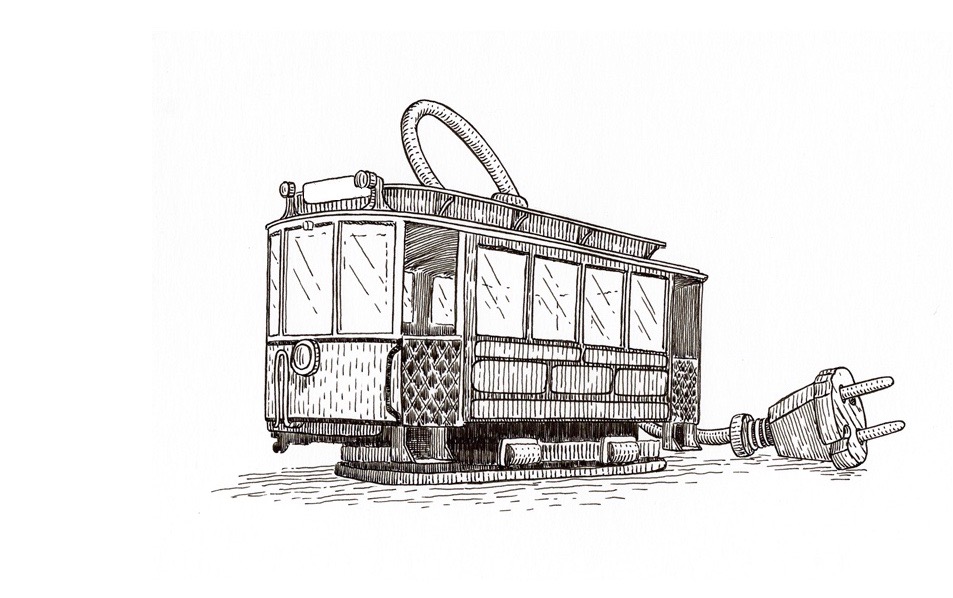
All’indomani della recente sentenza della Cassazione sulla strage di Viareggio (29 giugno 2009: trentadue morti a seguito del deragliamento di un treno cisterna carico di Gpl), abbiamo incontrato a Firenze Ezio Gallori. Protagonista delle lotte dei ferrovieri nella seconda metà del Novecento, Gallori è stato uno dei più accesi oppositori dei processi di privatizzazione delle Ferrovie e della progressiva dismissione della sicurezza per viaggiatori e lavoratori. Gallori, macchinista in pensione da molto tempo, è ancora attivo con la rivista In marcia!, organo di informazione autogestito dei macchinisti ferroviari. Per protestare contro la sentenza della Cassazione, è prevista una manifestazione venerdì alle ore 16 sotto la Prefettura a Firenze, via Cavour 1.
Come hai vissuto questo nuovo capitolo giudiziario della vicenda di Viareggio?
Il tema della sicurezza l’ho sempre vissuto in prima persona. Il primo articolo che scrissi nel 1964 su In marcia!, diceva: “Sicurezza e responsabilità”. Lavoravo da quattro anni come macchinista e mi resi subito conto che per la sicurezza va stabilito il responsabile, perché tutte le responsabilità già allora – e ora non ne parliamo – ricadevano sul personale operativo.
Ti confesso che mi ero illuso, a ottantatré anni, che finalmente ci fosse un dirigente delle Ferrovie condannato. Non è successo, come invece è successo in Francia a un sottosegretario delle Ferrovie. Io sono entrato nel ’57 e ho seguito cento e quarantadue incidenti ferroviari, li ho contati; li ho seguiti come sindacato, ogni volta che c’era un incidente trovavi minimo un articolo sull’In marcia!, se dopo c’era un morto ce n’erano due di articoli e c’era anche la fotografia, tanto è vero che prima di andare in pensione ho contato cinquantaquattro macchinisti morti in incidenti ferroviari. Moretti [amministratore delegato di Ferrovie dello Stato dal 2006 al 2014] diceva: “No, non sono questi i numeri…”. Gli ho portato le cinquantaquattro fotografie, perché quelli morti avevano il privilegio di essere riportati sul giornale dai compagni di lavoro…
È fondamentale capire cosa è cambiato in Ferrovie. Il primo dato è che dal 1964 al 1985, anno in cui le Ferrovie si trasformano in SpA, noi avevamo avuto in tutto sette macchinisti morti. Dall’85 ai primi anni Duemila, ce ne sono stati altri cinquanta. In quindici anni cinquanta, in trent’anni cinque. Perché prima la Ferrovia aveva la sicurezza assoluta. Questa sicurezza assoluta era un’ossessione dei ferrovieri, dei macchinisti in particolare. Nelle scuole professionali il punto fermo era la sicurezza. Quando andai all’esame, dopo essere andato benissimo, mi dissero: “Eh, ora c’è i regolamenti, lei lo sa, se sbaglia un regolamento lei non diventerà macchinista, perché non si deve sbagliare, il macchinista non può sbagliare, può sbagliare che brucia la macchina, non si ripara, va bene, ma la sicurezza è una cosa sacra”. Questa sacralità si è tenuta fino al 1985. Il primo trasformatore fu Schimberni [Mario, già presidente FS], il quale disse: “Ma perché si deve avere questa ossessione sulla sicurezza? Facciamola noi la sicurezza”. E cominciò a studiare, a fare documenti. L’uomo che curava queste cose si chiamava De Palatis, cominciò a creare una struttura e una cultura della sicurezza probabilistica. Da sicurezza assoluta a sicurezza probabilistica. E qui è cominciata a morire la gente… La sicurezza prima era garantita da una boa; c’era una struttura, un punto di riferimento, siccome sul ponte c’è la riduzione di velocità da 140 a 110 km/h, se il macchinista pensava a un’altra cosa c’era la boa, un sistema di sicurezza assoluta che ti diceva: “Velocità critica, ferma ferma!”. Se te non eseguivi, automaticamente ti fermava la macchina e ti riportava dentro la curva di sicurezza. In tutti i processi che hanno fatto non è mai stata individuata una responsabilità dell’azienda: capistazione, macchinisti, errori umani, tutto era sempre errore umano.
Torniamo ai processi di ristrutturazione, anche per capire come si arriva a un evento come quello del 2009.
Vengo al sodo. Questa ristrutturazione delle Ferrovie, oltre ad aprire verso questa sicurezza probabilistica, ha comportato anche tagli di personale. Nel 1964 c’erano 225 mila ferrovieri e il bilancio era in pareggio. Ora ce ne sono 60-70 mila. Però il bilancio, se si dovesse fare il bilancio reale, sarebbe sempre negativo. Perché le Frecce hanno un bilancio attivo, ma è come uno che di una vitella vende le bistecche e piglia i quattrini, c’è anche gli scarti. E i pendolari li paga la Regione. Se tutte le regioni che contribuiscono al pagamento dei pendolari si mettessero in fila, oggi il bilancio delle Ferrovie sarebbe negativissimo.
E i treni merci? In quella fase è cambiato che la dominazione degli Agnelli, auto e gomma, ha prevalso e mentre ai miei tempi a Firenze c’erano quattrocentodieci macchinisti adibiti al servizio merci, ora non ce n’è nemmeno uno. Nemmeno uno. Perché quei pochi treni merci che ci sono, pochi, sono di ditte che pigliano un appalto, non c’è più un servizio merci. Prima il servizio merci andava intorno al trenta per cento; il trenta per cento delle merci nazionali veniva portato per ferrovia. Ora siamo al tre-quattro per cento, e soprattutto merci povere, cioè legni, ingombranti e cose simili.
Un ingegnere, tale Romagnoli, Rino Romagnoli, aveva inventato un carro che portava i tir, cioè i tir entravano su questo carro, il conducente dormiva tutta la notte e la mattina in un minuto si scaricavano. Ora invece tutto viene trasportato in autostrada, le code, si consuma… C’era un prete, Don Chiavacci, che addirittura quantificava i soldi, quanto si spendeva di più portando coi camion, la Ferrovia ‘un costa nulla… C’erano dei locomotori, si chiamavano “424”, li avevano portati gli americani col Piano Marshall, che avevano una targhetta con scritto “L’America ai popoli liberi dona”, e noi si levavano le targhette perché non ci piaceva questo regalo americano, ancora negli anni Sessanta. Però queste macchine erano ecologiche, che quando si arrivava in cima a Porretta, per anda’ a Bologna c’è la salita e poi la discesa, quando si arrivava in cima non solo non si consumava, ma i motori diventavano dinamo che ributtavano la corrente per aria. Questi sviluppi tecnologici non sono stati privilegiati dalle Ferrovie. L’ingegnere Romagnoli è stato licenziato, perché non piaceva un servizio efficiente e a basso costo. La politica dei rami secchi si chiamava: “Questo non rende: chiuso”. Non rende? Un cazzo! E chi ce la porta in cima alla montagna questa gente se non ci arriva il treno?
Ho fatto anche delle denunce alla magistratura su queste circolari che incitavano la gente a non guardare la sicurezza, a guardare il prodotto. Dice: “Il prodotto non è solo la sicurezza, il prodotto è che oggi bisogna correre, bisogna risparmiare!”. E con questa ideologia la boa del ponte è stata levata. Poi hanno cominciato a tagliare i posti, a cominciare dal secondo macchinista. Hanno preferito mettere quello che pulisce i gabinetti, perché le signore ci hanno cacato sopra, e levare il macchinista. Meglio un gabinetto pulito che una sicurezza in più, perché l’immagine… Costa 0,005 una persona in più sopra, e guarda che è fondamentale. Io ho avuto il piacere di non andare mai ad agente unico, perché i macchinisti, fino a che ci sono stato io, hanno resistito. Dopo, il mondo, a cominciare dai sindacati, ha detto: “Beh, l’economia, eh, questi costano!”. E hanno cominciato a tagliare, prima i macchinisti, dopo i capistazione… Allora a tutte le stazioni c’era il capostazione, che quando passava il treno mandava il manovale da quell’altra parte con la bandiera rossa, e lui stava di là, perché se c’era un carro che prendeva fuoco o bruciava un cuscinetto, quello con la bandiera era subito pronto. Uno di qua e uno di là, a tutte le stazioni, era fondamentale. E invece hanno cominciato a tagliare prima il manovale e dopo anche le stazioni.
Cosa pensi del processo di Viareggio?
Uno dei sistemi perché se la cavano è che il CTU, l’uomo che dà il resoconto ai tribunali, è pagato dalle Ferrovie. L’ingegner Diana nel caso di Viareggio, un docente del Politecnico di Milano, il quale ha sempre aggiustato le cose a favore delle Ferrovie. L’altro problema è riconducibile alle parti civili. Non c’è stata mai una parte civile prima di Viareggio e anche a Viareggio hanno tentato di far desistere le persone. Quindi il processo ha avuto problemi in sede di perizie ed è stato sostenuto solo fino a un certo punto come parti civili. Il problema vero è che c’è una mancanza sociale. Qui ci voleva, dopo questa sentenza, uno sciopero di tutti i lavoratori, ma questo non riguarda le Ferrovie, riguarda un concetto di responsabilità che viene scaricato sempre sulle seconde e terze file; o pagato per modo di dire. Questa volta avevano colpito giusto: basta con gli errori umani, sulla sicurezza si risparmia, un macchinista solo, tanti chilometri… Ora c’è una moria di macchinisti, perché lavorano tanto. Quello che io facevo in un mese, facevo 3.500 km in un mese, lo fanno in un giorno. E allora, dai dai dai… È vero, ora si sta a sedere e si pigia i bottoni, ma andare a 300 km/h vuol dire avere gli occhi aperti, guardare, vedere: la macchina ha un limite, dopo ci vuole il cervello umano.
L’incidente ha sollevato anche il problema del collaudo e della manutenzione, che ne pensi?
Prima di mettere in giro i carri che venivano dall’estero, c’era a Milano un Ufficio collaudi dove tutti i carri, tutti i veicoli, dovevano essere collaudati con l’ultrasuoni, per vedere se erano perfetti. A questo ufficio ci mettevano gente qualificata, ci mettevano i più bravi, perché era fondamentale che i veicoli fossero perfetti, perché se c’è qualche cosa non perfetta, prima o poi viene fuori. E non si può sbagliare. Noi ora non abbiamo dirigenti che viaggiano con programmi a lunga gittata, oggi ci sono dirigenti d’assalto, che vogliono fa’ bella figura: “Io risparmio, risparmio, risparmio!”. È come la politica del “lasciapoderi” di prima, del Chianti a mezzadria. Quando il contadino lasciava il podere, lo lasciava dicendo: “Quest’anno è l’ultimo”, e non faceva più nulla, non curava più nulla.
Tutta la manutenzione non esiste più in Ferrovia. Io ogni volta che partivo mi davano quarantacinque minuti per visita macchina, dovevo guardare se i cerchioni stavano bene, facevo la prova del freno, sopra andavo a fare le prove. Quando arrivavo, mi davano altri quarantacinque minuti per vedere se tutto era regolare. I tempi accessori questi erano. Dopo li ridussero: venti minuti. Ora non danno più nulla. Tu monti sopra e se si guasta sei fermo.
Prima la sicurezza delle Ferrovie era basata non sulle macchine ma sugli uomini, e per succedere un incidente ci volevano tre errori di persone: capostazione, che doveva controllare gli incroci, capotreno, che doveva confermare gli incroci, e il macchinista. Se sbagliavano tutti e tre poteva avvenire, ma bastava che due, o uno, non sbagliassero e l’incidente non sarebbe avvenuto. Ci voleva il consenso di tre persone, e si perdeva tempo, si perdevano tre minuti. La boa del ponte di Piacenza faceva perdere sette secondi. Allora: “Bah, sette secondi? Ma scherziamo davvero?”, e beccatevi l’incidente!
Gli avvocati di Viareggio, quando uscirono mi dissero: “La sentenza è perfetta e regge sicuramente”. Chi è che ha il coraggio di dire che i dirigenti non sono più responsabili dei disastri della sicurezza? Pigliano tanti soldi perché c’hanno tante responsabilità, non vorranno mica prendere i soldi e le responsabilità darle a qualcun altro? Purtroppo gli stessi macchinisti hanno venduto l’anima. Oggi un macchinista che fa dieci ore di notte da solo, lo pagano, prende i soldi. C’è dei giovani che sono entrati ora che prendono tremila, tremila e cinquecento euro, quanto un professore, non so se rendo l’idea. Ai miei tempi c’era una cultura di classe, di sicurezza. Io non ho mai fatto un minuto di straordinario, lasciavo i treni. Ho dormito a Compiobbi, dovevo fare un treno da Roma a Firenze, dovevo fermare a Campo Marte ma avevo superato le ore a Compiobbi, mi so’ fermato a Compiobbi, non so se rendo l’idea. Mi dicevano: “Ma lei, per cinque minuti in più, che vòle che sia”. Ma non è il problema di cinque minuti, era un principio. Oggi i macchinisti, quelli giovani in particolare, vanno avanti.
Come va l’attività della vostra rivista? Quali riscontri avete dai lavoratori?
Ora c’è un rinnovamento, abbiamo quasi cinquecento abbonati nuovi alla rivista, che sono i giovani; si abbonano perché dentro la rivista abbiamo una rubrica tecnica, perché il macchinista deve sapere il suo. E allora siccome non c’è più le istruzioni… Io, per diventare macchinista, ho fatto prima quattro anni di apprendista, e dopo c’era la scuola professionale, nove mesi di scuola prima di rimontarmi sui locomotori. Oggi non fanno niente, li prendono belli e fatti, c’è una ditta a Verona, esterna, pagano 50 mila euro e vanno, e la Ferrovia li prende così, non che gli dice: “Ora ti metto un po’ a prova”. Se la gente sapesse… E poi c’è un grande problema sindacale. Ma perché i sindacati di base non si mettono d’accordo? Usb, Cub, Cobas… ma perché non si rimette in piedi il Coordinamento Macchinisti? Noi l’abbiamo fatto, perché c’era una cultura, eravamo delusi dalla Cgil. E abbiamo fagocitato i sindacati corporativi. Abbiamo fatto scioperi al novanta per cento. La mia vita l’ho spesa per l’unità sindacale, cioè extra-confederale, l’unità di classe. Perché prima c’era, io c’ho le prime tessere. Per un sindacato di classe: Cgil. Federazione sindacale mondiale: Cgil. C’ho tutto, e c’ho un quadro in casa mia, con tutte queste medaglie, dove si vede la storia del sindacato: “Per un sindacato moderno”, “Per un sindacato democratico”… E piano piano siamo diventati un sindacato di regime, hai ‘apito? In due parole, eh, io estremizzo… (a cura di michele colucci e stefano gallo)





Leave a Reply