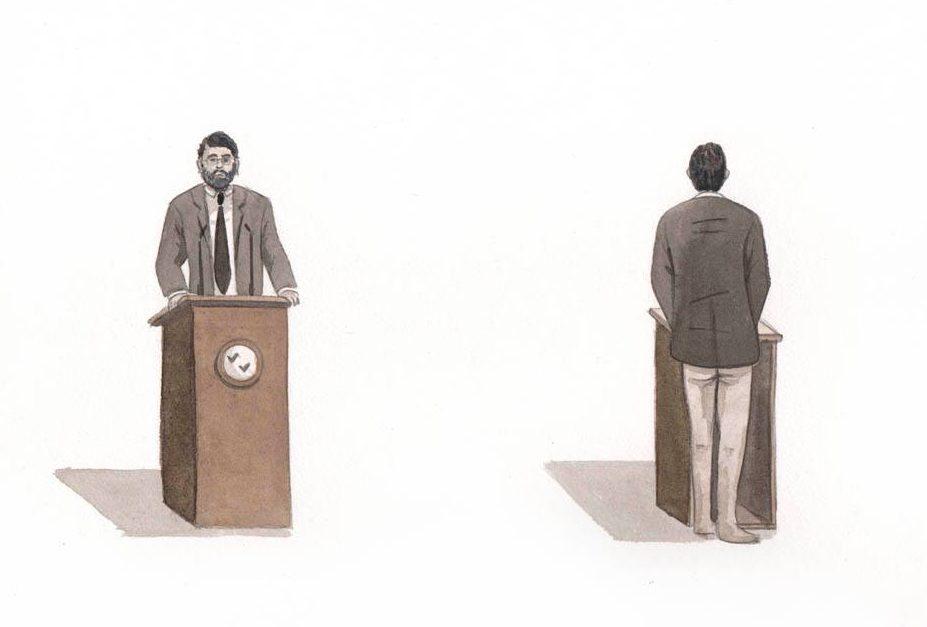
Dinamiche diverse convergono nelle recenti elezioni presidenziali brasiliane, modificando le caratteristiche del blocco di potere storico e le condizioni della lotta. Sarebbe un grave errore ridurre la contesa elettorale all’alternativa tra la riapertura di un ciclo progressista e il prolungamento di quello conservatore. I cambiamenti sono più complessi, e non è facile distinguere continuità e discontinuità.
La scorsa domenica Lula ha ottenuto 57 milioni di voti (48%), sopravanzando Bolsonaro che ne ha raccolti 51 milioni (43%). Siccome nessuno dei due ha raggiunto la maggioranza assoluta, si sfideranno nel secondo turno il 30 ottobre. Con gran difficoltà si potrebbe definire il risultato una vittoria per Lula. I partiti di destra, e in particolare quelli di estrema destra, hanno fatto registrare un’ascesa inaspettata, smentendo i sondaggi della vigilia. Tra gli eletti in parlamento c’è il giudice Sergio Moro, che comandò l’operazione Lava Jato (un’enorme caso di corruzione e riciclaggio che ha coinvolto nel 2014 governo e aziende, portando alla condanna dello stesso Lula, ndt), la maggiore esponente della teoria della “cospirazione di genere”, Damares Alves, l’ex-ministro della salute che negava la pandemia e l’astronauta brasiliano che contesta lo “scientificismo”. Tutti sono stati ministri del governo Bolsonaro. Inoltre, Bolsonaro ha ottenuto più voti stavolta che nel primo turno del 2018, nonostante il logorio di un governo che in quattro anni ha fallito nell’economia, nella lotta alla corruzione, nella gestione della pandemia e nelle questioni ambientali, soprattutto riguardo alla deforestazione dell’Amazonia.
L’unico punto positivo è che, oltre ad avere attivato sostanziali aiuti d’emergenza durante la pandemia, il governo ha prorogato i trasferimenti diretti di reddito per il periodo post-pandemia. Sebbene si sia trattato di una misura elettorale, e compensatrice di fronte alla disintegrazione dei servizi pubblici, Bolsonaro è riuscito a frenare l’emorragia dei suoi elettori verso Lula, al quale la memoria del cosiddetto “periodo felice” (2003-2010) ancora assicura un forte consenso tra gli strati più poveri (e maggioritari) del paese.
In queste elezioni Lula si presenta come il candidato del sistema, mentre Bolsonaro e i suoi occupano integralmente il campo anti-sistemico e anti-politico. Sono loro ad avere il monopolio del discorso di rottura. Naturalmente conducono una rivoluzione conservatrice e la rottura è soprattutto retorica. Nella realtà, si promuove il mantenimento delle diseguaglianze e delle violenze storiche, rafforzando chi già detiene il potere. Il fatto è che, rispetto al sistema di mediazioni che configura lo stato di diritto brasiliano, il sistema politico e il patto sociale soggiacente, Bolsonaro è antisistemico. Può essere considerato profondamente sistemico in un senso storico, ma rispetto al gioco delle mediazioni, il sistema è Lula e Bolsonaro vuole colpire il sistema. È Bolsonaro che parla la lingua del rifiuto, della rottura, della redenzione.
Lula oggi è il candidato dello stato di diritto e riunisce intorno a sé un fronte molto ampio, che include la quasi totalità delle opposizioni di sinistra, grandi rappresentanti di vari settori del potere economico, appoggi internazionali, socialdemocratici storici, Marina Silva (ambientalista, già candidata alla presidenza nelle ultime tre elezioni, ndt) e altri non premeditati sostegni lungo la retta finale. La sua campagna non si è orientata verso la mobilitazione e la polarizzazione. Al contrario, la scelta è stata di non fronteggiare gli elettori dell’altro candidato, di non esporre simboli di sinistra, fino a evitare, negli eventi della campagna, di vestirsi di rosso. Nonostante il partito abbia preparato un documento programmatico, Lula lo ha ignorato nei dibattiti, evitando di includerlo nei discorsi rivolti a elettori e media, sottolineando in diverse occasioni che non avrebbe preso posizione su argomenti polemici, in particolare sull’economia, di fronte all’attuale miscela di recessione, inflazione e aumento del debito statale.
Bolsonaro ha preso una posizione aggressiva contro i grandi media privati (in particolare il principale tra questi, la Globo) e contro la Suprema Corte, oltre a indicare il Partito dei lavoratori (PT) di Lula come una casta politica segnata dalla corruzione. La campagna ha fatto salire il livello della violenza verbale e simbolica, con ripercussioni nelle piazze e tensioni sociali, portando a un aumento della violenza fisica e ad alcuni omicidi. In un paese già tradizionalmente marcato da intimidazioni, ricatti e assassinii dei rivali elettorali nelle periferie della città e nelle regioni dell’interno, l’approccio truculento di Bolsonaro ha portato il paese verso il rischio di una generalizzazione della violenza politica. Lula, invece, si è presentato come il candidato della pace e della pacificazione, sostenendo la necessità di ricomporre gli scontri che si vanno moltiplicando nei vari segmenti della società.
Di fatto, non è prudente prefigurare lo scontro diretto, dal momento che l’opposizione di estrema destra ha cominciato ad armarsi apertamente ed è legata alle milizie e agli squadroni della morte che agiscono nelle periferie. In una delle scene più iconiche della campagna bolsonarista, che tuttavia non può essere ridotta ad aneddoto, un candidato al parlamento è apparso in un video leccando lascivamente la canna di un fucile, prima di uscire con l’arma in pugno per le strade di San Paolo innenggiando a Bolsonaro. Questo miscuglio di elezioni, armi e desiderio di fascismo non si era mai mostrato con tanta chiarezza. Bisogna ricordare che Bolsonaro ha consolidato la propria posizione nella fase finale del ciclo di grandi proteste di massa della decade passata, durante lo sciopero dei camionisti che paralizzò la logistica nazionale nel maggio 2018, quando cominciarono ad apparire slogan su una via d’uscita autoritaria del tipo “intervento armato”, ma anche nella mobilitazione che seguì l’attentato subito nel settembre di quello stesso fatidico anno, quando Bolsonaro ricevette una pugnalata all’addome da un individuo solitario con problemi psichiatrici.
Analizzando i processi a medio termine, si può considerare come una sconfitta anche l’incapacità delle forze progressiste, di centro-sinistra, di costruire un’alternativa alla figura di Lula. In queste elezioni, l’altro candidato competitivo e appetibile per il progressismo brasiliano, è stato Ciro Gomes, un estemporaneo nazional-sviluppista che si proponeva di “ripensare il paese”. Per mancanza di risorse, non è riuscito a resistere alle forze centrifughe della polarizzazione, raccogliendo appena il 3% dei voti. L’opposizone di sinistra da un lato è tornata al fianco del PT, come il PSOL (12 deputati eletti su 513 della Camera), chiudendo il divorzio cominciato quasi vent’anni fa con i “tradimenti” di Lula alla classe lavoratrice; dall’altro ha perduto rilevanza, come il PSTU (troskista), il PCB (stalinista) e il PCO (troskista), che sono rimasti senza nessuna rappresentanza parlamentare. Il campo della sinistra extra-parlamentare non è mai stato tanto chiuso dalla combinazione tra il potere statale e quello dei proprietari, oltre all’aumento della violenza in territori contesi da milizie parastatali e fazioni del narcotraffico (che comandano nelle prigioni).
Si è ripetuto lo stesso teorema elettorale che il PT aveva adottato nelle campagne presidenziali del 2014 e del 2018: nel primo turno preferisce enfatizzare la distanza dagli oppositori più prossimi al suo campo politico-ideologico, confidando di avere maggiore facilità a confrontarsi con la destra (2014) o con l’estrema destra (2018) nel secondo turno. È una strategia pericolosa, che non ha funzionato quattro anni fa, ma che potrebbe funzionare stavolta, se la maggioranza dei voti di Lula venisse confermata il prossimo 30 ottobre. Intanto, il prezzo da pagare è dare spazio al rafforzamento dell’estrema destra antisistemica, che radicalizza il suo discorso di polarizzazione, anche contro la legittimità delle urne elettroniche, i sondaggi elettorali e la copertura dei media, definiti golpisti.
È peraltro improbabile che il risultato favorevole a Lula possa essere contestato da un colpo di stato. Il “partito militare”, ovvero la cupola delle forze armate, ha dato segnali eloquenti: chi vincerà nelle urne andrà a governare. Inoltre, rappresentanti internazionali, per esempio del governo Biden, hanno lasciato intendere in modo inequivocabile che impediranno “resistenze anti-istituzionali”. In passato abbastanza ambiguo al riguardo, lo stesso Bolsonaro sembra gradualmente rassegnarsi all’accettazione dei risultati. Il fatto che i politici di destra e di estrema destra stiano diventando maggioritari alla Camera e al Senato, dove il partito di Lula sarà solo la terza forza numerica, contribuirà se non altro alla disattivazione dei meccanismi che conducono a un colpo di stato. La questione del golpe sta gradualmente perdendo d’attualità, e la disputa tra Lula e Bolsonaro sembra poter rientrare nei limiti definiti dalla legislazione elettorale, nonostante l’alto grado di violenza nella società.
In un orizzonte di analisi più ampio, vi sono tendenze strutturali legate all’evoluzione neoliberale della società brasiliana, un processo profondo e irreversibile in corso da più di tre decadi, che coincide con il periodo della democratizzazione e l’approvazione della Costituzione (1988). Il voto di domenica scorsa ha avuto come principale fattore di aggregazione due tipi di “rifiuti”: l’anti-bolsonarismo da una parte e l’anti-lulismo o anti-petismo dall’altro. C’è però una frazione significativa di voto “affermativo”, tra le fasce più precarie, che si divide tra Lula e Bolsonaro. Secondo il ricercatore sociale del lavoro, Giuseppe Cocco, la classe dei precari in Brasile si è divaricata, ma si tratta comunque di due gruppi di popolazione dai confini sfumati e con alcuni punti in comune.
Il primo gruppo è quello che, sebbene con gran difficoltà, riesce a stabilire alcuni mezzi di mobilità sociale e autofinanziamento attraverso le reti imprenditoriali, il microcredito, il lavoro “uberizato”. Il secondo gruppo, più precario, sta lottando entro la soglia della sopravvivenza ed è dipendente dai trasferimenti diretti stabiliti dai programmi di governo. In queste elezioni, secondo Cocco, si sono divisi tra i voti pro Bolsonaro (più intraprendenti e meno assistiti) e pro Lula (più assistiti dai programmi come il Bolsa Familia). Ciò dimostra come la politica assistenziale è ancora la variabile che decide le elezioni brasiliane, invece di essere decisa da queste.
In ogni caso, la situazione continuerà a essere difficile, qualunque sia il risultato. L’improbabile, però possibile, vittoria di Bolsonaro, legittimerebbe l’assalto al governo dei troll dell’anti-politica, portando a politiche ancora più deliranti di smantellamento dei diritti sociali, distruzione dell’ambiente e sabotaggio sistematico dei programmi di protezione delle minoranze. D’altra parte, anche la più probabile vittoria di Lula tenderà a subordinare l’agenda di movimenti e collettivi alla difesa del governo, che certamente sarà assediato da ogni parte, con un parlamento ostile e un’opposizione sociale estrema e armata, pronta a tradurre l’antagonismo di classe in termini escatologici. La “sinistra globalista” – ovvero chiunque si collochi al di fuori della cornice conservatrice moralista – starebbe minacciando la civiltà cristiana e la famiglia con ruoli di genere stabiliti dall’anatomia.
In entrambi gli scenari, le forze progressiste dovranno realizzare un profondo dibattito interno per ridefinire metodi e obiettivi, provando a riconnettersi con le attese della popolazione e delle reti solidali, che oggi costituiscono il terreno d’azione delle chiese evangelica e cattolica. Non si tratta però di tornare a un malinteso “lavoro di base”, perché la composizione sociale precarizzata funziona in rete, permettendo un nuovo tipo di militanza che tenga conto della fluidità dei territori, specialmente per fronteggiare le teologie della prosperità neoliberale.
La destra e l’estrema destra si consolideranno politicamente, smettendo di essere una “cosa nuova”, come lo erano nel 2018, per diventare una parte imprescindibile del paesaggio brasiliano. Sarebbe un errore vedere in Lula il salvatore della patria; il Brasile non tornerà alla felicità e niente è più lontano dall’attuale congiuntura che il riemergere dei governi cosiddetti progressisti dei primi anni Duemila. L’elezione di Lula non attesta la salute del progressismo sudamericano, ma è un sintomo di stanchezza e depressione post-pandemica, nato in un contesto di disperazione e asocialità.
Nel 2022, l’elezione di Lula, che va appoggiata, significa la possibilità di un’istanza di mediazione e il principio di un disarmo delle tendenze più pericolose e fascistizzanti del tessuto sociale lacerato. L’orizzonte reale delle lotte in Brasile va ritoccato verso il basso. L’elezione di Lula è il terreno per la costruzione di alternative future, il compito che ci spetta. (bruno cava / traduzione di luca rossomando)





Leave a Reply