
Tania è una donna bielorussa che oggi lavora come mediatrice culturale. Nel suo paese faceva la maestra in una scuola elementare. È arrivata in Italia nel 1996, per colpa della nuvola radioattiva di Chernobyl: «Gli scienziati – racconta – dichiaravano che i bambini colpiti da radiazioni, stando almeno per quaranta giorni all’anno in un paese non contaminato, riuscivano a smaltire il sessanta per cento delle radiazioni accumulate; con questi bambini dovevano partire anche maestre e interpreti. Quello è stato il mio primo contatto con l’Italia».
Durante i suoi viaggi, Tania incontra il suo futuro marito. Per quattro anni i due si vedono durante i periodi di accompagnamento dei bambini in Italia, qualche volta in Bielorussia, «e poi alla fine ho ceduto e l’ho sposato – ride –, anche perché avevo già un figlio di sette anni ed ero preoccupata dal fatto che era cominciata una delle prime ondate di morti per tumori connessi alle radiazioni: utero, seno, cervello, a dieci anni di distanza dall’esplosione».
Tania si stabilisce in Italia, dove si sente in un certo senso una “privilegiata”, perché non ha dovuto passare per la trafila da colf o badante che attende quasi sempre le donne dell’est Europa nella parte più occidentale del continente. «Anche la casalinga era un orizzonte che non mi soddisfaceva, venendo da un posto dove le donne hanno dei ruoli centrali da un punto di vista lavorativo e sociale». Così Tania inizia a interrogarsi su come mettersi a disposizione delle donne che vivono situazioni più complicate delle sue, per provare ad aprire orizzonti diversi. «I cellulari erano quasi un lusso all’epoca, soprattutto per gli stranieri. Per “agganciare” le persone esistevano le piazze, bisognava andar lì, trovarsi, costruire relazioni. Così abbiamo fatto per un po’, finché nel 2010 abbiamo fondato ufficialmente un’associazione, Bellarus, che riunisce donne provenienti da tutti i paesi dell’est».
Tania si iscrive alla scuola serale al Margherita di Savoia di Napoli e dopo all’università, fa una figlia, si laurea, e comincia a lavorare come mediatrice. Con gli anni Bellarus riesce a radicarsi a Napoli, coinvolge e supporta centinaia di donne, organizza un coro, lezioni di lingua, decine di eventi e in particolare, nel corso dei difficili anni del conflitto russo-ucraino, svolge un ruolo equilibratore tra le donne delle comunità russofone, che non potevano non risentire delle tensioni tuttora assai forti tra le varie nazionalità.
L’associazione si guadagna col tempo anche un grado di riconoscibilità a livello istituzionale, complice l’apertura del consolato onorario della Bielorussia a Napoli. «Il Comune fa il tavolo degli immigrati? Noi ci entriamo e chiediamo come mai questo non funziona e quell’altro pure. La Regione fa il registro delle associazioni di migranti? Noi ci entriamo e chiediamo com’è che non si riesce a ottenere questo e quell’altro; facciamo la battaglia per il consigliere aggiunto, facciamo la battaglia per la consulta dei migranti, tutte cose a cui partecipiamo con uno spirito battagliero, non pensando che siano la soluzione a tutti i problemi; impariamo col tempo che stare in un territorio comporta inevitabilmente fare politica, e la facciamo parlando con tutti, senza paura di sporcarci le mani, ma sempre pretendendo diritti e mai favori».
A un certo punto però il meccanismo si inceppa, e da qualche tempo Bellarus ha cominciato a incontrare una serie di ostacoli che potrebbero far pensare che l’associazione stia scontando dei presunti “buoni rapporti” con precedenti amministratori. «L’apice si è toccato a ottobre, quando ci è di fatto stato impedito di organizzare una manifestazione che facciamo dal 2017 nella Galleria Principe di Napoli, dedicata alle tradizioni del mondo slavo. Ci hanno posto una serie di paletti che alla fine dei conti ci sembrano strumentali: richiesta on-line per lo spazio, attesa per il nulla osta da parte del sindaco, complicato dialogo con l’assessorato alle politiche sociali, incapacità di comunicare tra loro dei diversi uffici di palazzo San Giacomo…». Tania e le sue compagne provano fino all’ultimo a fronteggiare il gigante burocratico. «Solo undici giorni prima dell’evento ricevo l’autorizzazione del sindaco, ma serve a poco perché mi dicono che ci vuole quella della Soprintendenza che necessita di almeno un mese per arrivare. In più servono una serie di documentazioni che non ci erano mai state chieste: nulla osta di vario genere, tasse da pagare e per finire un piano sicurezza per il quale gli architetti chiedono fino a tremila euro, e per il quale serve una planimetria della Galleria che nessuno tira fuori, una roba di cui in tanti anni che organizzo cose a Napoli non ho mai sentito parlare. Alla fine non ci hanno dato il nulla osta perché dalla polizia hanno detto che in Galleria cadono i calcinacci! Io però vedo le reti di messa in sicurezza e le attività aperte con tavolini, gente che va in bicicletta, assemblee, mentre noi volevamo solo mettere una cassa bluetooth, un microfono senza fili e tre tavolini per libri e gadget delle diverse associazioni».
Dopo settimane di lavoro a vuoto, l’evento delle comunità slave si è svolto in uno spazio privato, a pagamento. Tania spiega che non era possibile rimandare, perché per la prima volta avrebbero partecipato alla manifestazione tante associazioni che sono nate in città con lo scoppio della guerra e con l’aumento dei flussi migratori dall’area est-europea; realtà anche informali, che hanno lavorato, e bene, sottotraccia, in particolare per supportare i nuovi arrivati, senza dover necessariamente costruire rapporti istituzionali, appoggiandosi anche al lavoro di Bellarus. «Il giorno dopo la data in cui avremmo dovuto fare l’evento, in Galleria è stata fatta un’iniziativa che ha coinvolto cinquecento persone. Personalmente, e con me tante donne che hanno scelto questo paese per vivere, siamo rimaste molto deluse. Si dice sempre “Napoli città aperta”, ma forse quest’apertura cambia in base a certe condizioni politiche. Noi siamo migranti ma non siamo stupidi, sappiamo come funzionano certe cose. Quello che fa riflettere però è che evidentemente la politica non ha alcuna idea del lavoro che le associazioni dei migranti fanno sul territorio, anche al posto delle istituzioni; dovrebbero valorizzare questo tessuto, e invece di volta in volta ti chiedono aiuto, e in un certo modo ti sfruttano quando gli fa comodo, salvo poi scaricarti se non gli servi. Il risultato è che da oggi le cose ce le facciamo da noi, evidentemente parliamo lingue troppo diverse. E non mi riferisco al russo o all’italiano». (rosa battaglia)

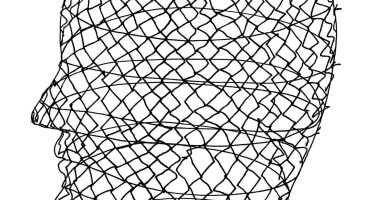


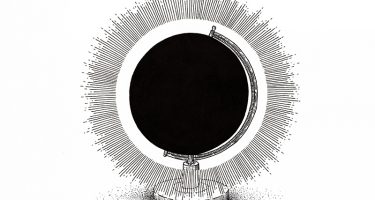
Leave a Reply