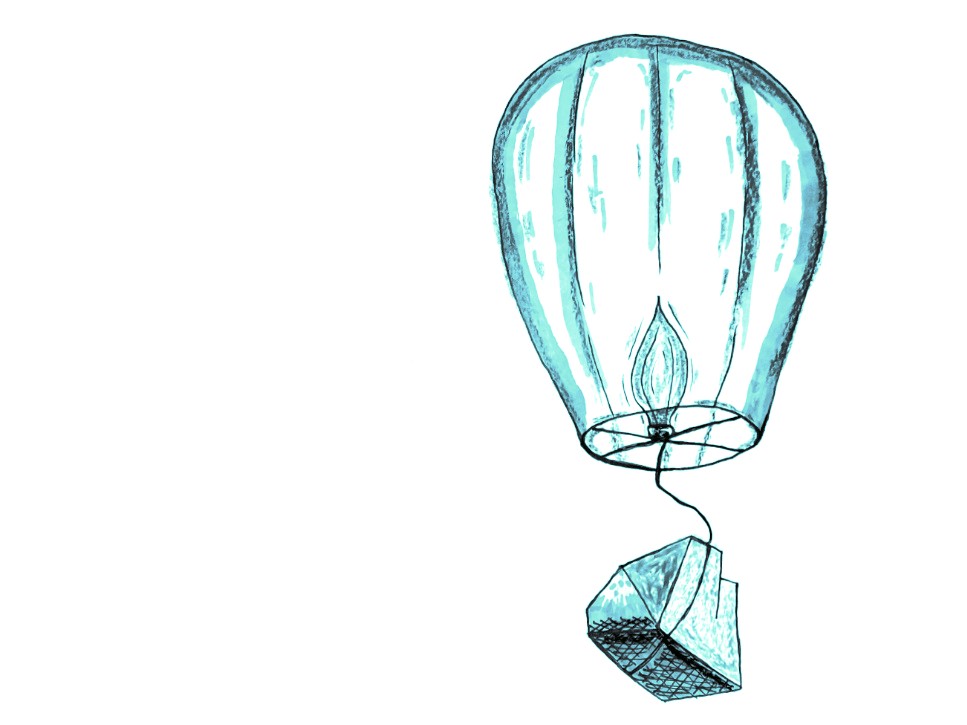
In uno degli ultimi incontri del laboratorio di narrazione che alcuni dei nostri redattori organizzano con un gruppo di ragazzi e ragazze negli spazi di Villa Medusa a Bagnoli, abbiamo chiesto ai partecipanti di raccogliere e raccontare delle storie di vita, individuando insieme dei punti di contatto o dei denominatori comuni. Ve ne proponiamo tre, illustrate da un giovane disegnatore che partecipa a sua volta al laboratorio.
* * *
SHAO DIAN
Shao Dian si trova in una stanza, chiusa a chiave e non so più niente di lei.
La conobbi un paio d’anni fa, grazie a mia zia, un pomeriggio d’estate, e ho mantenuto i contatti con lei per molto tempo; quasi sempre via chat. È una ragazza garbata, parla poco e ha lunghi capelli neri, che spesso raccoglie in due trecce laterali. I suoi occhi vengono dall’oriente e anche se stretti, a differenza di quello che pensano gli altri, ci vede fin troppo bene.
Quando venne in Italia iniziò a dire a tutti di chiamarsi Rosa perché, a detta sua, Shao Dian non è un nome che si addice a una donna nata qua, e lei è nata a Ottaviano. La gente però con questo nome si straniva, iniziava a mettere in dubbio la propria di cittadinanza, e per questo, semplificando la vita a tutti, spesso si presentava come Shao e basta. «In realtà tutti mi chiamano “la cinese” – mi confidò una volta –, ma io non so nemmeno se lo sono davvero».
Per Shao fu difficile trovare un posto da chiamare casa, un luogo da riconoscere e in cui essere riconosciuta; dove si sentisse intera e mai divisa. Per questo non sapeva mai dove collocarsi: di italiano non aveva niente, di cinese non aveva tutto. Aveva solo la testa piena di ideali e tradizioni anche se, di notte, «i miei sogni sono in italiano». A Shao piaceva molto il cibo di Napoli. Pizze, zeppole, panzarotti, gliele portavo sempre in quelle poche occasioni in cui ci siamo viste. Conosceva a memoria la ricetta della pasta e patate ma la mangiava sempre e solo con le bacchette. Da quando viveva in Italia, si era così abituata a quel cibo che ogni volta che tornava in Cina non mangiava quasi niente. Sua nonna, come ogni nonna, la rimproverava. «Non ho mai mangiato un cane in vita mia», teneva sempre a precisare. Ma ora non deve preoccuparsi, quelle battute sono passate di moda; a farle paura, al massimo, dovranno essere i pipistrelli, Whuan e il Covid.
Quando compì un anno, i suoi genitori la mandarono in Cina. Mama e baba, troppo impegnati, decisero che a occuparsi di lei sarebbero stati i nonni. I genitori di Shao erano emigrati a Ottaviano anni fa, convinti che lì avrebbero avuto successo. In quel posto c’erano già parecchie fabbriche tessili. Una fabbrica cinese non avrebbe fatto tanta differenza.
A Shao piaceva stare con i nonni, e i primi anni della sua vita li visse come una qualsiasi ragazzina di quartiere pechinese. La Cina però, senza accorgersene, l’ha imballata, come uno di quei giocattoli che spedisce in tutta Europa. «Certe culture non tengono conto di niente, nemmeno di inclinazioni, emozioni e sentimenti e nel caso dei cinesi, solo di profitto», mi spiegò una volta. Le fu chiaro a quattordici anni, quando da un giorno all’altro le fu detto di lasciare tutto e di tornare a “casa”, perché mama e baba avevano di nuovo bisogno di lei. Così, senza sapere bene quello che l’aspettava, fu spinta a strapparsi da tutto: amici, lingua, scuola. Bisognava ricominciare, questa volta in Italia con i suoi genitori e con suo fratello nato dopo di lei. Un giorno baba la portò in un cortile, nei pressi di un bel palazzo. All’interno del seminterrato, una volta aperte due grosse inferriate verdi, Shao vide tante altre persone, tutte chine su una macchina da cucire, che seguivano con le dita i tessuti. Il caldo soffocante, l’odore di muffa e quei fili elettrici che viaggiavano da un lato all’altro del deposito, per alimentare lampadine e ventilatori, le sarebbero diventati subito familiari. «Ormai sei grande – le disse quel giorno baba –, è giusto che tu lavori». E così, anno dopo anno, Shao ha continuato a fare sempre solo la stessa cosa, ogni pomeriggio di ogni giorno. «L’ho fatto per la famiglia, per la cultura, per la Cina». Pensandoci bene, ora che ha vent’anni, non sa nemmeno lei perché l’ha fatto.
Shao non lo diceva, ma la pressione di quella vita la sentiva tutta. Era sempre di fretta. «Scusami devo andare, è iniziato il turno», era la frase che mi ripeteva più spesso. Quello che traspariva, ogni volta che riuscivamo a parlare, era il forte desiderio di uscire dall’indifferenza. Mi parlava, per dire qualcosa di sé, di farsi strada come individuo in una società che omologava tutto. Così, anche quando la sua famiglia le raccontava di tutti i sacrifici fatti per raggiungere un futuro migliore, lei desiderava solo non doverne pagare le conseguenze e non essere più solo una dei tanti cinesi emigrati.
C’è una parola molto bella in cinese: Jia you. È un bellissimo motto di incoraggiamento e significa: “metti benzina nel serbatoio!” Metti energia, fa uno sforzo extra e va’ avanti! I cinesi se lo ripetono sempre e pure lei lo fa. Da quando decise di non lavorare più, i genitori pensarono che forse Shao si sentisse pronta a sposarsi con qualcuno. Dopo poco fu chiaro a tutti che invece non aveva intenzione di rinchiudersi in un altro “scantinato”, e iniziarono i problemi. L’ultima volta che parlammo, mi raccontò via chat che i genitori l’avevano chiusa in una stanza per paura che scappasse. «In fondo perché no – mi rispose con ironia –, me ne andrei molto volentieri da qualche altra parte».
Oggi di Shao Dian non so più nulla, mi auguro solo che stia bene. Una delle cose che preferiva fare da bambina era osservare con i nonni gli hutong di Pechino addobbati per le feste. A Capodanno la città, durante l’ultima festa, quella delle lanterne, si riempie di luci. Quella sera i bambini insieme agli adulti passeggiano con una lanterna in mano, assaggiando pietanze tradizionali e assistendo agli affascinanti spettacoli con i fuochi d’artificio. Fu proprio durante uno di questi che Shao si fece scappare la lanterna cinese tra le mani. La vide scomparire nel cielo nero di Pechino. «Quell’azione distratta, che mi fu rimproverata con uno schiaffo sulla mano dalla nonna, fu molto significativa», mi raccontò. «Il cuore era più leggero e per la prima volta sentii possibile prendere le distanze dalla tradizione». (sirya micera)
———-
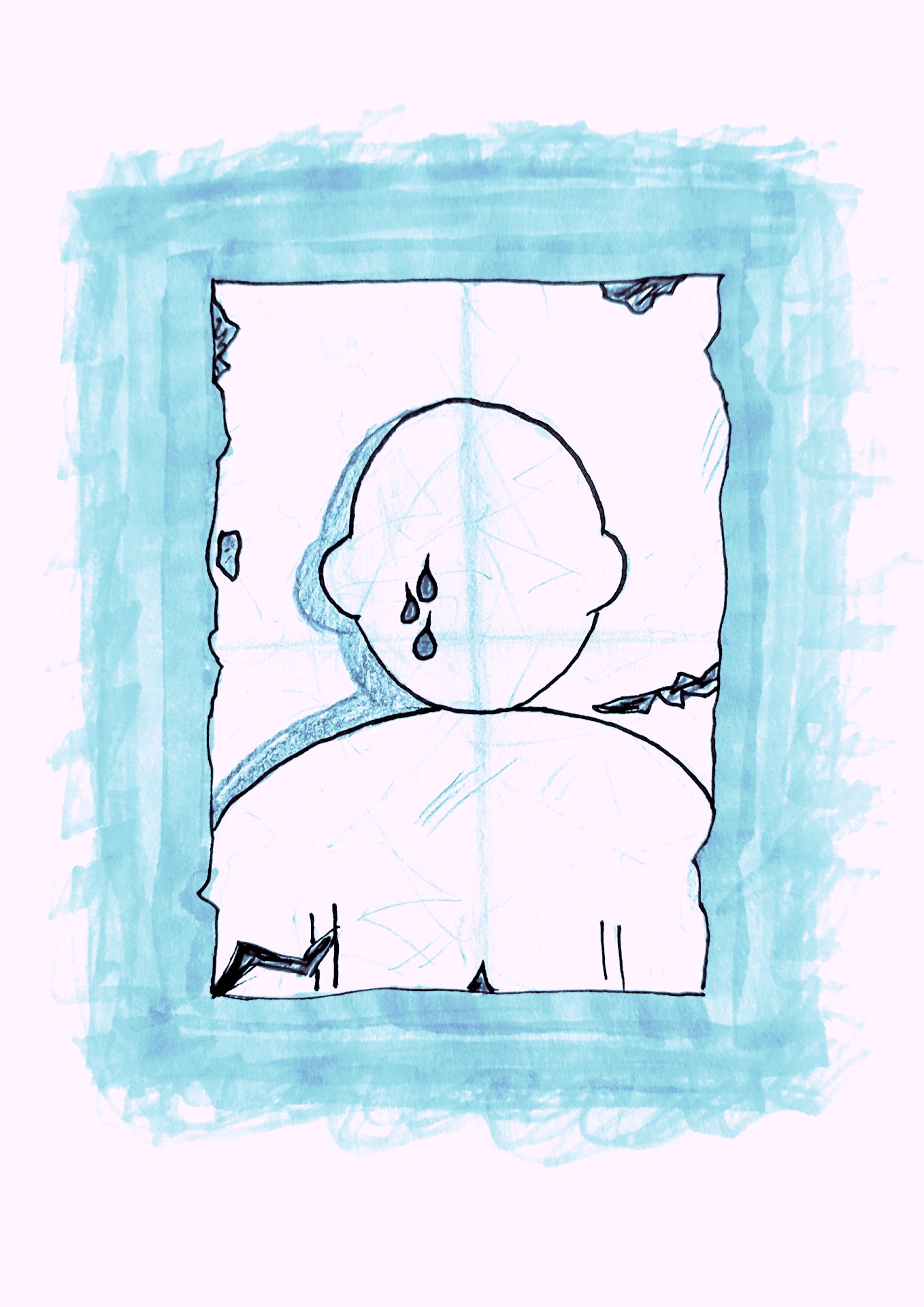
LORENA, GIAN ANDREA E ABDULLAH AFRIDI
6 settembre 2023
Con la professoressa di italiano abbiamo scoperto che a Trieste una coppia di anziani ha creato un piccolo centro di cura e accoglienza migranti. Abbiamo subito organizzato la partenza.
Arriviamo di sera in città. Scendiamo dall’autobus in piazza Libertà e vediamo una fila di persone, che sembra infinita. In fondo alla fila c’è una panchina coperta da telo di plastica blu, con seduta una donna sulla sessantina. È Lorena.
Avvicinarsi è impossibile, infatti ci accoglie Gian Andrea, suo marito. Ci sediamo in cerchio e iniziamo ad ascoltarlo. Ci sentiamo un po’ fuori luogo, per come siamo vestiti: a Trieste fa vento, noi ci siamo attrezzati con giubbotti caldi e costosi, guanti e cappello, mentre le altre persone che si trovano nella piazza no.
«Sono tanti anni che io e Lorena passiamo le nostre nottate qui», racconta Gian Andrea. «Ogni giorno arrivano decine o anche centinaia di migranti che per entrare in Italia passano per Trieste. La maggior parte hanno intorno ai trent’anni, ma più passa il tempo più l’età media si abbassa, includendo anche tanti ragazzini che sempre più spesso intraprendono il grande viaggio.
Noi partiamo dalla cura dei piedi: considerate che quasi tutti sono in viaggio da più di tre anni, e non hanno mai cambiato calzini. Negli anni abbiamo creato una rete di associazioni e abbiamo quindi la possibilità di procurare cibo, acqua e vestiti».
«Dove andranno a dormire?», domanda qualcuno di noi.
Gian Andrea risponde con un’espressione sconsolata, quasi come si sentisse in colpa. Ci spiega: «Dietro la stazione c’è un grande palazzo abbandonato che chiamiamo silos. È cadente e basta una piccola pioggia per farlo allagare, ma purtroppo per ora non c’è altra soluzione. È capitato che arrivassero famiglie molto in difficoltà e con bambini piccoli, in quel caso li facciamo stare alcune notti a casa nostra».
Non riusciamo a parlare con Lorena. Ma prima di andare chiediamo a Gian Andrea se la coppia si sia mai concessa una vacanza, da quando ha iniziato questo percorso. Con un’espressione tra desolazione e orgoglio, ci risponde che da quando hanno iniziato a farlo, è stato sempre più difficile pensare di andare via. «Guardando negli occhi persone che non hanno niente ho imparato ad apprezzare ciò che mi circonda. Noi siamo fatti per essere umani, non abbiamo bisogno di nessuna pausa da questo».
7 settembre 2023
Siamo di nuovo qui, la folla di persone sembra più vasta di quella di ieri. È quasi impossibile vedere Lorena dall’altro lato della piazza. Incontriamo di nuovo Gian Andrea, che ci invita a parlare con qualcuno, per capire come funziona un grande viaggio e per conoscere le loro storie.
Ci dividiamo in gruppetti e andiamo alla ricerca di persone che ci sembrano non troppo sofferenti o pensierose. Cerchiamo di capire chi abbiamo di fronte, siamo di fatto degli intrusi e non vogliamo infastidire nessuno.
Vedo un ragazzo, avrà più o meno vent’anni. Ci guardiamo, lui si avvicina a me con la fotografia di un uomo, e mi domanda in lacrime se lo abbia visto. Gli dico di no, con immenso dispiacere, gli chiedo se ha voglia di raccontarmi la sua storia. Il ragazzo parla un italiano stentato, ma riesce a farsi comprendere attraverso il linguaggio del corpo e con l’aiuto dei suoi amici.
«Mi chiamo Abdullah Afridi, vengo dall’Afghanistan. Dieci anni fa mio cugino è scomparso e ho deciso di partire per trovarlo e per aiutare la mia famiglia. Voglio andare dall’Onu a chiedere se lo hanno rapito».
Mentre parla, percepisco la distanza c’è tra me e lui. Vorrei spiegargli quanto sia difficile una cosa del genere, e probabilmente sarebbe anche inutile, ma mentre penso a tutto questo continuo ad ascoltare.
«Ho iniziato il viaggio otto anni fa. Non avevo documenti, né veri né falsi, ho dato la metà dei miei soldi a un signore che in macchina ha portato me e altri quattro in Iran. Lì ho lavorato un anno e mezzo come operaio, mi sono fatto male e sono dovuto restare altri sei mesi, senza mai poter chiedere di andare in ospedale. Piano piano sono arrivato a piedi dall’altra parte del paese, dovevo solo trovare il modo per passare il confine. Scopro tramite voci che in un quartiere di Tabriz un uomo organizzava le fughe dal paese, trovando metodi per passare il confine.
Ho passato nove ore legato sotto un camion con una corda. Ogni secondo pensavo di cadere, pensavo alla mia famiglia e ad Allah. Pensavo che mi avrebbero visto e mi avrebbero ucciso durante i controlli, invece andò tutto bene.
Arrivato in Turchia, ormai in viaggio da due anni, è arrivato anche il Covid. Nel 2020-2021 sono stato lì e ho lavorato dodici ore al giorno rischiando di ammalarmi. Anche in Turchia fa freddo.
Poi ho attraversato tutta la Grecia e i paesi balcanici. Lì per passare il confine basta correre veloce.
Ho sempre chiesto a tutti quelli che incontravo se avessero visto mio cugino. Il mondo è grande ma non così grande. Sono stato sempre solo, pensando alla mia famiglia e ad Allah.
Sono arrivato qui un mese fa. Vorrei diventare cittadino italiano, solo che qui non ci vogliono. Per loro non esistiamo e quando devono ammettere che esistiamo dicono che siamo un problema. Non vogliamo fare del male, vogliamo solo vivere come le persone che stanno bene».
Abdullah ha percorso in otto anni circa seimila chilometri. Era impossibile per me, dopo aver ascoltato la sua storia, dire qualsiasi cosa. Mi ha sbattuto in faccia la sua realtà, la realtà, e in un certo senso anche la mia. L’ho abbracciato. Siamo diventati un po’ più umani. (viola varlese)
———-
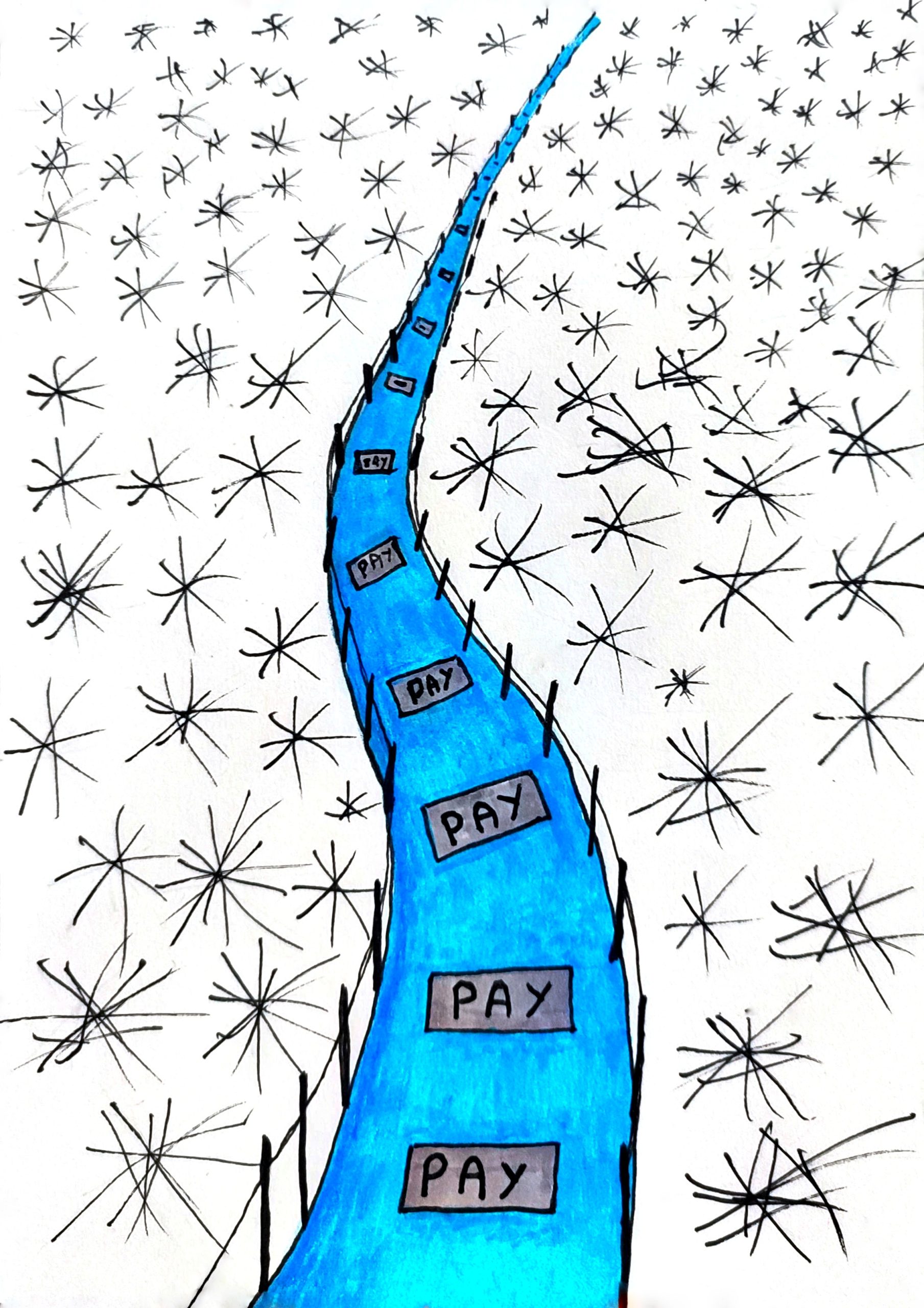
ZORYANA
Zoryana vive da vent’anni in Italia. Ci incontriamo poco prima dell’inizio della sua giornata di lavoro. Si occupa di integrazione e supporto ai migranti per l’Unhcr (United Nations High Commissioner for Refugees). L’aria è fredda, e decidiamo di sederci in un bar sotto la Galleria Principe. Proprio mentre iniziamo a chiacchierare dalle casse parte una canzone di Pino Daniele.
Zoryana arriva da un piccolo paese del nord Ucraina. Ha deciso di lasciare casa appena finito il liceo, ricongiungendosi con sua madre a Napoli, che era partita all’inizio del nuovo millennio. Ricordando quei giorni sottolinea lo sconforto, la paura di dover lasciare per sempre amici e abitudini, per arrivare in un nuovo paese, di cui non sapeva quasi nulla, a cominciare dalla lingua.
«Mi sono sentita cresciuta all’improvviso, di fronte a tante responsabilità da adulta. Come tante persone, anche io ho fatto dei debiti per arrivare in Italia. Il viaggio è costoso e anche complicato. Non è stato facile».
Dopo un po’ di tempo Zoryana si ritrova a Venezia. Non conosce la città, non parla la lingua, interagire con le persone è impossibile. «Quando sono arrivata a Venezia mi sono spaventata. Non sapevo come muovermi e non avevo molti soldi in tasca. Per fortuna, grazie a Dio, sono riuscita a trovare qualcuno che mi ha aiutato a capire come poter arrivare a Napoli».
Una volta arrivata a Napoli, Zoryana non può che trovare un lavoro che le garantisca anche un alloggio, il che le impedisce di costruirsi una vita sociale. «Lavoravo notte e giorno come badante, sette su sette, non avevo mai tempo per me stessa, per fare amicizie o altro: lavoro soltanto lavoro».
Almeno, la famiglia si ricongiunge pian piano, con l’arrivo del padre e dei fratelli. «Col tempo abbiamo preso un appartamento. Certo era molto piccolo, ma ci sentivamo nel nostro confort, eravamo tornati a essere una famiglia unita».
Dopo qualche anno Zoryana riesce a trovare un lavoro come babysitter. Condivide con quella famiglia circa quindici anni della propria vita, per lei importantissimi. «Mi sentivo parte di quella famiglia, non una lavoratrice. Sono stata con loro tanti anni, ho cresciuto due bambine stupende, e poi è arrivata la gioia più grande: mio figlio.
Solo con il tempo mi sono stabilita emotivamente, prima grazie a mio marito, poi mio figlio, al quale però non sono riuscita a dedicare abbastanza tempo, per via del lavoro. Nel tempo libero studiavo, ho iniziato a pormi domande su quello che volessi fare».
Nel 2020 il mondo si ferma, ma chiusa in casa, Zoryana non smette di farsi domande: «In quel periodo sono stata molto male, ma ho anche avuto la possibilità di scoprire cose che mi ero persa arrivando qua, per esempio ho studiato la storia e la lingua di questo paese».
Alla fine della pandemia, Zoryana è riuscita a trovare un lavoro come mediatrice culturale. È arrivata a conoscenza di un progetto di UNHCR a Napoli, ed è riuscita a far diventare un lavoro la sua tendenza naturale a supportare gli altri. «Aiutare chi vive le stesse difficoltà che ho vissuto io mi fa sentire meglio. Oltre a un supporto nelle cose pratiche, cerco di dare loro quella speranza che in molti momenti mi è mancata». (angelo della ragione)

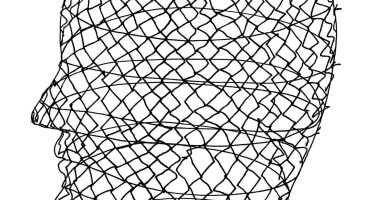


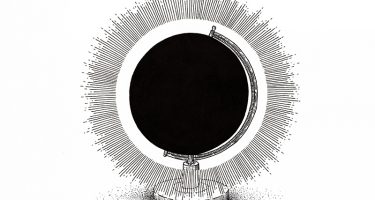
Leave a Reply