Lo stato della città. Napoli e la sua area metropolitana è un libro collettivo uscito nell’aprile 2016 per le edizioni Monitor. Un volume di 536 pagine, con 68 autori che comprende 86 articoli, saggi, storie di vita, grafici e tabelle. Da circa un mese esiste un sito con lo stesso nome, nato con l’obiettivo di rendere progressivamente disponibile l’intero libro, ma soprattutto di aggiornare con il passare del tempo tutti i contributi, a cominciare da quelli basati su dati annuali, per costruire un archivio in movimento delle questioni aperte nell’area metropolitana. Proponiamo a seguire il primo dei contributi inediti e in via di pubblicazione.
* * *
Beni comuni urbani. L’esperienza di Acqua Bene Comune
di Sergio Marotta
Napoli è l’unica grande città italiana che, sulla scia degli esiti dei referendum del 12 e 13 giugno 2011, ha trasformato la propria azienda per la fornitura dell’acqua da società commerciale, Arin S.p.A., in azienda speciale, Abc – Acqua bene comune, modificando la sua forma giuridica da società per azioni di diritto privato a ente di diritto pubblico.
Ciò si è potuto realizzare perché l’amministrazione cittadina ha posto al centro dell’agenda politica il tema dei beni comuni intesi, secondo la definizione che ne diede la Commissione Rodotà nel 2008, come “cose che esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona” e che “devono essere tutelati e salvaguardati dall’ordinamento giuridico, anche a beneficio delle generazioni future”.
Sulla base di questo indirizzo, l’acqua è stata considerata come risorsa collettiva da gestire al di fuori della logica del profitto e delle leggi del mercato. A tal fine, oltre alla trasformazione della forma giuridica, è stato introdotto un principio di governo partecipato coinvolgendo i movimenti ambientalisti e i cittadini utenti chiamati a superare così la condizione di semplici consumatori.
La realizzazione di una gestione pubblica e partecipata del servizio idrico integrato è in una fase iniziale e ancora non s’intravede quale sarà l’esito finale dei processi in corso.
La cronistoria
Nella prima metà degli anni Novanta la legge 5 gennaio 1994, n. 36, meglio nota come legge Galli dal nome del suo proponente, creò il cosiddetto servizio idrico integrato mettendo insieme i servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Un servizio la cui organizzazione andava pianificata sulla base dei bacini idrografici, cioè della presenza sul territorio delle acque e delle fonti nonché delle infrastrutture artificiali realizzate per il loro utilizzo.
La legge di riforma fu salutata come un’innovazione necessaria dalla maggioranza delle forze politiche. In realtà, la legge Galli importava nel nostro ordinamento il modello anglosassone elaborato dal governo Thatcher nel 1989 per la Gran Bretagna che prevedeva l’integrazione del ciclo della fornitura dell’acqua e dei servizi di fognatura e depurazione nelle mani di un unico operatore, identificato con un soggetto imprenditoriale privato che divenisse titolare di una concessione comprendente l’intera estensione di un bacino idrografico di riferimento.
La legge Galli organizzava il servizio sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO) corrispondenti ai diversi bacini idrografici. Era previsto che tali ambiti fossero governati da un’autorità di nuova istituzione composta da tutti gli enti locali presenti sul territorio del bacino e individuata da ciascuna regione con apposita legge.
Quanto alla proprietà formale della risorsa, non è superfluo ricordare che in Italia l’acqua è pubblica e che “tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato” (d. lgs. n. 152/2006, art. 144, comma 1). Di proprietà pubblica sono anche gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche che fanno parte del demanio e sono inalienabili se non con i criteri dettati dalla normativa vigente. Dunque ciò che interessa non è la proprietà pubblica della risorsa ma la gestione del ciclo delle acque, cioè il suo effettivo utilizzo. L’acqua, in sostanza, “appartiene” a chi ne ha la effettiva disponibilità e quindi a chi la gestisce, occupandosi della realizzazione e manutenzione delle infrastrutture e dell’amministrazione delle risorse finanziarie.
Nel 1994 gli enti locali, province e comuni, che dovevano dare vita alle nuove autorità di gestione degli ATO potevano utilizzare le modalità previste dalla prima importante legge di riforma delle autonomie locali, la 142/90. Tale legge lasciava ampia libertà di scelta sulle modalità di gestione dei servizi pubblici locali e, quindi, anche del servizio idrico integrato: gli ATO potevano provvedere alla “gestione diretta” mediante aziende speciali (autoproduzione); all’esternalizzazione del servizio affidandolo in concessione a un soggetto esterno mediante procedura di evidenza pubblica (outsourcing); oppure avrebbero potuto utilizzare lo strumento della società mista pubblico/privata, purché a maggioranza pubblica.
Ciò che rese più complessa la riorganizzazione dei servizi idrici, fu la circostanza che nello stesso periodo andava realizzandosi in Italia un profondo processo di riforma delle amministrazioni pubbliche locali. In particolare, la seconda delle cosiddette leggi Bassanini (l. 15 maggio 1997, n. 127) incentivava la trasformazione delle aziende speciali, enti di diritto pubblico che svolgevano attività d’impresa, in società per azioni, attraverso una procedura semplificata e con un regime fiscale agevolato. Insomma, si andava lentamente superando il sistema della municipalizzazione dei servizi che era iniziato con la legge Giolitti del 1903 e si dava spazio alle società di capitali come strumento privilegiato anche per la gestione dei servizi pubblici locali. (continua a leggere)

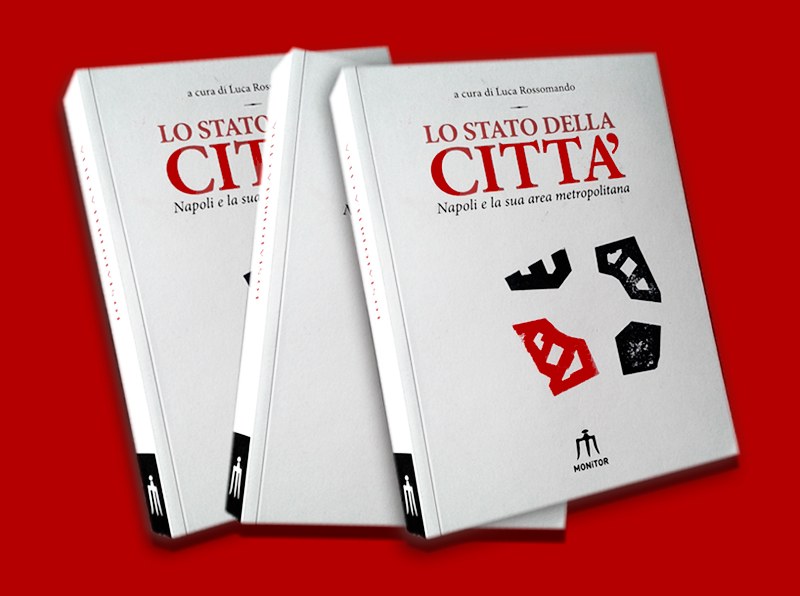



Leave a Reply