
«Dove andrai a dormire?», chiede la giornalista.
«Laggiù», risponde Mohammed, indicando le montagne lontane.
Cassibile, ventuno agosto. Le ruspe sono appena arrivate ma nell’accampamento erano già rimasti in pochi. Mohammed raccoglie i suoi quattro stracci e si avvia, voltandosi solo un attimo a guardare la distruzione del posto in cui viveva. Distruggono pure la “moschea”, col suo tappeto rosso a terra.
A metà giugno, in quell’accampamento c’erano cinquanta o sessanta persone. Ad agosto, prima dello sgombero, solo una decina. Il campo è celato agli occhi di chi non conosce la zona. Basta sbagliare direzione per perdersi in un paesaggio lunare dove si alternano il verde degli ulivi e il giallo dell’erba secca.
Durante una visita, appena arrivati ci siamo imbattuti in un ragazzo a piedi, magrissimo. È del Darfur: «Andando avanti si incontrano gli altri, in bici o dentro le macchine». Subito dopo, in effetti, ne passano due o tre con a bordo dei ragazzi: una si ferma dentro l’accampamento, loro scendono, ne arriva un’altra, stessa storia e ripartono. Tutto intorno abitazioni di fortuna a testimoniare che la schiavitù esiste. Nessun essere umano libero e dotato delle risorse essenziali vivrebbe così. Ma loro non hanno scelta.
A un tratto spunta Moustafà, vivace e chiacchierone. Parla benissimo italiano e inglese e, dopo una certa ritrosia iniziale, inizia a raccontare la sua storia. Anche lui viene dal Darfur, è in Italia da undici anni, è un rifugiato politico e guadagna massimo quarantaquattro euro al giorno per lavorare nei campi senza pause né giorni liberi. Dalla paga bisogna sottrarre tre o quattro euro per la macchina che lo prende e lo riporta indietro e cinque euro per il panino che compra dentro il campo stesso. Il suo capo è un marocchino che a suo dire sfrutta la sua posizione di potere per arricchirsi. «A volte si tiene una parte della paga, altre volte ci chiede soldi senza motivo. Così poi se ne va a casa. Lo sai che va spesso nel suo paese, in Marocco?».
Moustafà lo dice come uno che sa di subire una ingiustizia cui non può porre rimedio. «Fino alla settimana scorsa eravamo il triplo. Ora sta finendo la stagione delle patate. Quando finisce del tutto, mi sposto in altre province della Sicilia, oppure vado in altre regioni. Puglia, Campania…». Arriva un altro ragazzo. Età indefinibile, da qualche anno in Italia, parla solo pochissimo inglese. Abbastanza per indicare un pallet con una tenda sopra e raccontare che lui dorme lì, perché è arrivato tardi. «Poteva andare anche peggio», aggiunge.
Questi uomini hanno lasciato la propria terra dove la guerra e la siccità hanno reso impensabile ogni futuro, sono sopravvissuti al deserto per trovarsi schiavi in Libia e oltrepassare il mare. Hanno toccato terra e ottenuto lo status di rifugiato: il diritto internazionale dovrebbe proteggerli. E invece, si trovano invischiati nella trappola del caporalato e quando qualcuno si ricorda di loro, lo fa per arrecare ulteriore danno. Nessuno ha chiesto come si sentano a veder crollare la propria casa, né gli è stata offerta alcuna alternativa.
Come ribadito da padre Carlo D’Antoni, della parrocchia Bosco Minniti a Siracusa, «sono più di dieci anni che questi ragazzi vedono giornalisti arrivare, scattare foto e andarsene, lasciando tutto come prima. Sono sempre più poveri, sempre più emarginati». Padre Carlo da anni si batte per i diritti dei braccianti agricoli sfruttati, denunciando le condizioni in cui sono costretti a vivere quegli uomini. «Mesi fa alcune baracche erano visibili dalla strada. Sono arrivate le ruspe e hanno tolto solo quelle. Ora invece hanno smantellato tutto perché non serve più manodopera visto che la raccolta è finita. Ma non illudiamoci: se non hanno dove andare, torneranno». (maria grazia patania)

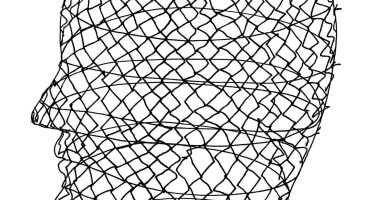



Leave a Reply