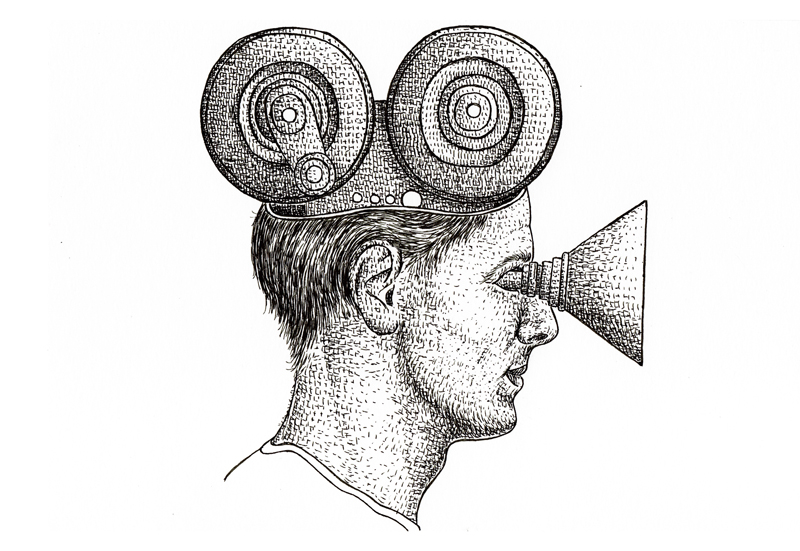
Che in mezzo a quel pantano Fulvio fosse tra i più intelligenti – di un’intelligenza viva, e per questo pericolosa come una ferita –, in pochi avevano dei dubbi. Magari allora difficilmente lo avrebbero ammesso, perché da noi una regola non scritta ci vietava di parlare bene del prossimo. Certo è che con Fulvio si poteva dissentire per quel suo modo di fare elegante, che stonava in mezzo al disagio sotto ai portici del Banco di Napoli; si poteva ritenere la sua parlata simile a quella dei figli di papà di piazza Vanvitelli e dintorni, sebbene Fulvio non appartenesse a quel ceto medio male alfabetizzato; si poteva perfino detestare la puzza di Diana rosse che raramente rifiutava di offrirti; ma quelli che hanno avuto modo di conoscerlo non possono fare a meno di ammettere, con il senno di poi, che Fulvio era un ragazzo che pensava con la sua testa.
Noi lo ignoravamo a dire il vero. Almeno in un primo momento. E quando dico noi mi riferisco a un gruppo di tre adolescenti appena usciti dalle scuole medie che iniziavano a cacciare la testa fuori dal sacco, condividendo le giornate in quella provincia troppo piccola per essere una città e troppo grande per essere un paese. Un paesone. Niente di più, niente di meno. Talmente monotono che salutavi anche dieci volte la stessa persona che incrociavi dieci volte in un giorno.
A parte noi, nessuno credeva in noi. Nello stereo i Company Flow ci facevano salire l’adrenalina con le rime di Population Control, e in tal modo ci illudevamo di vedere Brooklyn dalla piazza centrale del paesone. Più o meno era la fine del novantanove. Tra noi c’era già chi si dilettava con qualche strumento musicale, cercando di superare lo scoglio che stabilisce la differenza tra un destino già scritto e un altro ancora da scrivere. Il tempo lo dividevamo in tentativi di imparare a ballare la breakdance e in partite di pallone.
Ai Salesiani il meccanismo era semplice: c’erano dei campetti di asfalto attaccati l’uno all’altro e le partite si fermavano solo al momento della preghiera. Prima e dopo, il pallone. Il pallone e nient’altro. Le squadre si sfidavano a oltranza e continuava a giocare solo chi arrivava a cinque. Il vincente sfidava “la squadra per dopo”. E si andava avanti così per tutto il pomeriggio, per tanti pomeriggi. Tra vittorie, sconfitte, squadre per dopo e poi di nuovo, zero a zero e palla al centro. Avanti il prossimo. Le bestemmie erano punite con il massimo della pena e le risse erano sedate dal controllo morale che circondava l’oratorio come una cappa, con il lascito di Don Bosco che aleggiava ovunque, insieme alla sua idea di formare buoni cristiani e buoni cittadini.
Non mi pare comunque che Fulvio frequentasse i campetti dei Salesiani. Non giocava a pallone. Nuotava, questo sì. Tra l’altro abitava nei pressi della piscina comunale, non lontano dallo stadio e da una via intitolata a un capitano medaglia d’oro al valor militare, un classico nome di via per quel paesone di caserme. Da casa sua forse sentiva i soldati della brigata Garibaldi e i rumori delle esercitazioni che rompevano la monotonia. Di sicuro sentiva i boati e i cori dei tifosi allo stadio. Ma Fulvio non andava neanche allo stadio, se ne fregava della Magica. Preferiva leggere libri di poesia o di letteratura, o ascoltare musica, o suonare la chitarra. Tonino, che pure ha ricordi sbiaditi sul suo conto, dice che cantava bene e che era appassionato del rock anni Settanta, i Led Zeppelin, e poi il blues, tanto blues. E i cantautori. Dice anche che nella strada in cui viveva, alzando la testa all’altezza di casa sua, si vedeva la finestra della camera e, quando la tapparella era alzata, spuntava un poster del Che con il sigaro in bocca. Allora potevi citofonargli e lui ti faceva salire, e andavi a cazzeggiare a casa di Fulvio che condivideva con te il mezzo pacchetto di Diana rosse e della buona musica.
Immagino ignorasse anche quei discorsi sul declino di una squadra che provocò una rivolta popolare anni addietro, e che tra gli Ottanta e Novanta arrivò in serie cadetta. Avrà sentito, come tutti, le storie raccontate da quelli che le avevano vissute in prima persona come Michele, proprietario del bar in via Ernesto Rossi – nato a Caserta un secolo prima, ragion per cui gli intitolarono una via. Michele era tra quelli che andarono fino a Giarre, e tra i suoi aneddoti ritornava spesso quello del gemellaggio finito male che lui sintetizzava in tal modo: “Arrivammo là. Giarre saluta Caserta, Caserta saluta Giarre. Alla fine della partita palate ‘i morte”.
Ma Fulvio non dava importanza neanche a quelle storie che invece ad alcuni facevano ridere, ad altri facevano piangere, ad altri ancora facevano ricordare. Fulvio al massimo coltivava dentro di sé un conflitto difficile da sanare e prestava attenzione ai dettagli. Come quell’arroganza nel dialetto, che forse trovava volgare. In effetti era un dialetto efficace, con un intercalare insopportabile, capace di esprimere solo disprezzo verso il prossimo, sciatteria, cinismo, diffidenza, e un pragmatismo insolito per la gente meridionale. Era il dialetto dei soldi da guadagnare. Quel paesone non avrebbe mai potuto essere come Bergamo, eppure l’inclinazione al lavorio finalizzato all’accumulazione smodata si percepiva già da quella lingua per palazzinari venuti fuori dalla campagna. L’emarginazione partiva da lì. Dall’idea distorta di Terra di Lavoro. Ecco cosa ci distingueva dal resto del mondo circostante: quel dialetto buono per i fravecatori e i riggiolari sfruttati dalle ditte al servizio dei grossi costruttori, i migliori manovali che si potessero trovare sul mercato delle braccia.
Fulvio neanche quello sapeva fare, il mestiere non gli interessava, gli piaceva la letteratura, la poesia, la musica; uno come lui poteva nascere in qualsiasi altro luogo e invece eccolo là, a farsi strada in un paesone di provincia che non ascolta e non capisce, a rivoltarsi contro sé stesso, privo di riferimenti, circondato da gente che bada al sodo come i peggiori dei brianzoli. Forse Fulvio sognava di andarsene via come avevano fatto tanti altri suoi coetanei. Ma intanto le giornate trascorrevano e lui si ritrovava nel tritacarne, a frequentare l’istituto tecnico commerciale “Terra di Lavoro”.
Passarono gli anni. Giravano voci che Fulvio per un po’ avesse fatto il carabiniere in Sardegna. Poi accadde qualcosa, e a quanto pare si congedò. Forse Fulvio pensava che quello del carabiniere fosse un lavoro come tanti? Che tanto non c’era più nulla per cui valesse la pena battersi? Solo la rassegnazione del cupio dissolvi? Forse la sua era confusione, rivolta esistenziale, solitudine, conflitto che non trova sfogo, espiazione della colpa di essere nati là, bisogno di una disciplina che se non ti dai da solo ti darà qualcun altro? Dopo la scomparsa la sorella fece pubblicare alcune tra le sue poesie e racconti, ma non li ho mai trovati né letti. Forse non ho cercato bene. L’altra notte però ho trovato questa breve cronaca scritta da lui, risalente al giugno 2007, pubblicata sul sito locale con cui collaborava un anno prima della decisione di levare la mano su di sé. E in questa “piccola storia”, come la definiva, ho ritrovato dopo tanto tempo non solo la sua voce, ma anche una possibile risposta ad alcune questioni ancora irrisolte sulle ragioni che m’inducono a scriverne.
Fra venerdì e sabato, le terrazze di San Leucio – chiuse al pubblico da un cancello e relativo catenaccio – sono state simbolicamente occupate da una folta schiera di giovani casertani trovatisi là come per magia, senza appuntamento. Un evento assolutamente improvvisato e pacificamente “clandestino” all’interno del quale alcuni rabberciati mercatari hanno dato sfoggio della fantomatica arte di arrangiarsi generando un brusio paragonabile alla fiera settimanale. All’urlo di “Vai con la birra ghiacciata” numerosi ragazzi, nel buio silenzioso della romantica cornice Leuciana, hanno abbandonato le suggestioni della bella vista notturna su Caserta, cominciando improvvisamente a generare come un’energia collettiva, una forza nuova eppure antica, dimenticata da molti. E quest’anima popolare, così meravigliosamente spontanea, è cresciuta all’arrivo del collettivo dei ragazzi del Laboratorio Millepiani, centro di aggregazione aperto a ogni minoranza bisognosa di espressione, e soprattutto mosso dall’intento di rendere fruibile a tutti l’accesso e la condivisione di tutta una serie di mezzi espressivi che possano dare voce a un bisogno sovra-individuale. Bisogno quale ad esempio quello di poter godere liberamente della terrazza Leuciana, senza dover scavalcare un cancello e doversi sentire “clandestini” piuttosto che liberi utilizzatori, valorizzatori di qualcosa che è stato dimenticato dal proprio legittimo proprietario. Una vera e propria autogestione-lampo di uno spazio popolare, una riappropriazione durata giusto il tempo di una notte. Invasione pacificamente barbarica, e dunque altra, di uno spazio nel quale è stata offerta gratuitamente la musica per far ballare i partecipanti. Un evento certamente sommerso, capace pur senza arrecare disturbo ai più, di stabilire un feeling, un incontro nato dal nulla in un luogo buio. Una piccola storia, comunque, forse per questo almeno meritevole di essere raccontata. (pomé)


Leave a Reply