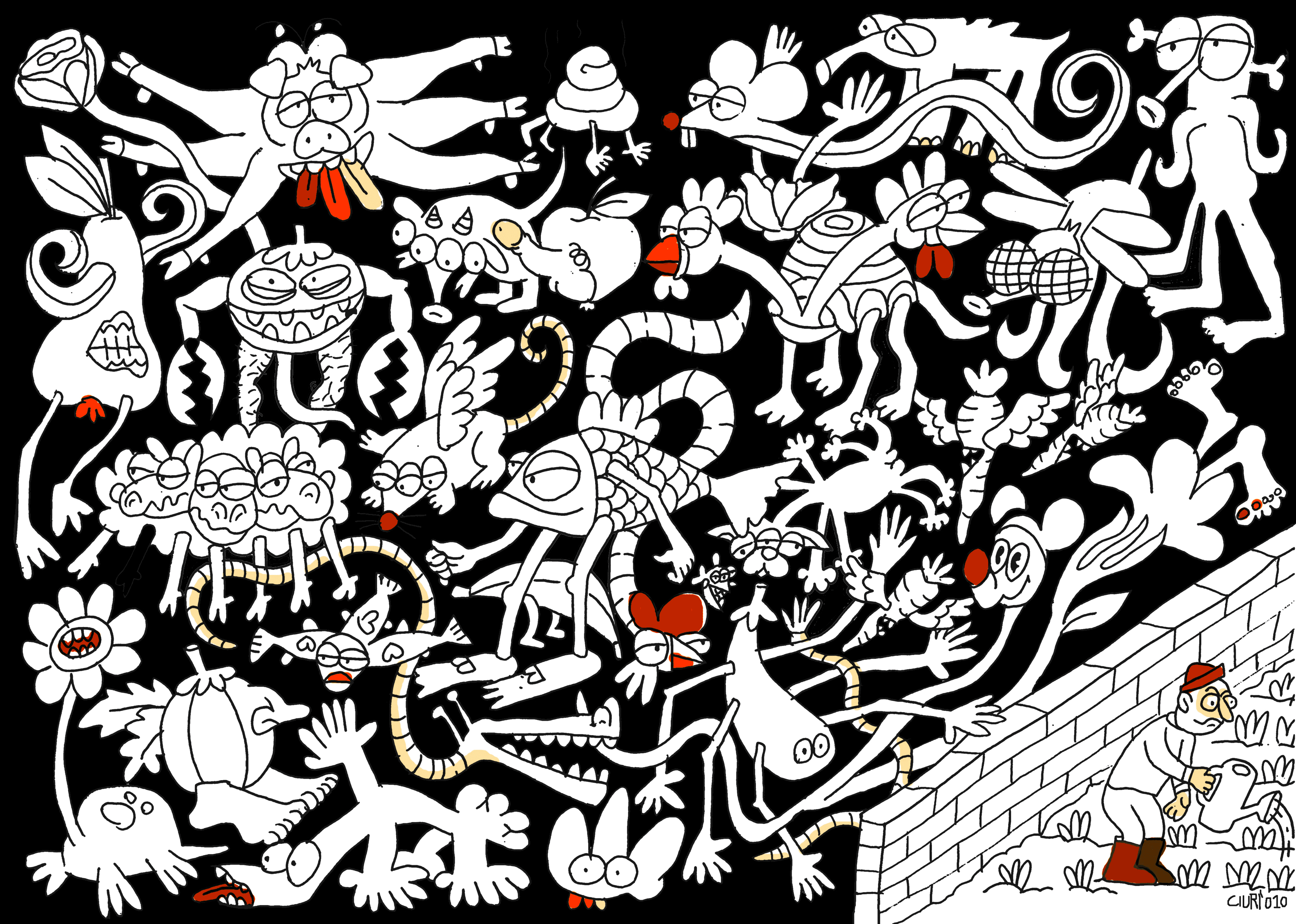
Il movimento operaio nella sua storia plurisecolare ha avuto il merito di inventare di volta in volta forme nuove e spiazzanti di mobilitazione, che hanno avuto la capacità di mettere in difficoltà padroni e governi apparentemente invincibili. Una delle pratiche che in Italia, soprattutto negli anni successivi alla seconda guerra mondiale, ha avuto maggiore incisività è stata lo sciopero alla rovescia.
L’Italia che usciva dalla guerra era un paese devastato, pieno di macerie e privo delle infrastrutture minime necessarie alla ripresa. Strade interrotte, ponti distrutti, quartieri abbandonati. L’intervento delle istituzioni però si muoveva a corrente alternata e le carenze infrastrutturali costituirono a lungo terreno di conflitto e di mobilitazione.
Già nel pieno della seconda guerra mondiale era iniziata una campagna di riappropriazione che continuò anche a guerra finita e che i governi difficilmente riuscirono a contenere. Il volto più visibile di questa riappropriazione fu l’occupazione delle terre, nelle campagne di tutta Italia, soprattutto al sud, pratica che dimostrava la capacità da parte delle classi subalterne non solo di protestare per la propria condizione ma anche di saper gestire in modo alternativo un pezzo importante di economia e di territorio, rovesciando assetti proprietari che le vedevano sottomesse da secoli.
Ben presto all’occupazione delle terre si affiancò un’altra pratica, diffusa trasversalmente nelle borgate delle grandi città e nei piccoli comuni, nelle campagne, nelle zone di montagna e nelle aree urbane: lo sciopero alla rovescia. I partiti di sinistra e la Cgil, nelle sue varie forme organizzative, individuavano dopo assemblee pubbliche un obiettivo comune su cui intervenire con i propri militanti: selciare una strada, pulire gli argini di un fiume, sistemare un terreno dissestato, riparare condotte idriche.
Grazie alle capacità tecniche di migliaia di lavoratori e disoccupati, gli scioperi alla rovescia restituivano alla comunità beni pubblici altrimenti inutilizzabili. Il lavoro gratuito non era però fine a se stesso ma legato alla protesta verso lo stato, che nelle sue varie articolazioni aveva deciso di non investire in opere di pubblica utilità e di non far lavorare i disoccupati. E lo stato reagiva in modo spietato: non si contano i feriti e anche i morti a seguito degli interventi della polizia durante gli scioperi alla rovescia, per non dire degli arresti, del carcere e dei processi. Il conflitto innescato dagli scioperi alla rovescia determinò la crescita di un movimento sociale militante capace di lottare contro la disoccupazione e di strappare, pur se con costi altissimi, stanziamenti e investimenti finalizzati a interventi di miglioramento del territorio, dei trasporti, delle infrastrutture.
Nell’Italia di oggi si torna a parlare sempre più spesso di lavoro gratuito, di volontariato, di impegno civico volto a combattere il cosiddetto “degrado”. In tanti si attivano per fare quello che le istituzioni non fanno. I genitori ridipingono le aule dove i propri figli vanno a scuola. Cittadini volenterosi si armano di scope e ramazze e ripuliscono parchi e giardini. L’elenco potrebbe continuare a lungo, aggiungendo azioni ancora più mirate e a volte difficilmente comprensibili quali lo sbiancamento dei muri o dei vagoni dei treni dipinti di graffiti o la rimozione degli adesivi dalle serrande dei negozi.
Si fa un gran parlare di queste azioni, i giornali le esaltano come buone pratiche che mettono ordine nella città e addirittura i politici le incoraggiano, mettendo anche a disposizione materiali per la pulizia o comparendo nelle foto ricordo a fianco dei ripulitori, alcuni dei quali si definiscono retakers. Ma cosa si riprendono questi retakers? Perché il loro lavoro anziché essere utile alla riconquista dei beni pubblici rappresenta invece l’antefatto della privatizzazione e della smobilitazione del settore pubblico? La risposta è molto semplice e per certi versi disarmante: l’enfasi dei retakers sul degrado mette in secondo piano le responsabilità istituzionali di chi ha creato tale degrado. E infatti sindaci, assessori, consiglieri, amministratori delegati di imprese a partecipazione pubblica non fanno altro che gioire di fronte a queste azioni.
Roma è una delle città in cui questo processo sembra più avanzato. Le scuole sono sempre più abbandonate e gli edifici cadono a pezzi? Il comune nel 2014 ha proposto un albo dei genitori abilitati e investiti dall’autorità istituzionale a intervenire per pulire e sistemare le aule. La raccolta della spazzatura è gestita in modo sciatto e poco razionale? La stessa Ama (Azienda municipale ambiente) rifornisce i cittadini volenterosi di scope e palette per pulire le rispettive strade.
A questa nuova ondata di “civismo” manca un elemento essenziale, senza il quale ogni intervento rischia di rappresentare solo un tappabuchi e un ottimo antidoto all’inadempienza delle istituzioni: manca il senso del conflitto verso le istituzioni stesse, la voglia di rivendicare un intervento del settore pubblico efficiente, trasparente e libero da clientele e condizionamenti. Senza questa spinta il protagonismo dei cittadini spiana la strada alla ritirata del settore pubblico, anzi favorisce il processo di privatizzazione.
Inizialmente, si configura una sorta di “autogestione dall’alto”, per cui tale protagonismo viene di fatto gestito e strumentalizzato dagli stessi responsabili del dissesto. Da qui alla privatizzazione, poi, il passo è breve. Gli effetti collaterali di tale processo sono sotto gli occhi di tutti. Il principale avversario del retaker non è il sistema politico e istituzionale che ha scelto altre priorità rispetto alla cura del territorio ma il giovane attacchino – spesso straniero – accusato di imbrattare i beni pubblici perché attacca un adesivo su una serranda o lo zingaro che fruga nel cassonetto. Non importa se sotto casa tua hanno costruito palazzi o supermercati speculando nel modo più increscioso, non importa se ti hanno tagliato i posti all’asilo nido o se ti hanno cancellato l’unico autobus che ti porta in centro: il problema è il volantino A4 che imbratta un muro.
Per fortuna Roma è una città dove ne succedono tante e qualcuno nel pieno della crisi si è accorto che il nostro passato recente non è proprio tutto da buttare via. Gruppi organizzati di disoccupati hanno iniziato a pulire e rendere agibili alcuni beni pubblici in una delle zone considerate più problematiche della periferia romana: Ponte di Nona. Ma allo stesso tempo hanno manifestato contro il comune per rivendicare una diversa assegnazione degli appalti pubblici, la cui cattiva gestione ha contribuito in modo determinante a rendere invivibile quel quartiere. Per non dire delle tantissime occupazioni a scopo sociale o abitativo di luoghi dismessi, che cercano di aprire spazi di conflitto e di vertenzialità con le amministrazioni ma allo stesso tempo liberano aree destinate all’abbandono o alla speculazione. È lo sciopero alla rovescia del Duemila: un possibile strumento per contrastare non solo la disoccupazione ma anche la privatizzazione e la cooptazione del protagonismo sociale.
In tempi di tagli e di generale ritirata del pubblico, ci troveremo sempre più spesso a fare i conti con queste dinamiche. Di fronte a servizi meno efficienti, la tendenza all’autorganizzazione è naturale ed è anche una sana alternativa alla rassegnazione. Sarà utile però ricominciare a mettere per bene in fila priorità, responsabilità, confini e paletti tra pubblico e privato, tra mutuo appoggio e autogestione dall’alto, per non dare l’assist decisivo a chi sta pianificando lo smantellamento del pubblico e l’avanzata della privatizzazione, intesa non solo come processo economico. Dal passato c’è ancora moltissimo da imparare. (michele colucci)



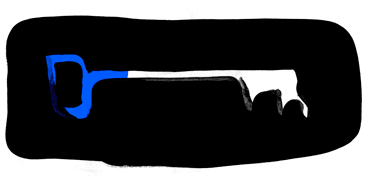
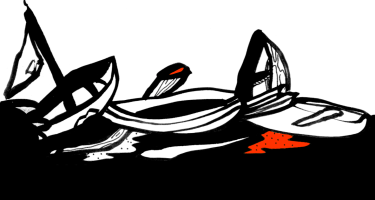
Dato che appartengo al movimento retake roma mi sento chiamata in causa e dunque rispondo. Subito con un paio di precisazioni tecniche: da anni tutti i quartieri intorno al gra sono vittime di roghi di materiale plastico di tale portata da costringere le persone a non aprire mai le finestre. Non sono ancora noti gli effetti sulla salute, anche se si sa con certezza che respirare diossina non fa bene a nessuno. Questi roghi sono il risultato del lavoro di tantissimi poveracci semischiavizzati che offrono sgomberi e traslochi a prezzi stracciati per poi separare la plastica dal metallo con fuochi en plain air. Metalli riciclati che poi magicamente rientrano nell’economia legale! Quindi staccare gli adesivi, non significa affatto prendersela con il poveraccio di turno, ma denunciare un giro economico basato sullo sfruttamento dei deboli e sull’inquinamento di interi quadranti di città. Significa quindi pretendere dalle istituzioni un deciso cambio di passo per esempio nella gestione dei rifiuti. Analoga è la questione dei treni vandalizzati: sono la prova che chiunque può entrare nei depositi dei treni sia di atac che di fs e fare qualunque cosa: dipingere, ma anche sabotare, minare, ecc. Anche in questo caso poniamo l’accento sulle inefficienze gestionali, al punto che, contrariamente a quanto suggerito nell’articolo, non sono poche le istituzioni che ci considerano dei rompi scatole. Collaboriamo invece con ama, e devo dire che frequentare gli operatori ecologici di roma (posso considerarli classe operaia?) aiuta molto a capire chi sono i responsabii del gran casino in cui versa roma, lo consiglio a tutti. Come mi è stato recentemente fatto notare da un operatore ama, se tutti si comportassero bene, loro dovrebbero occuparsi solo di svuotare i cassonetti e spazzare le foglie. Non fare la caccia al tesoro per trovare le migliaia di discarichette abusive che punteggiano tutta la città, sempre grazie ai gestori di traslochi abusivi. Vogiamo ancora parlare di diritti? Perché non riconoscere che le migliaia di bacarelle di mutandari di fatto impediscono la libera circolazione di una parte importante della cittadinanza, cioè tutti quelli che non sono super atleti, ma magari hanno qualche difficoltà, come anziani, disabili, ecc. Pretendere marciapiedi sgombri non è una fisima di persone fissate con il decoro, è pretendere uno dei diritti basilari di ciascuno di noi, cioè il diritto di uscire di casa. E perché devo essere attaccatacse peso che scuole belle e curate non possono essere solo quelle private, ma anche quelle pubbliche? Stanare dirigenti scolastici con progetti non rifiutabili significa obbigarli a riconoscere che scuole funzionali, pulite e anche belle sono un diritto di ogni allievo, che loro sono tenuti a garantire.Potrei continuare con decine di altri esempi, ma mi fermo qui e passo ad un piano più generale. Le stesse osservazioni, le stesse parole su di noi sono ormai pubblicate a cadenza regolare da chiunque, a partire dallo speciale di zero calcare su la repubblica la scorsa primavera. Chiunque lo abbia fatto è stato invitato a prendere parte ad uno dei nostri incontri, ma nessuno si è presentato. È netta la sensazione che si tratti di persone che parlano di cose e persone che non conoscono, partendo dal presupposto che ciò che esula dai lori schemi preesistenti, non possa essere niente di buono. Sinceramente avvilisce assistere a questa mancanza di curiosità, specialmente da parte di chi si attribuisce capacità critiche miitanti. La invito quindi a parteciare e poi discutere di quello a cui ha partecipato. Le assicuro che fare retake, toccare con mano la propria città, apre molto gli occhi su quello che accade, costruzione di quartieri invivibili, ruberie, gestione malsana dei servizi., gestioni private di spazi pubblici. Proprio il contrario di quanto afferma: sappiamo e critichiamo molto della gestione pubblica, e stiamo molto attenti a non farci strumentalizzare. Il pensiero critico lo esercitiamo pure noi, provare per credere!
Salve,
direi che al post di Elena almeno una risposta la si debba dare. Altrimenti si rischia di passare per quelli che hanno poco da dire.
quello che avevamo da dire è nell’articolo
nm