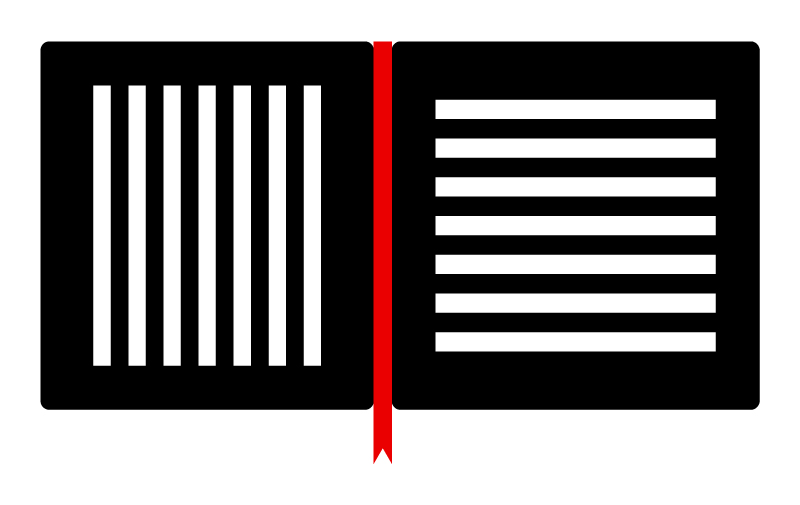
Le giornate afose non rallentano le linee di smistamento dell’interporto, i tir sono sempre in coda all’ingresso dei magazzini e gli operai caricano e scaricano le merci con gli stessi ritmi. Cambiano le coltivazioni che si alternano con le stagioni, ma il resto è identico.
Dimitri è in Italia da molti anni e lavora all’Antico Ristoro, a ridosso dei magazzini e a poche centinaia di metri dal carcere di Santa Maria. La piccola trattoria è in mezzo alla statale che collega Santa Maria Capua Vetere con Teverola e accoglie chi si trova di passaggio sulla strada. Ci confessa che non ricorda il maxiprocesso che si sta celebrando nell’aula bunker, allora gli raccontiamo delle immagini del “corridoio umano”, dei poliziotti in assetto anti sommossa che colpivano con manganellate e testate i detenuti che si paravano davanti. «Si, ora mi ricordo, ma io credevo che fossero stati assolti. Finirà così e qualcuno farà anche carriera…». Gli ricordiamo che non si è celebrato ancora il dibattimento e non c’è sentenza sulle responsabilità individuali.
Mentre raccontiamo del processo la memoria recupera le immagini dei dirigenti delle forze dell’ordine e dei loro successi professionali dopo le condanne definitive per i fatti del G8 del 2001. Quella storia racconta anche la forza di protezione scatenata dagli apparati del ministero dell’interno nei riguardi dei pubblici ufficiali che hanno adempiuto al “mandato di servizio”.
Dimitri si appresta ad accogliere alcuni operai. Il suo movimento interrompe i nostri i pensieri, scambiamo un cenno di saluto e ci concentriamo sul piatto di pasta.
* * *
Il giudice D’Angelo ha sciolto la riserva il 12 luglio scorso, dopo aver ascoltato le discussioni delle difese degli imputati e le brevi repliche della procura. Anche questa volta dalle parole degli attori del processo sono emersi elementi indicativi rispetto alla composizione degli interessi delle parti e delle strategie per difenderli. Gli avvocati degli imputati (soprattutto dei dirigenti della polizia penitenziaria e degli agenti che hanno effettuato la “perquisizione straordinaria”) hanno difeso la legittimità dell’ingresso in istituto: non si trattò di un “atto abnorme”, ma costituì secondo loro una misura necessaria per affrontare il pericolo “concreto” di una insubordinazione armata preparata il giorno precedente.
«Signor giudice, il barricamento del 5 aprile è un fatto reale!». Il tentativo dei difensori è chiaro, bisogna ridurre le “superfetazioni del racconto” lasciando trasparire dalle costruzioni della procura e dalle cronache dei media quanto è accaduto realmente.
«Ci troviamo di fronte a uno tra i processi più delicati dell’intera nazione, in cui sono coinvolti molti appartenenti alle forze di polizie penitenziaria di diverso grado…», afferma un avvocato richiamando l’attenzione del giudice prima di ricostruire gli avvenimenti antecedenti al 6 aprile.
Gli avvocati si sono concentrati sul clima di tensione che viveva il paese durante i primi mesi dell’emergenza pandemica, avvertito in modo particolare nelle carceri dopo le rivolte nel mese di marzo. In questo quadro hanno operato un acrobatico capovolgimento dei ruoli perché le vittime dovrebbero identificarsi con gli agenti di polizia penitenziaria, mandati al macello per gestire i momenti di crisi. Al fronte, lontani dai posti di comando, sarebbero stati i soli a sporcarsi le mani mantenendo l’ordine senza batter ciglio. Di fatto, nelle discussioni degli avvocati e degli imputati che si sono confrontati direttamente con il tribunale, il contesto emergenziale è diventato un protagonista indiscusso, un presupposto necessario per offrire una giustificazione alle condotte più discutibili. Una forza motrice irrefrenabile che ha guidato la mano degli attori.
«La polizia penitenziaria è un corpo militarmente organizzato e, pertanto, l’ordine dei superiori non può essere messo in discussione», hanno recuperato gli avvocati la retorica strategia difensiva dei corpi militari, rispetto alla capacità di autodeterminarsi nello svolgimento delle proprie mansioni. Per quanto concerne invece l’ipotesi di “tortura”, secondo le difese questa costruzione giuridica è scarsamente interpretativa: bisogna isolare i singoli frame, identificare esattamente il soggetto e la condotta tenuta durante il 6 e nei giorni seguenti perché il singolo schiaffo, calcio o la testata non possono essere intesi come tortura.
Nell’udienza precedente il provveditore Fullone aveva rotto il silenzio – «dovuto alla gravità delle accuse che mi sono state mosse» –, rilasciando spontanee dichiarazioni e soffermandosi sul contesto in cui operava l’amministrazione penitenziaria regionale in quella fase, un «…momento storico di così grave difficoltà… il 7 aprile mi trovavo nell’ufficio come parafulmine…». La linea del provveditore sembra simile a quella degli altri superiori della penitenziaria perché, dopo aver ricostruito l’l’impatto della pandemia sulle istituzioni carcerarie campane, ha rimarcato la propria estraneità dalle condotte violente distanziandosi da quanto accaduto anche alla luce della sua carriera professionale. Dalle sue dichiarazioni sembrerebbe che il vertice regionale dell’amministrazione sia stato indotto in errore dai dirigenti della penitenziaria rispetto alla valutazione degli eventi del 5 aprile (la protesta dei detenuti). Di conseguenza tutta la responsabilità andrebbe ricercata nel personale di polizia che avrebbe “provocato” un intervento “straordinario” per recuperare l’ordine interno.
Tuttavia, al di là delle suggestioni difensive, il complesso impianto investigativo costituito da una documentazione fitta, ore di registrato del circuito di videosorveglianza, le numerose intercettazioni, le denunce precise dei detenuti, le evidenze emerse dagli interrogatori di garanzia, delineano un ventaglio di responsabilità ampio che soltanto l’ulteriore fase dibattimentale riuscirà circoscrivere nel dettaglio. Sulla base di questi elementi, la procura ha controbattuto sostenendo che le difese hanno costruito un’interpretazione miope. Difatti, è impossibile slegare le singole condotte dalla dinamica sistemica in cui i singoli agenti hanno agito. Un’azione preordinata secondo schemi conosciuti: sputi, schiaffi, calci, minacce, il corridoio umano, non possono essere separati tra loro, si reggono insieme perché sono l’estrinsecazione di un piano preordinato. La perquisizione era progettata per fiaccare il carattere dei detenuti e ripristinare un rapporto di forza a vantaggio del personale in istituto. Il Nilo doveva essere placato e bisognava ripristinare il regime maggiormente punitivo delle celle chiuse per agevolare il lavoro del corpo di guardia. Le intercettazioni costituiscono quasi una “confessione materiale”, ed emerge chiaramente che tra il 5 e il 6 c’è stata una “chiamata alle armi”, tanto che l’intenzione della perquisizione straordinaria è rinvenibile dalle conversazioni prima dell’arrivo dei “lupi”: «U tiemp re buoni azioni è fernut». Bisognava abbattere i vitelli.
Questi elementi hanno indotto il giudice dell’udienza preliminare a chiudere questa fase processuale con un decreto che dispone il giudizio per centocinque imputati dinanzi alla Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere il 7 novembre.
* * *
Finisce così il primo momento processuale di questa vicenda, durato circa sette mesi, che ci lascia poche certezze.
Nell’aula bunker si vive una tensione costante, il tempo sembra essersi fermato e in ogni udienza è come se si ripartisse dall’anno 2020. Oltre al muro di cinta, la mattanza della Settimana Santa sembra essersi alleggerita fino a scomparire. La nostra dimensione temporale quotidiana è schiacciata sul presente ed è accelerata dal confronto con le emergenze individuali e collettive. È un movimento confuso che produce la rimozione continua del passato dalla memoria. Ricordare, ricucire, sovrapporre e intrecciare le trame delle storie sono percepiti come movimenti scomposti e disarmonici, pertanto lo sforzo di annodare i fili del processo diventa necessario: attraverso la lente di ingrandimento dell’aula bunker possiamo ricomporre sia le interazioni avvenute nella catena di comando istituzionale che la misura del potere, osservando le tecniche più feroci adoperate per rendere docili i corpi.
La reazione alla perdita di controllo è stata magnificente, per un attimo il nostro sistema punitivo ha scricchiolato talmente forte che sembrò potesse rompersi definitivamente. Non sappiamo cosa accadrà nei prossimi anni e quale sarà l’esito del processo, quali verità verranno fuori. Dopo i fatti di Santa Maria, però, è difficile prevedere la capacità di assorbimento del sistema contenitivo rispetto alla disoccupazione crescente e all’impoverimento rapido e progressivo di ampie fasce della popolazione. Per gestire questi numeri, il sistema può soltanto intensificare la guerra agli esclusi su ogni fronte, ma le risorse che hanno a disposizione non sono infinite.
Per quanto tempo riusciranno a reggere i fronti? (napolimonitor)




Leave a Reply