
Sarà presentato a Napoli martedì 29 giugno a palazzo Venezia (via Benedetto Croce, 19), a partire dalle 18:00, il numero 6 della rivista Lo stato delle città. Di transizione ecologica e lotte ambientali discuteranno Salvatore De Rosa e Paola Imperatore, collaboratori della rivista e rispettivamente ricercatore e dottoranda delle università di Lund (Svezia) e Pisa. Dello stesso Salvatore De Rosa pubblichamo a seguire un articolo su questi temi apparso nell’ultimo numero della rivista.
***
Nel vicino futuro, un’ondata di calore attraversa il nord dell’India. Durante una settimana di temperature e umidità estreme, uccide venti milioni di persone. Questo presagio apre Il Ministero del Futuro, l’ultimo romanzo di Kim Stanley Robinson, autore americano di narrativa climatica. Visualizzare il mondo in preda al collasso ecologico è ormai parte dell’inconscio collettivo quando non dell’esperienza diretta. Ma Robinson non vi indugia. Parte dai fallimenti del presente nell’affrontare la crisi climatica per tracciare i passaggi che potrebbero alterare la traiettoria ecocida e riformare le relazioni tra società e atmosfera. Il Ministero del titolo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, opera per conto delle generazioni future e di tutte le creature viventi escluse dalla deliberazione politica. Il proliferare di eventi climatici estremi innesca una serie di attentati eco-terroristici da parte dei sopravvissuti ai disastri contro manager di aziende inquinanti, aeroplani, infrastrutture estrattive e allevamenti industriali. L’urgenza fa confluire gli sforzi internazionali e moltiplica la disobbedienza civile di massa. Le alternative alla civiltà fondata sul fossile si espandono. Il Ministero convince gli stati a spegnere le fornaci, a regolare il mercato e a riformare il sistema finanziario, reiscrivendo l’economia entro i limiti planetari e gettando le basi per l’eco-socialismo del ventunesimo secolo. Una diversità di tattiche dal basso e dall’alto, la giusta congiuntura e lo slancio utopico per costruire oltre l’apparente immutabilità degli assetti attuali, pur basandosi sulle concrete possibilità disponibili, sono le risposte di cui abbiamo bisogno, secondo Robinson, per non accettare supinamente il disgregarsi del mondo.
Il presente pandemico potrebbe diventare la nostra congiuntura? Nel 2020 il rallentamento dell’economia globale a causa del virus si è tradotto in una contrazione delle emissioni totali di gas serra del 7% rispetto al 2019, ma al prezzo di sofferenze collettive. Le risposte dei governi per salvare questo sistema sono gli investimenti giganteschi dei piani di recovery e green new deal. È l’ultima decade che ci rimane per non superare soglie di riscaldamento apocalittiche e difficilmente sarà possibile mobilitare simili risorse nel vicino futuro. Ogni dollaro o euro investito conta. Le avvisaglie non confortano. Un rapporto del Programma Ambientale ha analizzato i piani di ripresa delle maggiori economie al mondo (esclusa l’Europa, che attende i piani nazionali per allocare i fondi del Next Generation EU), concludendo che dei quasi duemila miliardi di dollari impegnati per misure di ripresa a medio e lungo termine, solo il 18% è orientato verso progetti che diminuiranno le emissioni. Le economie più grandi restano nel solco dei combustibili fossili. Legate a doppio filo ai piani di ripresa, le promesse di contributi volontari alle riduzioni di emissioni già consegnate alle Nazioni Unite (da settantacinque paesi che coprono circa il 30% di emissioni) in vista della COP26 di Glasgow del prossimo novembre, non arrivano neppure a una riduzione dell’1% entro il 2030 rispetto al 2010, lontano dal 45% necessario per avere qualche chance di restare entro 1,5 C di riscaldamento. Un altro rapporto alla fine del 2019 rimarcava che sarebbero necessarie riduzioni globali annuali del 7,6%. E se si volesse assecondare il principio delle “responsabilità comuni ma differenziate e le rispettive capacità dei paesi”, come da preambolo degli accordi di Parigi, i paesi con la maggiore responsabilità delle emissioni storiche già accumulate in atmosfera dovrebbero operare riduzioni nell’ordine del 10-12% annuo.
La finanza globale non è da meno. Il dossier Banking on climate chaos 2021 rivela che, nei cinque anni trascorsi dagli accordi di Parigi, le sessanta banche più grandi al mondo hanno pompato oltre 3.800 miliardi di dollari nell’industria dei combustibili fossili. Nel mezzo della recessione del 2020 i finanziamenti alle cento società più responsabili dell’espansione del fossile sono aumentati del 10%. Guida la classifica l’americana JP Morgan Chase; poco sotto le italiane Unicredit e Intesa Sanpaolo. Tutte le banche in questione si sono impegnate a supportare la transizione verso un’economia a basso contenuto di carbonio, continuando però a razzolare in gas, petrolio e carbone. Dal canto loro, le multinazionali del fossile come BP e Shell hanno dichiarato obiettivi di “zero netto entro il 2050”, autoproclamandosi “leader climatici”. Allo stesso tempo, intendono estrarre e bruciare il 120% in più di combustibili rispetto ai limiti condivisi per mantenere il pianeta al di sotto di 1,5 C di riscaldamento.
Per capire come sia possibile promettere la neutralità climatica continuando l’estrazione e il consumo dei combustibili fossili occorre sfatare l’illusione della “transizione”, quella particolare forma di dissociazione che gli ingegneri del consenso hanno insinuato nel senso comune attraverso le parole d’ordine di “zero netto” e “compensazioni”. Tutto inizia dalle promesse di neutralità climatica, ossia l’obiettivo dello zero netto di emissioni, che l’Italia e l’Europa hanno posto al 2050. Zero netto non significa zero emissioni. Significa continuare a utilizzare combustibili fossili provando a compensare le emissioni generate attraverso l’aumento di assorbitori, naturali o artificiali, di carbonio. Sono almeno due decadi che mercati di carbonio internazionali e istituzioni come il Meccanismo di Sviluppo Sostenibile aprono la pista alla domanda di compensazioni. Questi metodi emergono ora dai meandri delle politiche climatiche per egemonizzare le risposte alla crisi.
Contano come compensazioni gli investimenti in energia rinnovabile nei paesi in via di sviluppo, le tecnologie che estraggono carbonio direttamente dall’aria, la preservazione di ecosistemi e la piantumazione di alberi. Le ultime due, definite “soluzioni naturali”, stanno generando una nuova corsa alla valutazione economica e finanziaria della natura, e all’appropriazione di vaste estensioni di terra per progetti di sequestro di carbonio, localizzate per la massima parte nel sud del mondo. Territori che rischiano di passare dallo sfruttamento intensivo alle nuove “fortezze della de-carbonizzazione”: aree off limits dove ecosistemi ristorati e monocolture di alberi “lavorano” per compensare le emissioni. A parte la sostanziale incertezza che circonda la fisica di questi approcci, il rischio è che si accumuli più CO2 di quanta ne possa essere rimossa. Inoltre, attualmente le compensazioni vengono adoperate per coprire ulteriori emissioni e non emissioni residuali in seguito a riduzioni effettive. Ciò non comporta alcuna riduzione assoluta delle emissioni totali, quello di cui abbiamo bisogno. Continuare a bruciare combustibili fossili presume che le nuove foreste ne assorbiranno le emissioni in eccesso per millenni nel futuro, condannando preventivamente le comunità locali a pagarne il costo. Attraverso gli schemi di scambio e compensazione di carbonio, gli inquinatori riproducono lo status quo presentandosi come attori responsabili. Il colmo dell’ironia è che le stesse banche e istituti finanziari che investono nell’industria fossile sono in prima linea per sviluppare gli standard e le regole del mercato delle compensazioni.
È la riduzione del riscaldamento globale unicamente a una questione di carbonio nell’aria che permette la fantasia delle compensazioni, astraendo in una molecola le profonde articolazioni storiche, politiche e sociali della crisi climatica. L’infinita complessità delle relazioni ecologiche e l’interdipendenza tra ambienti e configurazioni sociali e culturali vanno perse nel feticismo del carbonio. Le responsabilità storiche, le relazioni di potere ineguale e l’insostenibilità di un sistema condannato alla crescita infinita per continuare a funzionare, evaporano davanti alla CO2 tramutata in idolo laico. È sulla base di queste astrazioni che si spiega l’enfasi sulle emissioni individuali – con la pletora di inviti al cittadino a “fare la sua parte” – deviando l’attenzione da cambiamenti sistemici e da regolazioni stringenti alla fonte. Certo che le emissioni devono essere azzerate, e gli ecosistemi preservati, ma chi, come, quando e dove sono domande politiche che bisogna riportare in primo piano per scongiurare la prospettiva di un apartheid climatico globale, in cui un capitalismo rinnovato dalla (supposta) neutralità climatica disegni nuove zone di emissione e di assorbimento, rinsaldi i confini tra periferie invivibili e nazioni e città smart, e approfondisca le ineguaglianze tra i sommersi (letteralmente) e i salvati. E queste domande bisogna porle subito, prima che eventi atmosferici sempre più estremi rendano accettabili tecnologie di geo-ingegneria – dall’aerosol nell’atmosfera per oscurare il sole al creare nuvole artificiali – di dubbia utilità e con effetti collaterali potenzialmente devastanti.
L’evoluzione delle politiche climatiche autorizza a dichiarare il fallimento degli appelli a governi e multinazionali, la strategia finora perseguita da Extinction Rebellion e da Fridays for Future. Gli appelli hanno funzionato, la crisi climatica è salita in cima all’agenda globale e molti governi hanno dichiarato l’emergenza climatica (una delle richieste di XR). Ma il risultato sono state promesse di zero netto e compensazioni. La lezione è, primo, che il ruolo dei movimenti sociali non può ridursi agli appelli; secondo, che va sviluppata una forza sociale radicata nei territori e collegata a reti nazionali e internazionali capace di rispondere colpo su colpo al dispiegarsi di vecchie dinamiche di sfruttamento e di nuove “soluzioni” climatiche.
In Italia e in Europa la dissociazione tra ambizioni dichiarate e pratiche effettive si esprime anche attraverso un’altra parola d’ordine della transizione illusoria: i combustibili “ponte”, un mito spacciato dai produttori di gas fossile per vendere la propria merce, suggerendo che per arrivare al 100% di rinnovabili si debba passare necessariamente per il gas fossile. In Italia sono pianificati entro questa decade impianti termoelettrici a ciclo combinato alimentati a gas per 14 GW, collegati a una ragnatela di gasdotti in costruzione per le importazioni. È questa la strategia, delineata nel Piano Nazionale Clima e Energia, per superare le centrali a carbone entro il 2025. Nell’ultimo elenco dell’Ue di progetti prioritari di infrastrutture energetiche che beneficiano di autorizzazioni semplificate e finanziamenti, ci sono trentadue progetti di gas fossile premiati con ventinove miliardi di euro. Il gasdotto Tap Snam in costruzione sulla costa pugliese per portare nel continente il gas dall’Azerbaijan è uno di questi. I legami tra gas, rivolta e repressione nell’era della crisi climatica in questo territorio sono paradigmatici per capire i limiti degli attuali progetti di transizione.
Oltre al Tap Snam sulla costa leccese, nel raggio di pochi chilometri, insisteranno tre centrali a turbogas – la A2A di Costa Morena, l’Enel di Cerano e l’EniPower –, un deposito di gas liquido e il petrolchimico Eni Versalis. Il movimento civico che sta provando a fermare il Tap non accetta che la Puglia diventi un hub del gas contro ogni opportunità climatica, sanitaria ed economica. Il primo aprile di quattro anni fa, duemila persone insorsero alla masseria San Basilio all’inizio dei lavori. A seguito di quella e altre manifestazioni sono state emesse a metà marzo sessantasette sentenze di condanna nel processo di primo grado contro gli attivisti del movimento, comminando pene comprese tra i tre anni e i tre mesi, e multe pecuniarie. È questa una tendenza repressiva che attraversa molti dei conflitti in corso in Italia. Solo nel mese di marzo, attivisti No Tav, sindacalisti a Piacenza, e lavoratori del porto di Genova, sono stati raggiunti da arresti e denunce pesantissime. Ambiente, guerra e lavoro, fronti comuni di un’unica lotta. Il potere lo ha capito, e sincronizza la repressione. Per questo a noi spetta di ricomporre la rivolta: per fermare l’illusione della transizione e chiarire che sarà o trasformazione o barbarie.



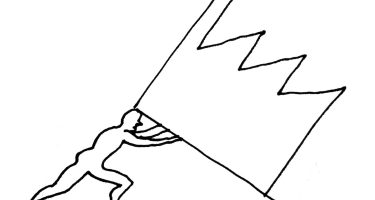

Leave a Reply