
da: Horatio Post
Dopo i quartieri orientali di San Giovanni, Ponticelli e Barra, continua a occidente, tra le colline flegree, il viaggio nei casali di Napoli, ripercorrendo la “corona di spine” di Francesco Saverio Nitti. Fino al 1926 erano comuni autonomi, coi loro santi patroni, cultura ed economia, l’unione col capoluogo ne ha stravolto per sempre il destino, declassandoli a periferia. Per tutti loro, a est come a ovest, a distanza di novant’anni, l’integrazione vera con Napoli, qualunque cosa questo significhi, è una questione ancora aperta.
All’estremo ovest c’è Pianura: nelle foto aeree scattate dagli Alleati nei primi anni Cinquanta per il piano Marshall, queste terre sono ancora un giardino, la conca è tutta un ricamo di filari di vite e piante da frutto, le selve di castagno sui versanti dei Camaldoli sono curate come un salotto, e il casale – novemila anime in tutto – è un borgo a forma di croce, attorno alla chiesa madre di San Giorgio.
«Eravamo felici». mi dice Vittorio Balestrieri, il decano degli agricoltori di Pianura. «In contrada Torciolano si viveva insieme, una quarantina di famiglie, tutt’intorno a Masseria Grande, il forno e il torchio erano in comune, c’erano le stalle, papà coltivava patate, ortaggi, frutta, e pure il grano. Lo accompagnavo col cavallo e il carretto al mercato ortofrutticolo, traversavamo tutta la città, tra un quartiere e l’altro di Napoli c’era solo campagna. Le nostre patate soprattutto erano assai richieste, il suolo vulcanico fertilissimo le rende particolarmente profumate e sapide». Don Vittorio non lo sa, ma il suo è il racconto di una villaggio rurale (il vicus) col suo territorio agricolo (il pagus), un modello di vita comunitario che risale a duemilacinquecento anni fa.
«Poi comprammo la macchina, in tutta Pianura ce n’erano solo tre, intanto il mondo stava cambiando, andammo tutti a vedere Kennedy, il presidente in visita a Napoli percorse il viale da Bagnoli tra due ali di folla. Erano i primi anni Sessanta, la famiglia era cresciuta, facemmo domanda al comune per ristrutturare l’antica casa colonica, ma non arrivò mai risposta. Passarono i vigili, e ci dissero che era inutile aspettare, che potevamo regolarci da soli, della licenza non c’era bisogno… Fu il rompete le righe, la campagna intorno diventò un enorme cantiere, la nostra azienda agricola si è salvata solo perché sta dentro il vincolo cimiteriale». Così l’antico casale, senza regole, è deflagrato: nel ’51 le aree urbanizzate erano quattordici ettari, oggi sono quattrocentottanta, la città è cresciuta di quasi quaranta volte.
Mentre il casale tutt’attorno diventava città, Don Vittorio ha resistito con la sua masseria, come un samurai, ha conservato i suoi quattro ettari di frutteto, e le stalle con venti vacche marchigiane allevate come si deve. Fare zootecnia in città è difficile a causa dei vincoli e delle norme, è un paradosso che debba considerarsi intruso proprio chi il territorio agricolo l’ha difeso. Vittorio vende i suoi prodotti in azienda, è la dimostrazione che l’agricoltura in città è una cosa seria, ma il gioiello ora è il ristorante, con il dipartimento di Veterinaria ha installato un sistema innovativo di frollatura delle carni, i sensori del computer controllano in continuo il processo, la bistecca di marchigiana frollata quaranta giorni è da svenimento, e le ricerche hanno dimostrato che il trattamento arricchisce la carne di molecole protettive, benefiche.
«Nel discorso pubblico la responsabilità del sacco edilizio – mi dice Pasquale Belfiore, docente di architettura dell’Università Luigi Vanvitelli, assessore all’edilizia nella giunta Iervolino – è attribuita in massima parte ad Achille Lauro, che però finì di amministrare nel 1961. Certo, se era stato il Comandante a dare il via alla deregulation, negli anni Sessanta furono le amministrazioni democristiane e i commissari governativi a mettere in pratica il disegno, almeno fino al piano regolatore del ’72. Con questo il governo centrale cercò di correre ai ripari, fu l’ultimo intervento dello stato prima che le competenze passassero alle regioni, ma lo strumento era tutto basato sulla redazione di piani particolareggiati, che nessuno fece mai, e così l’attività amministrativa in materia urbanistica si bloccò di nuovo».
Un altro aspetto chiave lo sottolinea Vezio De Lucia, una vita da urbanista pubblico, dalla direzione del ministero a quella del PRG di Napoli con la prima giunta Bassolino: «Con Lauro almeno un timbro sotto la domanda l’amministrazione ancora lo metteva, si trattava in altri termini di un abuso a norma di legge, e gli interlocutori erano ancora i costruttori privati. Dopo, è venuta meno anche l’ipocrisia di mettere le carte a posto, mentre l’imprenditoria privata è sparita, e sono entrate in campo le società e i prestanome del malaffare e della criminalità».
Se l’amministrazione non risponde, il territorio non rimane certo a guardare. Così a Pianura la costruzione della città abusiva si intensifica, come un missile a più stadi: ai settemila vani abusivi realizzati negli anni Sessanta, se ne aggiungono ventimila nel decennio successivo, e altri trentaduemila tra il 1981 e il 1991. Nel frattempo, in trent’anni, la popolazione del quartiere aumenta di quarantamila unità, come effetto di due trasferimenti di massa: quello seguito al bradisismo dei primi anni Settanta, e quello successivo al terremoto del 1980. L’antico borgo rurale che nel 1951 faceva novemila e cinquecento abitanti, ora è una città, completamente abusiva, di cinquantottomila abitanti, il primo quartiere di Napoli per superficie, il quinto per popolazione.
Nel viaggio mi fa da guida Augusto Santojanni, che a Pianura è nato e ha lavorato come medico e come dirigente politico, ora a settant’anni è in pensione. La drammatica trasformazione del casale l’ha vissuta e combattuta per intero, ma non ha smesso di lavorare per il quartiere: il suo giornale, Il corriere di Pianura, è il diario civile del casale, va in edicola ogni mese in mille e cinquecento copie, in redazione collaborano una quindicina di giovani, tra cui Rosa, che ci accompagna.
Percorriamo a piedi la strada vicinale al bordo della città, dove comincia il bosco di castagno, in località Masseria del Monte, le foglie crepitano sotto i piedi; nascosti tra gli alberi sono gli imbocchi delle cave sotterranee di tufo, solenni e misteriose come cripte, con le volte e i pilastri in roccia, da qui è venuto il piperno dei rivestimenti del Maschio Angioino e del Gesù Nuovo.
Ora lo sguardo abbraccia tutta la conca, al fondo c’è una selva infinita di palazzi di sette, otto e nove piani, separati da una scacchiera di strade anguste, col marciapiede che c’è e non c’è, portano i nomi di artisti e filosofi: Botticelli, Dalì, Empedocle, Talete, Socrate. «Quello che vedi, tranne il minuscolo centro storico che s’è salvato, è tutto abusivo», mi dice Augusto indicando col gesto la veduta intera. «All’inizio la criminalità organizzata c’entrava poco, era un’economia locale che partiva dal colono, coi suoi mille metri di terra, e comprendeva il piccolo imprenditore edile, il ruspista per gli sbancamenti, manovali, fabbri, falegnami, e poi certamente i colletti bianchi – progettisti, geometri, notai… Il meccanismo non richiedeva capitali iniziali, la liquidità arrivava alla fine con la vendita delle case, all’agricoltore che aveva conferito la terra restavano un paio d’appartamenti».
Poi il sistema si è evoluto, industrializzato, un meccanismo descritto nei dettagli da Aldo De Chiara nel suo libro fondamentale sull’abusivismo a Napoli. Aldo queste cose le ha affrontate sul campo, da magistrato in prima linea: «L’assenza delle istituzioni nelle attività di governo e controllo del territorio – mi dice – ha dato campo libero a gruppi organizzati che, sostituendosi di fatto allo stato, in un momento in cui il paese cresceva, e l’edilizia legale era di fatto bloccata, hanno fornito abitazioni a fasce sociali meno abbienti. È stato un affare per tutti, per la criminalità organizzata certamente, ma anche per i proprietari borghesi che hanno messo a disposizione la terra per le lottizzazioni; e per il mondo delle professioni, perché qualcuno i calcoli del cemento armato deve pure averli fatti».
La conclusione è che l’abusivismo, che ha rappresentato per un trentennio la base economica del quartiere, è un reato collettivo: parafrasando l’avvocato cocciuto del film Spotlight, si potrebbe dire che «…se serve una comunità per abitare un territorio, serve una comunità per abusarne». Oltre, naturalmente, alle insufficienze e alle connivenze della politica – di tutta la politica – degli apparati legislativi, amministrativi, e anche giudiziari.
Con Augusto ora percorriamo il centinaio di metri pedonalizzati del corso Duca d’Aosta, a Pianura una piazza vera e propria non c’è, questo breve tratto ha un suo decoro, è diventato lo spazio prediletto dei cittadini, anche se un parco pubblico ci sarebbe, un ettaro di verde intitolato ai giudici Falcone e Borsellino, è uno dei bei parchi della Ricostruzione, ma è inaccessibile, chiuso da anni dopo ripetuti vandalismi.
A poche centinaia di metri, in via Grottole, lo scheletro in rovina di un centro polifunzionale mai completato marcisce da anni, gli alberi lo divorano; di fronte, uno spazio pubblico che funziona lo troviamo, è la Casa della cultura e dei giovani, inaugurata nel 2014, l’edificio è bello, riprende nel disegno l’arco catalano delle masserie seicentesche, è un luogo vivo di musica, incontri, laboratori, una risorsa preziosa, in un quartiere-città di sessantamila abitanti dove non c’è il cinema e nemmeno il liceo.
«La Casa della cultura – mi dice Santojanni – è un’eccezione: qui, dopo la Ricostruzione, sono più di venti anni che non succede niente. Nessuna politica pubblica, nessuna economia ha sostituito i redditi che l’edilizia, nel bene e nel male, ha assicurato per quasi un trentennio. C’è una fascia larga di famiglie che vive in una situazione drammatica, per la quale misure di protezione e assistenza come il reddito di inclusione e quello di cittadinanza hanno una loro logica, con tutte le difficoltà che si sono di gestire bene poi questi strumenti, che comunque evidentemente non bastano».
Come ci sarebbe da dare una risposta all’abusivismo, mettere a norma questo quartiere-città, dove lo stato ha scelto ancora una volta di non scegliere, migliaia di domande di sanatoria giacciono in attesa, quelle del primo condono addirittura dal 1985, un’ipocrisia che corrode alla base la credibilità delle istituzioni.
Ora nella grande città abusiva la disillusione regna sovrana, e gli umori cambiano in fretta: alle ultime elezioni europee del 26 maggio, quasi sette elettori su dieci sono rimasti a casa, il tasso di astensione più alto registrato in città. Il riflusso di sfiducia sembra aver colpito duramente anche i vincitori delle politiche 2018, i 5 Stelle, passati dal 60 al 43%, più di ottomila voti persi nel giro di un solo anno, mentre la Lega quadruplica le adesioni, e in percentuale passa dal 2 al 13%. Il Pd guadagna duecentocinquanta voti, non sono molti, ma bastano, grazie al crollo dell’affluenza, a salire dal 9 al 16%, in un gioco ottico all’apparenza confortante.
Torniamo con Augusto e Rosa alla macchina, sotto la grande chiesa di San Giorgio, nel vento umido di questa strana primavera travestita d’autunno. Resta l’idea che Napoli, quando vorrà davvero rimettersi in cammino, è dalle sue periferie che dovrà iniziare, e il compito è immane: dall’est post-industriale, all’ovest post-rurale, bisognerà riabbracciare questi luoghi irrisolti, coi cittadini invisibili che li abitano, rispettarli, pensarli finalmente come una città sola. (antonio di gennaro)



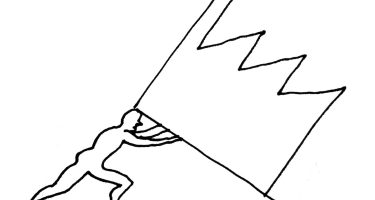

Leave a Reply