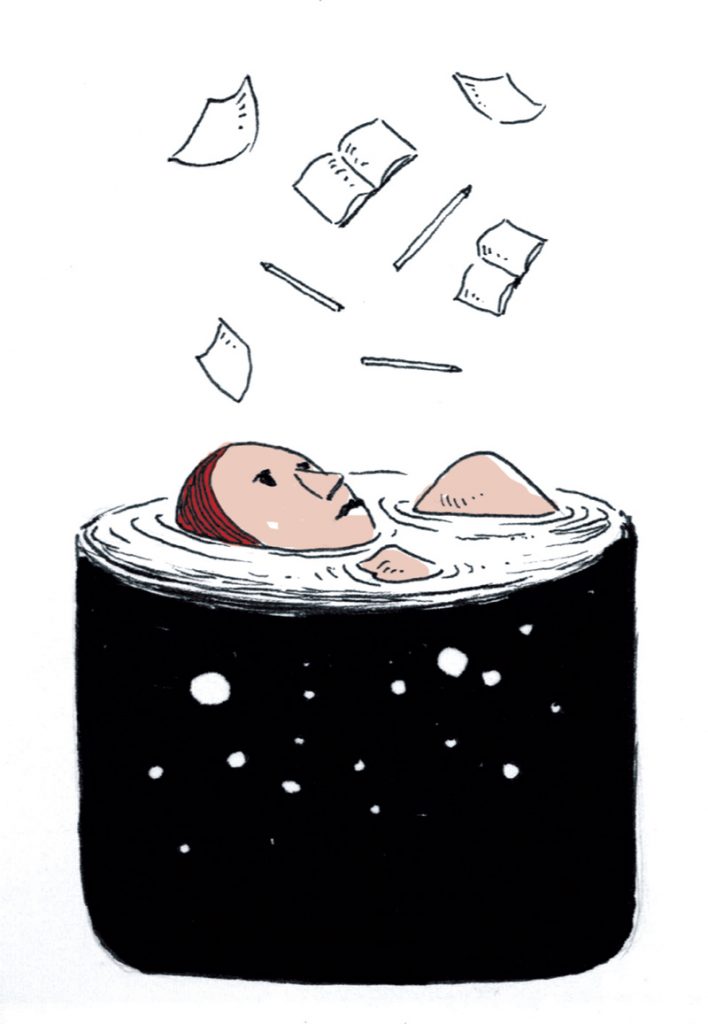
Come tutte le periferie dell’area metropolitana, il Rione Traiano si trova periodicamente sotto i riflettori, quasi sempre in concomitanza con accadimenti di cronaca nera. Per qualche tempo la stampa e l’opinione pubblica si ricordano dell’esistenza di questi enormi ghetti, ne denunciano la massiccia presenza malavitosa, si mostrano indignati per le condizioni di abbandono in cui operano la scuola, le associazioni e tutte le persone che provano a restituire a quei luoghi una dimensione più umana. Ma la denuncia è sempre fine a se stessa, tanto più che la politica se ne infischia, salvo qualche dichiarazione d’intenti tanto vaga quanto estemporanea. Il quartiere e i suoi problemi passano di moda nel tempo necessario a chiudere la pagina di un giornale, come se quelle vite trovassero senso solo all’interno del racconto predeterminato che del quartiere si intende fare.
Qui raccontiamo le storie di alcuni abitanti del Rione Traiano. Persone che lavorano o sono disoccupate, studiano o cercano un posto dove andare a dormire, insegnano oppure organizzano associazioni. Senza pretesa di dividere i buoni dai cattivi, ma cercando di far emergere le esistenze quotidiane di chi il rione lo abita, con tutte le infinite sfumature che si trovano nello spazio che esiste tra il bianco e il nero.
Federica Montieri, operatrice Associazione Davide Bifolco
La mia famiglia non è originaria del Rione ma i miei nonni hanno vissuto per un periodo a Soccavo; così, quando si sono trasferiti da un’altra parte, noi abbiamo preso casa loro. Mia madre è nata ai Quartieri Spagnoli e quando ha sposato mio padre sono andati a Salita Arenella. Sono stati lì fin quando non è arrivato il terzo figlio, poi sono arrivata io. Mia madre fa la logopedista, mio padre l’impiegato di banca, ma entrambi provengono da famiglie popolari. Io e mio fratello Delio invece siamo cresciuti confrontandoci con una popolazione di estrazione sociale un po’ diversa da quella in cui avevamo cominciato a crescere. Personalmente una sorta di diversità la avvertivo, ma la cosa non mi è mai pesata. La notavo, da bambina, inconsapevolmente, frequentando le case dei miei amici nella zona di Verdolino, a Soccavo vecchia, una zona di campagna fino a qualche anno fa, dove ci sono queste palazzine, per la maggior parte abusive, in cui vivono intere famiglie tutte assieme, una situazione molto diversa dalla mia casa a via Epomeo. Mia mamma ha fatto un gran lavoro in questo senso, ha costruito un rapporto paritario con le signore del rione, che in un primo momento avevano una certa soggezione… qui per rimarcare una differenza sociale chiamano tutti “dottoressa”, una parola che già segna uno scatto. Lei però ha nascita in un quartiere popolare e per lavoro si interfacciava con un’utenza molto varia, lavorando al Don Orione ai Banchi Nuovi. E quindi questa sua capacità di interagire con tutti mi ha aiutato molto.
Alle scuole medie sono andata alla Bracco, che è la scuola “meno peggio” a Soccavo, ma dove comunque impera la logica delle classi-ghetto, in base alla provenienza dei ragazzi. Le classi per i buoni, quelle per i “malamente”, e poi due classi “miste”, in una delle quali finii io. Lì cominciai a prendere contatto con il modo di vivere e le dinamiche del quartiere, ne succedevano un po’ di tutti i colori, a cominciare dallo strascino tra ragazzine per questioni d’amore, che è stato un motivo ricorrente in quei tre anni. Certo venivo vista come quella “diversa”: svolgevo una vita differente, avevo un approccio alle cose un po’ bambinesco, mentre la gran parte dei miei compagni svolgeva una vita già da adulto, non giocavano più, qualcuno fumava la sigaretta, facevano discorsi che erano “più avanti”. Al liceo invece sono andata al Vomero, dove ho cominciato a fare attività politica, prima seguendo mio fratello che era molto preso dalla battaglia sull’acqua pubblica e poi con un comitato territoriale che stava formando con alcuni amici, vicino casa, che poi è diventato il Comitato Soccavo. In una prima fase lavoravamo sulla riqualifica delle aree verdi abbandonate, degli spazi pubblici del quartiere, con gente senza particolari esperienze militanti precedenti. A via Giustiniano, a via Piave, dove siamo riusciti a dare un input per alcune associazioni che oggi si prendono cura di quegli spazi. Per me è stato il modo per conoscere le persone che stavano sul mio territorio e passare del tempo con loro nel mio quartiere, che non è una cosa scontata, perché comunque prima di allora frequentavo soprattutto il centro storico. E lo stesso vale per il Rione Traiano, di cui avevo conosciuto solo il parco quando ero piccolina, pur tenendolo azzeccato a casa, anche perché poi non è che uno dice: «Beh, andiamoci a fare una passeggiata al Rione». Così ci siamo trovati a fare la battaglia per il Polifunzionale, questo enorme centro di cinquantamila metri quadri, nel cuore del quartiere, ma di cui la gente del Rione sa pochissimo e soprattutto lo usa pochissimo. Lo occupammo nel 2010, denunciando l’assurdità di un posto enorme e vuoto, in cui non c’era niente se non i call center gestiti dall’università e qualche palestra in concessione ai privati. Nella stessa giornata venne la polizia e ce ne fece andare. La battaglia è continuata, con alti e bassi, finché il comune ha deciso di utilizzare alcuni soldi che erano vincolati per la ristrutturazione di questo tipo di strutture per la creazione di un centro giovanile. Abbiamo lavorato con l’assessorato per dar vita a una assemblea che organizzasse le attività, cosa che per noi era buona perché ci consentiva di stabilire una connessione con gli abitanti del territorio. Ma di fatto il comune non si è perso carico nemmeno di una campagna che pubblicizzasse l’apertura, lasciando il peso dell’assemblea sulle nostre spalle, che dovevamo coordinare tanto quelli che avevano voglia di fare cose lì dentro, quanto quelli che, trovandoci sotto campagna elettorale, venivano lì a fare proposte irricevibili.
Prima del Polifunzionale c’era stata l’esperienza del Parco Don Gallo, un piccolo parco che si trova all’ingresso del Rione. Un’area che era di fatto abbandonata ma che il comune ha sempre considerato aperta, con i giardinieri che sarebbero dovuti andare a pulire con regolarità e invece non si vedevano da anni. Col tempo sono venute fuori una serie di cose, abbiamo scoperto l’esistenza di un piccolo deposito sotterraneo che la gente chiamava “il bunker”, dentro il quale per anni ci avevano fatto di tutto: chi dice storie di prostituzione, chi dice che ci mettevano dentro droga o armi, o che ci andava un latitante a nascondersi. La nostra idea era quella di ricreare un luogo in cui la gente potesse incontrarsi, considerando che viviamo in un quartiere vastissimo in cui c’è una sola piazza. In queste situazioni inevitabilmente vai incontro a qualche conflitto, per esempio tra le persone di una certa età che avevano ricominciato a frequentare il parco e i ragazzini che volevano a loro volta stare lì dentro, mentre per i più anziani quella doveva essere una zona protetta e quindi li cacciavano con modalità aggressive innescando una serie di reazioni a catena in quello stesso senso.
Dopo la morte di Davide Bifolco mi sono approcciata ulteriormente al Rione. La cosa ci è scoppiata in faccia, abbiamo avuto bisogno di capire bene per metabolizzare. In quei giorni tornavo a casa dall’università e mi mettevo a leggere gli articoli, cercavo di capire cosa stesse succedendo, perché i giornali facevano molta confusione, parlavano di latitanti, criminali, armi. Ovviamente la mia reazione era per il fatto che avessero ucciso un ragazzino di sedici anni, e quindi senza nemmeno sapere bene come e perché ho cominciato ad andare lì, a frequentare l’aiuola dove Davide era stato ucciso e ho creato un rapporto “personale” con il Rione. Nel frattempo la gente, anche gli attivisti dei movimenti, che intanto avevo conosciuto per l’esperienza del Don Gallo, cominciavano a chiamarmi per capire cosa stesse succedendo e a venire anche, considerandomi un referente, quantomeno da un punto di vista geografico. Come Comitato ci è venuto naturale metterci in contatto con la famiglia di Davide, per fargli sentire la nostra vicinanza, stringendo dei legami che poi sono diventati forti. Io un po’ per carattere, un po’ per altro, già in quella fase preferivo rapportarmi con i ragazzini. Loro stavano tutto il giorno seduti o comunque in gruppetto al punto dove gli avevano sparato, io cercavo di parlarci, provando ad andare oltre la vicenda, a farmi raccontare chi erano, cosa facevano. Loro percepivano quest’interesse, soprattutto dopo i primi momenti in cui mi scambiavano per una giornalista, ma comunque è stata una cosa che ha avuto bisogno di tempo. Intanto ho conosciuto Emilia, la zia di Davide, e poi il resto della famiglia, finché abbiamo cominciato a pensare di far nascere un’associazione che portasse il suo nome. In un primo momento i ragazzi del Rione partecipavano, organizzavano cortei di protesta nel quartiere, collaboravano alle iniziative, poi abbiamo visto il loro coinvolgimento scemare un po’, in una dinamica abbastanza naturale, e così abbiamo deciso che dovevamo essere noi ad andare incontro a loro, in particolare a quelli più piccolini, quelli in età di scuola. Solo che non avevamo un luogo fisico dove incontrarci, mentre sentivamo l’esigenza di stare nel cuore del Rione. Così abbiamo deciso di occupare la ex scuola Copernico, e far partire lì una serie di attività per i bambini, partendo dai doposcuola e puntando poi a coinvolgere anche gli adolescenti, che sono quelli che in un quartiere come il Rione vivono la situazione più problematica. L’occupazione è stata simbolica, per spingere il comune ad assegnarci la scuola, ma di fatto abbiamo avuto solo un riconoscimento temporaneo, che ancora oggi ci lascia sospesi, nonostante ormai lavoriamo con decine di famiglie del quartiere quotidianamente. Esisteva un bando, che stabiliva che in questa scuola si doveva fare una specie di centro servizi sanitario, ma nel quale il comune si faceva garante del fatto che una serie di spazi, come le aule e la palestra, avrebbero dovuto continuare a essere usate dall’Associazione. Di scritto però, di queste cose, non è venuta fuori nessuna traccia e rimaniamo in questa situazione di impasse.
Il nucleo di partenza degli operatori è stato quello dei ragazzi che gravitavano attorno al Comitato, assieme ad alcuni attivisti di Bagnoli. Poi hanno cominciato a presentarsi altri volontari, quasi sempre slegati dal mondo dell’attivismo politico. Gente che ha saputo delle attività che stavamo facendo, che era legata al territorio perché aveva vissuto qui, perché ci era cresciuta, magari ci abitavano i nonni e sentiva l’esigenza di dare una mano, di dare un contributo per stare vicino a questi bambini che intanto diventavano sempre di più e frequentavano le attività con più costanza. In questa cosa ci siamo buttati con un po’ di incoscienza, non avevamo un’idea chiarissima delle metodologie, della didattica, a parte ciò che alcuni di noi stavano studiando all’università. Col tempo abbiamo costruito un rapporto con il Mammut di Scampia, in particolar modo con una delle fondatrici, che è originaria di questa zona, e loro hanno ci hanno aiutato a capire e a intervenire sulle difficoltà che avevamo, per esempio a livello di approccio con alcuni bambini che vivono situazioni molto particolari. Da un punto di vista pedagogico c’è stata una crescita, proporzionata anche alla conoscenza che chiaramente diventa più profonda con i ragazzini, così come c’è stata da un punto di vista della strutturazione degli ambienti in cui i ragazzi passano i pomeriggi, e su molte cose le differenze si vedono. Da qualche tempo proviamo a lavorare sui processi di confronto tra noi, con una sorta di “autoformazione”: sulle modalità da utilizzare con i bambini, la necessità o meno di parlare il dialetto, l’alzare la voce, il fatto che alcuni di noi abbiano un approccio più fisico rispetto ad altri nel contenere i ragazzini meno controllabili, oppure le modalità con cui va utilizzata la palestra e quindi l’attività motoria, che non diventi solo uno sfogatoio… Insomma il processo di crescita magari non è velocissimo ma è parallelo, quella dei bambini, delle famiglie e quella nostra personale come gruppo di operatori. Lo notiamo per esempio nella gestione di momenti come le uscite fuori del quartiere. Si tratta naturalmente di bambini – ma anche dei loro genitori, per la maggior parte giovani – che hanno sempre e solo visto i palazzi del loro circondario, e quindi andarsene in giro per la città, tutti insieme, a vedere qualcosa di nuovo, oppure una strada famosa del centro che l’ultima volta hanno visto vent’anni fa, è un viaggio nello spazio ma per i più grandi anche nel tempo.


Leave a Reply