
Dal n.55 (settembre/ottobre 2013) di Napoli Monitor
#1 Napoli, 23 settembre 2018 – Lungomare, stazione zoologica Anthon Dohrn
La gru carroponte semovente si mosse di pochi metri verso la battigia. Dalle due benne pendeva l’ultima delle vasche a tenuta stagna in cui battevano l’ombrello e agitavano i filamenti alcuni rari esemplari di Olindias phosphorica, una specie di idromedusa diffusa nel mediterraneo occidentale. Cinque Tir per trasporto speciale erano incolonnati sulla strada acciottolata che separava la rena della spiaggia pubblica dai prati della Villa a Mare. Il primo della fila si mosse in direzione della gru, due operai aiutarono la discesa della vasca e la fissarono sul cassone con le catene di acciaio elastico. Il Tir partì scortato da un paio di mezzi dei vigili del fuoco, diretto verso il nuovo parco marino di Bagnoli. Il fumo di scarico del mezzo pesante irritò alcune famiglie adagiate sulla sabbia e protette dagli ombrelloni del lido Partenope, lo stabilimento pubblico di manutenzione della spiaggia e accoglienza dei bagnanti.
Dalla stazione zoologica uscirono altre quattro vasche. Bavose, guarracini, cernie e cavallucci di mare osservavano la vita di terra, affatto stupiti del movimento. Avevano iniziato a viaggiare, per tutta la città, nel 2013, verso la fine dell’estate quando il programma “Risorsa Mare” legato al Forum Universale delle Culture aveva avviato un progetto quinquennale di divulgazione scientifica delle specie ittiche del Mediterraneo. Si trattava della costruzione di percorsi espositivi guidati tra mare e terra che utilizzavano le competenze dell’acquario cittadino e dei pescatori del golfo nella costruzione di una mostra permanente (al principio itinerante) sulla biodiversità marina.
Bandi di selezione pubblica avevano richiamato in città esperti, divulgatori, scrittori, operatori marini, pescatori e cineoperatori di nazionalità diverse che, per un anno, avevano dato vita a un racconto articolato del mare, della sua vita, della sua fauna, flora e dei mestieri che ospitava. Oltre al finanziamento pubblico il progetto attirò interesse (e conseguenti donazioni) di grandi armatori, istituti di ricerca, multinazionali… Una mole di denaro che, usato sapientemente e con criteri rigidi e trasparenti, dopo cinque anni aveva reso possibile la nascita di un complesso sistema di indagine e divulgazione dell’ambiente marino, una sorta di mostra (stavolta permanente) della risorsa mare. La ricaduta occupazionale fu notevole, per la prima volta un Grande Evento era stato utilizzato per costruire una struttura territoriale capace di autoalimentarsi e autoperpetuarsi con effetti sul tessuto urbano e sociale della città.
#2 Panorama della città futuribile, Napoli 2018
Dal litorale di San Giovanni a Teduccio (da cui distava poche centinaia di metri il banco sottomarino di Santacroce, l’unico Reef corallino presente nel Mediterraneo) fino a Bagnoli, passando per la costa antropizzata del porto commerciale e il lungomare tradizionale, l’impulso della “Risorsa Mare” aveva ridisegnato e ridefinito la forma e l’uso della linea costiera metropolitana attraverso una sinergia (fino a quel momento sconosciuta in città) tra interventi urbanistici e azioni culturali e sociali.
La spiaggia nera di San Giovanni era stata bonificata e dotata di moderni depuratori. Alla Vigliena, al posto del previsto porto turistico per barche di diporto di dubbia provenienza, erano sorti due moli da cui partivano le barche di osservazione sottomarina; la centrale termoelettrica era diventata un polo di ricerca e museale dedicato alla storia dell’elettrificazione nazionale e della produzione di energia pulita (eolico, sfruttamento delle maree, movimenti delle placche tettoniche). All’imbocco del porto (ampliato e dragato per ricevere le navi intercontinentali portacontainer) erano state costruite vasche di coltura delle spugne marine che svolgevano una funzione biologica di depurazione dell’acqua marina, il primo esempio (in seguito esportato nei porti di tutto il mondo) di depurazione naturale degli inevitabili scarichi inquinati di uno scalo commerciale.
Il porto stesso era diventato parte della città: oltre agli imbarchi della navigazione del golfo e verso la Sicilia, ora ospitava un museo/centro di ricerca internazionale dedicato al fenomeno dell’immigrazione. Nei pressi del molo dell’Immacolatella era sorto il museo dedicato ai mestieri del mare. Le crociere, dealer di turismo mordi e fuggi, erano state spostate nel porto di Salerno per lasciare spazio, nella zona del Beverello, ai circoli nautici per la divulgazione popolare della navigazione a vela; nei due chilometri e più di lunghezza del molo San Vincenzo, alcuni tecnici, elettricisti e scenografi avventurosi avevano costruito il primo Teatro a Mare d’Europa (che ospitava il Festival Internazionale del Teatro Mediterraneo capace di soppiantare, in pochi anni, i principali festival di settore europei).
Il lungomare, liberato dall’asfalto, era diviso in una zona per i grandi alberghi (da Santa Lucia alla Colonna Spezzata) per poi diventare una vasta spiaggia separata dalla ex-Villa Comunale (liberata da cancelli e rinominata Villa del Mare) da una sottile linea di basoli vesuviani.
La collina di Posillipo, una volta aggredita con decisione la privatizzazione delle discese a mare, era diventata un bioparco metropolitano. Dalla discesa di Coroglio fino all’ex insediamento operaio di Bagnoli, si era fatta spazio una distesa di alberi di nuovo impianto, al cui interno, sui suoli della ex-acciaieria, era sorto un Museo della Scienza e della Tecnica; sulla linea costiera, oltre a qualche centinaio di metri di spiaggia costruita con sabbia desertica e incontaminata, dopo la bonifica radicale seguita agli scandali del carrozzone della società pubblica Bagnoli Futura, sorgeva il nuovo Centro di Ricerca Biomarina che aveva sede nell’Acquario le cui strutture si dipanavano tra il pontile Sud e Nord e l’isola di Nisida (da cui erano stati spostati il carcere minorile e il comando della sesta flotta USA).
I Tir in viaggio dal lungomare arrivarono su via Coroglio dopo mezz’ora passando per il tunnel sotterraneo che da Mergellina sbucava a Cavalleggeri Aosta. Dopo un breve tratto di strada in superficie trovarono un’equipe di ricercatori e tecnici multirazziale pronta a sistemare l’ultima ala dell’Acquario dedicata alle specie tipiche dei bassi fondali.
#Allegato. Napoli. Gennaio 2014. Protocollo 71. Oggetto: Forum Universale delle Culture
Preso atto della sopravvenuta incapacità organizzativa, nonché delle evidenti lacune amministrative, l’amministrazione comunale di Napoli affida l’organizzazione e la gestione del Grande Evento (cd) Forum Universale delle Culture, alla Fundaciò Forum Catalana, demandando e trasferendo i poteri decisionali (in merito a Selezione ed Emissione dei Bandi e dei Progetti) ai suoi (della Fundaciò) organi decisionali ed attuativi. Trasferisce, inoltre, l’utilizzo dei fondi stanziati per il G.E. a disposizione della Commissione Commissariale dell’Unione Europea (CCUE) delegandone (e affidandosi) alle professionalità in essa coinvolte. Delega, inoltre, i progetti di trasformazione urbana ai due enti citati invitando i suddetti al coinvolgimento delle migliori forze attive nell’Area Metropolitana (istituita con DPR del 01.01. 2014). Forze da individuare attraverso pratiche di reclutamento che rispondano ai requisiti di legge. (SIC.)
#3 Pietrarsa 2018. Confine tra i comuni di Napoli e Portici
Il sound che aleggiava sulla rotonda affacciata sul mare del Museo Ferroviario di Pietrarsa/Portici, era denso, carico di bassi. La consolle, irta di cavi e luci intermittenti, si intuiva dall’interno di un vagone del rapido panoramico S345 in servizio tra Napoli e Trieste tra il 1965 e il 1980. Il restauro di un intero convoglio ferroviario, abbandonato in una stazione di servizio periferica del centro Italia, era iniziato nel maggio del 2013, come parte del progetto finanziato dal programma “Lavoro” del Forum Universale delle Culture.
Le maestranze provenivano da ranghi di pensionati delle Ferrovie dello Stato coadiuvate da apprendisti coinvolti in un percorso di formazione professionale legato al circuito delle biblioteche/università del territorio, costituito dall’amministrazione comunale del tempo e finanziato da risorse della UE. Giovani uomini e donne avevano imparato tecniche per il restauro delle meccaniche e carrozzerie d’epoca, e, invece di riportare in vita ciclomotori o vespe destinati ad alimentare il mercato delle assicurazioni civili d’epoca, furono chiamati a restituire i fasti a vetture ferroviarie costruite per rispondere alle esigenze del lusso miserabile della società dei consumi (una sorta di modernariato dalle dimensioni estese). Treni costruiti ispirandosi al binomio Velocità&Comodità, ormai superati dalle esigenze TAV e dall’affermazione della velocità sulla comodità.
Ora il vagone era immobile, ancorato ai binari della piattaforma girevole dell’ex-deposito diventato museo. Tutt’intorno, persone disparate si servivano robusti drink serviti ai banconi dei due bar ospitati in altrettanti vagoni ristorante provenienti da epoche diverse. Più in fondo, verso i capannoni dell’esposizione, il treno del re Borbone (il primo a far costruire la ferrovia in Italia da una ditta inglese) era un ristorante slowfood dal menù farcito di piatti a base di pietanze rigorosamente a chilometro zero. Il chiacchiericcio mescolava italiano, dialetto, inglese, francese, tedesco, russo. Gruppi ristretti dialogavano in spagnolo sudamericano, pharsi, arabo. Il cinese imperava nel capannone destinato ai gadget. All’area dedicata ai plastici ferroviari fu infatti aggiunta una dependance per la vendita di gadget: treni in tutte le dimensioni, a trazione, a pile, a energia solare. Berretti, magliette e borse di tela con le insegne delle ferrovie di mezzo mondo. Una sala proiezione dedicata al racconto dell’industria ferroviaria e più in generale dei trasporti, in pochi anni diventò il centro del Festival Internazionale del Movimento. Cinema, teatro, danza, musica, letteratura e altre piste narrative trovavano ospitalità, nel mese di giugno di ogni anno, negli spazi del museo.
Nel lontano 2013, infatti, il museo di Pietrarsa, grazie all’intuizione di un oscuro funzionario comunale impiegato nella gestione dell’evento Forum Universale 2013, diventò, in pochi mesi, una delle attrazioni dell’area metropolitana partenopea. Era bastato un attimo: cambio degli orari d’apertura, riorganizzazione e ottimizzazione dei percorsi di visita, commercializzazione del modellismo ferroviario (anche attraverso la costruzione di uno spazio dedicato esclusivamente alla simulazione di percorsi ferroviari in miniatura), apertura del belvedere sul mare ad attività ricreative commerciali e non. Dal 2013 al 2015 le visite aumentarono in maniera esponenziale costringendo scolaresche e singoli visitatori da tutt’Italia a incrementare liste d’attesa rigorosamente organizzate. D’altra parte, a quei tempi, la svolta fu proprio questa: usare dei soldi piovuti dal cielo (per un evento che nessuno fin dal principio avrebbe saputo usare vista l’insipienza della classe dirigente dell’epoca) per avviare dei progetti sostenibili nel tempo e con una forte ricaduta territoriale, proiettati verso l’acquisizione delle attività avviate da parte di soggetti cooperativi o privati capaci di internazionalizzare l’ancora provinciale settore della produzione immateriale, di costruire sinergie tra la tecnica e la sua divulgazione. Occupare professionisti della sovrastruttura per mantenere in vita il calore di una struttura che scompariva.
Il suono di quella sera settembrina era carico di eco provenienti da convogli ferroviari estinti: stridii, rimbombi, fluttuazioni, respiri ansimanti. Sembrava quasi di sentirlo quell’odore scomparso dai treni, quei convogli che attraversavano l’Italia di notte, sostituiti da proiettili mascherati da treno.
#4 Napoli 2020. Litoranea
Il tram era in ritardo. Vera lavorava a Bagnoli e viveva a San Giovanni, dall’altro capo della città. Per arrivare alla sua postazione dotata di computer, wifi, schedari (sita nell’Acquario internazionale di Bagnoli) impiegava quindici minuti di tram.
Il tram era in ritardo di tre minuti. Alcuni piccioni erano rimasti schiacciati e incastrati tra la rotaia e il mezzo. Alfredo, il conducente, picchiettò due tasti per comunicare ai pannelli delle fermate la durata dell’inconveniente.
Il tram era un altro risultato del programma “Lavoro” del Forum Universale 2013. Sei mesi di incontri internazionali sulla salvaguardia e sostenibilità del territorio, indirizzati attraverso seminari specifici sulla zona partenopea che avevano incredibilmente attratto persone da tutto il mondo con proposte e progetti per migliorare l’organizzazione urbana del caos napoletano. Fu un esperimento, una scommessa dettata dall’incapacità della classe dirigente di prendere decisioni assennate, di prospettiva, scelte che dovevano rispondere a domande del futuro e non a necessità del presente. Finanziamento di residenze di operatori e specialisti, programma semestrale di gruppi di lavoro, interdisciplinarietà, coordinamento con centri di ricerca delle università europee e statunitensi. In un attimo il chiacchiericcio che animava il centro storico, Bagnoli, San Giovanni fino all’arcigna collina Vomerese si andò internazionalizzando.
La città cambiò pelle. Le gallerie della linea metropolitana numero 6 furono riconvertite a passeggiate nel sottosuolo napoletano che conducevano fino al fondale del golfo. Una miniera senza materia prima, o meglio, con materia prima immateriale. Dalle caverne di Chiaia si sbucava in un sistema di camere stagne e di decompressione che portavano direttamente al fondale marino prospiciente alla città. Per assicurare la mobilità veloce tra oriente e occidente della metropoli, era bastata una doppia corsia protetta – i binari non correvano nell’asfalto ma separati da semplici ciottoli acuminati – per i tram. Erano treni di superficie a basso impatto energetico e puntuali. Affiancata al cunicolo di grotte correva l’autolinea sotterranea che collegava la zona di Chiaia a quella di Fuorigrotta.
La città antica era stata svuotata dalle auto grazie all’intervento di “decoro urbano”, finanziato dal Forum, per il centro storico. Piazza Mercato (liberata dallo sgorbio di palazzo Ottieri) era diventata l’epicentro di un nucleo antico non più circoscritto dai legacci dei decumani, il quartiere si era espanso: il sottoproletariato urbano devastato dal consumismo e restio a trasformazioni si era contaminato con una classe media impoverita ma di alto profilo, squattrinata e per questo incline all’azzardo. Il centro cittadino aveva dismesso i bar patinati dallo stile mobilificio controllati dalla malavita, i teatrini d’avanguardia costruiti sul narcisismo di autori e attori mediocri ma garantiti, le estorsioni e tutte le attività illegali improduttive (in parte grazie a una sagace legalizzazione delle sostanze da intrattenimento). Tutta quella zona viveva un momento di splendore dovuto allo sviluppo dell’industria dell’intrattenimento che occupava il rivolo di vicoli pacificati che accompagnavano la città fino al mare.
Gadget, souvenir, boutique, vintage, gallerie d’arte, bassi diventati studi professionali, parrucchieri di grido diventati proprietari di intere stradine, coolness, sale incontro, sale conferenze, ludoteche, orti urbani, spazi ricreativi. Manovalanza e pensiero. In un attimo le palanche avevano internazionalizzato il chiacchiericcio.
#Allegato. Napoli 2015. Dal diario (dattiloscritto) di Ines Sotomayor
Quanto tempo è passato, un paio d’anni? Il Forum, per me, era soltanto una porta d’ingresso per l’Europa. Un modo per avere il visto e andare al nord. Che so? Spagna, Francia?
L’incredibile, per me sudamericana, fu che mandando todas las cartas per l’application form del Forum, ebbi una risposta immediata e mi fu pagato perfino il viaggio per sostenere i colloqui di selezione. Rimasi due settimane a Napoli, incontrai due commissioni di valutazione e fui accompagnata in un giro esplorativo dei luoghi e dei progetti in corso. Al final de las cuentas mi presero, e venni inquadrata nel progetto “Risorsa Mare”.
Io sono biologa marina, e mi piace la musica, il teatro, il cinema, i libri, ma sono una, come si dice? fruitrice? Ecco! All’inizio ci diedero degli spazi in una struttura enorme del centro storico, un ex-Asilo o una cosa simile. Era gestito da una sorta di comunità. Non l’ho mai capita fino in fondo. Poi ci spostarono a Bagnoli nell’Acquario. In ogni caso, quel periodo passato in quel posto, nonostante tutto, mi ha insegnato a intersecare il mio linguaggio (il mio presente fatto di esemplari marini, di fondali e cose così) con tecniche e sensibilità capaci di tradurlo e raccontarlo a chiunque (ho incontrato il presente di altri e il futuro che continuo a vivere). Era un continuo incontrarsi, forse è per questo che quell’esperienza riesce a sopravvivere? Durante il Forum non c’erano regole formali, era uno spazio completamente ridisegnato dall’informalità, così abbiamo fatto i soldi. Così sono diventata anche io napoletana. E poi la spiaggia… dove c’è in Europa un’altra spiaggia così in città?
#5 Napoli, settembre 2016. Un Altrove Ulteriore
Copertoni di gomma bruciano. Un pennacchio nero deturpa il paesaggio metropolitano. Poi un altro, un altro ancora. In città si appiccano roghi di gomma, si incendiano automobili di vetroresina a trazione elettrica che hanno sostituito i risciò a pedali sul lungomare. Gli stand di Bulgari e altri gioiellieri vengono smontati in fretta, la folla avvinghia tutto quello che trova, si lancia sugli oggetti di valore. Svaligiano le casse continue delle banche montate in occasione delle regate della coppa non-si-sa-cosa di Vela. L’ennesimo giocattolo dei ricchi a cui si è svenduta la città.
Negli alberghi del lungomare si servono drink, nei bar del centro antico si servono drink con alcol adulterato. I vicoli pullulano di crocieristi, botteghe smerciano merchandising: cineserie a forma di pastori, corni di corallo e pizza margherita. Il fumo nero raggiunge il piccolo gruppo di notabili assiepati all’entrata del Teatro San Carlo. Tosse, sdegno e biglietti omaggio per la prima del Forum Universale delle Culture (2013) che scivolano veloci nelle mani delle maschere che aspettano banconote. Ci sono voluti tre anni di ritardo e un programma striminzito infarcito di banalità, per far intascare ai professionisti dei grandi eventi i residui di un finanziamento spropositato e ingestibile. Stavolta qualcosa è andato storto. Il Grande Evento si è trasformato in un’insurrezione inattesa, animata da configurazioni individuali (uomini e donne) e collettive (gruppi). La folla chiede incendi, tabula rasa, la folla si è già riappropriata della città! Una folla amorfa, logica conseguenza di una disgregazione culturale, sociale, economica. Una folla che non si affida più, che distrugge perché ha capito che solo dal caos saprà ricostruire.
In una notte di settembre, grazie al Forum Universale delle Culture (2013), l’Occidente ha visto la propria storia indirizzarsi verso contrade a venire. Dalla periferia è partita la sovversione confusa del centro. A ciascuno il suo.
#6 Napoli. Settembre/Ottobre 2013. Considerazioni a margine
Non avremmo voluto l’ennesimo teatrino di corte: re e vicerè amministrativi che provano a saccheggiare fondi pubblici per assicurare “salari” a un consanguineo “lavoratore” (ma quanti lavoratori vivono sulla faccia della terra?) o stipendiare l’ennesimo “consulente”, direttore (artistico o amministrativo) selezionato in base a criteri non clientelari (per esercitare clientela ci vuole – quanto meno – un talento) ma goffi, disarticolati, sin verguenza.
Non avremmo voluto che l’aggettivo proletario venisse stuprato e affiancato a un Grande Evento già corrotto e, in ogni caso, fin dal principio ideato come sagra di paese (con tutto il rispetto per le sagre), maschera di un meccanismo farraginoso di distribuzione di posti di lavoro (precari) e finanziamenti per eventi, non effimeri, ma del tutto senza basi. Non avremmo voluto assistere a una ridicola recita condita di attori incapaci di recitare il proprio ruolo. Eppure…
In altri momenti abbiamo chiamato il Forum Universale delle Culture/Napoli 2013, un “fantasma amministrativo”, creatura dell’insipiente gestione dell’amministrazione Iervolino/Oddati. Oggi il Forum è un vero e proprio “sgorbio amministrativo”, un qualcosa che certificherà l’insipienza della classe dirigente passata e futura. Un amo (una tentazione) utile a pescare pesci piccoli strozzati dalla crisi (culturale e poi economica) oppure vecchi squali privi di pensione garantita. I processi di trasformazione urbanistici, sociali, culturali, economici che, chi scrive, ha immaginato, non rientrano nelle nostre grazie. Noi agiamo in micro-territori, proviamo a costruire privilegiando la continuità delle esperienze, tentiamo di sovvertire il presente evitando lo spettacolo e le alzate di testa. E perciò, avremmo gradito poter immaginare il Forum Universale delle Culture 2013 come un’occasione di trasformazione urbana programmata e articolata su necessità (e urgenze) di prospettiva. Uno strumento di sviluppo e non una pantomima. Un grimaldello per avviare un cambiamento radicale nella gestione delle politiche urbane e culturali della città. Forse, in verità, non ci abbiamo mai creduto, perché disillusi, perché già proprietari di lenti che denudavano il re (qualunque esso sia). “Gente come noi” non ha mai voluto regnare né limitarsi ad aspettare come sudditi fedeli. “Gente come noi” si affida alla fantascienza, quel rigagnolo narrativo che offre, a chi scrive, orizzonti sconfinati. Mettere in pratica quello che vediamo laggiù, non è un pranzo di gala. (-ma)



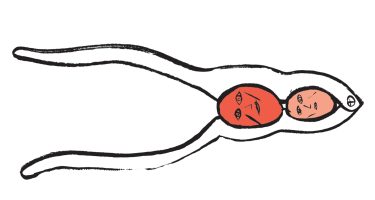
Leave a Reply