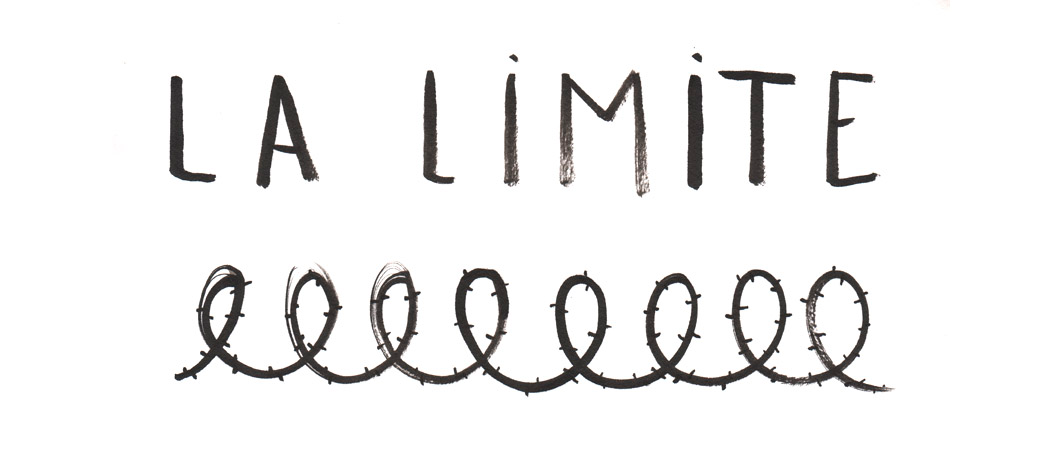
Dopo otto mesi dalla chiusura del centro di identificazione ed espulsione di Santa Maria Capua Vetere, il Tribunale di Caserta ha iniziato a emanare le prime sentenze di riconoscimento di protezione umanitaria, inizialmente negata a tutti i migranti che erano stati trattenuti in quella struttura. A quasi un anno di distanza, gli avvocati dei trattenuti ricompongono i frammenti di una storia fatta di detenzione, violenza e violazioni dei diritti umani.
Sono arrivati a Napoli il 18 aprile 2011, dopo un breve soggiorno a Lampedusa e sette giorni trascorsi nella stiva di un traghetto. È iniziata così la vicenda dei duecentocinquanta giovani tunisini che a primavera scorsa, nelle settimane successive alla cacciata del dittatore Ben Alì, sono partiti alla volta dell’Italia. In quei giorni concitati, i migranti arrivati a Lampedusa venivano smistati nelle diverse strutture di accoglienza presenti sul territorio italiano. A loro è toccato in sorte il centro di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, una tendopoli approntata in fretta e furia nel cortile della ex – caserma Andolfato. Le cose sono iniziate ad andare male sin dal principio: prima di entrare nel centro, avevano trascorso una settimana in una nave, dormendo su delle sedie, mangiando una volta al giorno, senza potersi lavare e soprattutto senza sapere quando e dove sarebbero sbarcati. Finalmente il 18 aprile il traghetto ha attraccato al porto di Napoli. «Quel giorno il centro di identificazione e di espulsione di Santa Maria Capua Vetere ancora non era pronto», ricorda Ileana Accetta, uno dei quattro avvocati che ha assistito i migranti. «Il CIE infatti è stato istituito soltanto il 21 aprile, con un’ordinanza della presidenza del consiglio dei ministri». Ma questi sono dettagli. Dal 18 al 21 aprile, i duecentocinquanta ragazzi sono stati ugualmente trattenuti all’interno della caserma, senza la possibilità di uscire. Un sequestro di persona vero e proprio, iniziato dieci giorni prima, sul traghetto che ha navigato per una settimana senza meta.
Quando le porte della caserma si sono chiuse ai ragazzi è stato fatto firmare un foglio, gli è stato spiegato che serviva per la consegna del materiale per l’igiene personale, ma in realtà autorizzava la permanenza all’interno del centro. In quelle ore l’accesso alla caserma è stato negato alle associazioni per i diritti umani e ai legali, che sono riuscite a entrare solo dopo quattro giorni, il 21 aprile, a seguito di pressioni e richieste. Dopo poche settimane le autorizzazioni a entrare sono state revocate anche agli attivisti e da allora sino alla chiusura della caserma gli unici ad averne accesso sono stati i quattro legali.
La parte in muratura della caserma Andolfato era ed è ancora oggi inagibile, i ragazzi perciò sono stati sistemati dalla Croce rossa nel cortile. Sono state montate le tende della Protezione civile (una per ogni dieci persone circa), contornate da un doppio filo. «All’inizio c’erano reti e materassi, ma poi gli hanno sequestrato le reti, perché venivano utilizzate come scale per scavalcare il muro e scappare», ricordano gli avvocati Accetta e Coppola. «I materassi erano poggiati direttamente a terra, è stato un aprile molto piovoso, così i ragazzi hanno dormito sul bagnato per giorni e giorni. C’era un solo bagno chimico e per andarci bisognava chiedere alle forze dell’ordine di essere accompagnati, per cui, soprattutto di notte, quando le guardie si ritiravano, i migranti non potevano accedervi ed erano costretti ad utilizzare bottiglie e buste di plastica. Consumavano i pasti sui bidoni della spazzatura, perché gli erano stati sequestrati anche i tavoli. Non abbiamo mai visto così tanti arti fratturati come in quei due mesi. I nostri assistiti ci raccontavano che durante i tentativi di fuga o nei momenti di tensione arrivavano le forze dell’ordine in automobile e investivano chiunque gli passava davanti. C’erano decine di ragazzi con gambe e braccia ingessate».
Il 25 aprile ci sono stati i primi scontri e le prime cariche della polizia, a seguito del tentativo di fuga di alcuni. Quel giorno in molti sono riusciti a scappare e nel Cie sono rimaste circa centotrenta persone. Nelle settimane successive altri ragazzi sono fuggiti e l’8 giugno, quando il centro è andato a fuoco, erano rimasti solo in novantotto. A tutti era già stato notificato il diniego della commissione territoriale di Caserta per il riconoscimento della protezione internazionale. «Noi abbiamo assistito a tutti i colloqui», continuano a raccontare i legali: «C’erano molte persone che avevano subito persecuzioni sotto il regime di Ben Alì e durante la rivoluzione, ma la commissione non ha concesso la protezione a nessuno, tranne che ad un ragazzo, forse perché si era lasciato andare a forti emozioni durante l’intervista. Era scoppiato a piangere dopo avere raccontato del fratellino morto tra le sue braccia, ucciso da un cecchino durante una manifestazione».
Su novantotto richieste, novantasette dinieghi. C’erano omosessuali che subivano persecuzioni nel loro paese, c’era una guardia del corpo del cognato di Ben Alì, costretto a scappare perché gli abitanti della sua città lo avevano identificato come un uomo del regime, ma la commissione non ha dato credito a nessuno. Le motivazioni dei dinieghi sembrano ciclostilate, uguali per tutti: “I richiedenti non risultano credibili e non sono meritevoli di protezione”. Gli avvocati ricordano che molti ragazzi durante le audizioni non sono riusciti a raccontare con dovizia di particolari i loro trascorsi in Tunisia, perché troppo stressati dalla condizione che stavano vivendo nel CIE e inibiti da una commissione poco clemente. Ce n’è stato uno che ha raccontato che durante una manifestazione pacifica le forze dell’ordine tunisine gli hanno fratturato il setto nasale. La presidentessa della commissione gli ha domandato: «Scusa, ma uno che va a una manifestazione non se l’aspetta di tornare a casa con il naso fratturato?». Un altro nel corso del colloquio ha tirato fuori una bottiglia con un serpente vivo dentro, lo aveva trovato nella tenda della Protezione Civile.
«La commissione di Caserta è un “dinieghificio”: adesso per esempio sta diniegando i libici», spiega l’avvocato Accetta. «Un uomo che conosco, cittadino libico naturalizzato da tre generazioni, ha ricevuto il diniego dalla commissione perché è nero e quindi secondo loro non è credibile che sia libico. Diniegare un libico nero oggi significa mandarlo a morire, perche in Libia sarà accusato di essere un mercenario di Gheddafi».
L’8 giugno un incendio ha messo fine all’esperienza del CIE di Santa Maria Capua Vetere, il primo e forse ultimo della regione Campania. I detenuti sostengono che sono stati i lacrimogeni a incendiare le tende, le forze dell’ordine invece assicurano che l’incendio è stato appiccato dolosamente. La caserma è stata sequestrata e posta sotto sigillo e i migranti sono stati trasferiti in diversi centri di accoglienza per richiedenti asilo del sud Italia. Dopo tre o quattro giorni, però, qualcuno è stato di nuovo chiuso in un CIE, in base a un criterio che ai legali ancora oggi sfugge. In quei giorni la comunicazione con le questure competenti è stata impossibile. «Noi stavamo facendo i ricorsi contro i dinieghi alla richiesta di protezione, e avevamo quindici giorni per presentarli», lamentano gli avvocati. «Dovevamo sapere dove erano i nostri assistiti per assicurare loro il diritto di difesa, ma la questura di Caserta non ci ha mai risposto. Se i ragazzi non avessero iniziato a telefonarci, non avremmo mai saputo dov’erano».
Dopo quel fatidico 8 giugno le cose sono iniziate ad andare meglio. Il Tribunale ha sospeso tutti i dinieghi e chi era ancora in un CIE è potuto uscire con un permesso di soggiorno per richiesta di asilo. «Ora iniziamo ad avere le prime sentenze – proseguono i legali – e per ora ne abbiamo ricevute una trentina, tutte positive. Il tribunale sta riconoscendo a tutti la protezione umanitaria sulla base del fatto che i diritti umani non hanno scadenza: se il nostro governo ha riconosciuto l’esigenza di dare protezione umanitaria ai ragazzi arrivati prima del 5 aprile, non si capisce perché la stessa protezione non debba essere riconosciuta a chi è arrivato nei giorni successivi. Purtroppo noi abbiamo perso le tracce di molti, per cui non sapranno mai di avere ottenuto la protezione umanitaria».
Ma perché il centro di Santa Maria Capua Vetere è stato gestito così male? Perché tanta violenza, tanta incapacità, tanto denaro speso inutilmente? «Forse perché non sapevano come gestire la situazione», ipotizza l’avvocato Accetta. «Forse proprio per il fatto che un CIE qui non c’è mai stato e dalla sera alla mattina prefettura e questura si sono trovati a gestirne uno; forse perché hanno pensato di seguire alla lettera le direttive ministeriali, in base alle quali coloro che erano arrivati prima del 5 aprile erano considerati meritevoli di protezione, mentre gli altri erano solo dei criminali da rimpatriare». (marzia coronati)

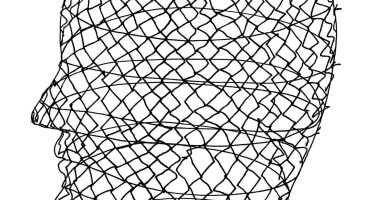
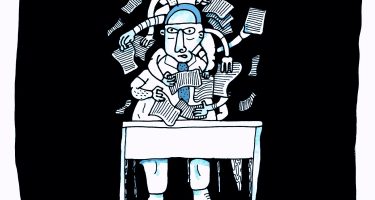


Leave a Reply