
Nel tardo pomeriggio del 15 luglio 2016 è stata emessa la sentenza di primo grado del cosiddetto processo Resit, dal nome della discarica nel comune di Giugliano di proprietà dell’ex avvocato e imprenditore Cipriano Chianese. Un processo importante e complesso, che durante centottanta udienze in sei anni ha sviscerato la storia, le modalità di gestione e le conseguenze ambientali degli invasi della società Resit in un lasso temporale di vent’anni (dal 1985 al 2004), nonchè i rapporti tra Resit e Commissariato all’emergenza rifiuti urbani della regione Campania. I giudici della V sezione della Corte d’Assise del Tribunale di Napoli erano stati chiamati a pronunciarsi sulle accuse di disastro ambientale, avvelenamento della falda acquifera, riciclaggio, estorsione, associazione mafiosa, truffa ai danni dello stato, traffico organizzato di rifiuti, violazione di sigilli e una molteplice serie di falsi ideologici, mosse dalla procura di Napoli nei confronti di ventisette persone coinvolte a vario titolo. La sentenza (le cui motivazioni saranno depositate entro centottanta giorni) conclude il primo grado con quindici condanne e dodici assoluzioni, per complessivi centodiciassette anni di carcere comminati. Cipriano Chianese, principale imputato e additato da diversi pentiti fin dal 1993 come figura chiave dello smaltimento illecito di rifiuti industriali in Campania, è stato condannato a vent’anni per i reati di disastro ambientale e avvelenamento delle acque dolosi, e per associazione mafiosa; sedici anni a Gaetano Cerci (già in carcere per estorsione) per associazione mafiosa e disastro ambientale; Giulio Facchi, ex-subcommissario all’emergenza rifiuti tra il 2000 e il 2004, è stato condannato a cinque anni e sei mesi per disastro e avvelenamento colposi. Condannati invece a dodici anni Remo Alfani e Mosé di Meo, tecnici incaricati in momenti diversi di certificare le opere di messa in sicurezza della discarica Resit. Per i fratelli imprenditori Generoso, Salvatore ed Elio Roma – esclusi dal reato di disastro ambientale – tra i cinque e sei anni di condanna per concorso esterno con l’associazione mafiosa dedita al traffico di rifiuti organizzata da Chianese e Cerci. Per gli altri imputati condannati, gli anni di reclusione vanno da quattro a sei anni e mezzo.
Gli esiti, lo svolgimento e le ripercussioni di questo processo vanno analizzati con cura, e va tenuta alta l’attenzione sulle possibili svolte ai successivi gradi di giudizio. Siamo solo al primo grado, e tutti i condannati presumibilmente ricorreranno in appello. Ma per il momento un dato fondamentale è stato accolto dai giudici, il più contestato nelle requisitorie della difesa: la gestione criminale della discarica Resit ha causato un disastro ambientale e l’avvelenamento delle acque, comportando la contaminazione delle matrici ambientali e, di conseguenza, un grave pericolo per la salute pubblica. Per la terza volta in Campania (dopo le condanne ai fratelli Pellini di Acerra e al boss Bidognetti del clan dei casalesi) un tribunale ha stabilito che disastro e avvelenamento dolosi ci sono stati. Il pubblico ministero Alessandro Milita ha basato l’accusa sulla perizia del consulente tecnico Balestri, la quale ripercorre le varie fasi degli allestimenti d’invasi nelle cave di Chianese, dei conferimenti e delle autorizzazioni falsate, mettendo insieme le analisi effettuate nel corso degli anni da agenzie governative con nuovi rilevamenti geologici e ulteriori analisi fisico-chimiche. Secondo Balestri, la mancanza di teli di protezione sul fondo discarica, l’assenza di sistemi per la corretta gestione del percolato e del biogas, la continua immissione di rifiuti urbani e tossico-nocivi ben al di là della capacità degli invasi, e la creazione di buche non autorizzate nei pressi delle cave principali, hanno causato la compromissione della falda acquifera sottostante. Da qui la rilevanza dei due riferimenti normativi del codice penale utilizzati da Milita e accolti dai giudici: l’articolo 439, avvelenamento delle acque, e l’articolo 434, altri disastri dolosi. Il nodo contestato dalla difesa riguarda l’effettiva contaminazione e quindi il rischio relativo per la popolazione. La questione è complessa, ma va affrontata per meglio comprendere il ragionamento del pm e le ripercussioni su agricoltura e salute umana.
Una delle evidenze avanzate dalla difesa per contestare il reato di disastro è un documento dell’Istituto Superiore della Sanità del giugno 2013, denominato “Supporto tecnico scientifico per la caratterizzazione delle aree agricole dell’area vasta di Giugliano in Campania”, nel quale si certifica che non c’è un passaggio dall’acqua alle piante per i composti organici volatili presenti nei pozzi attorno alla discarica. I campioni di ortaggi e frutta raccolti vicino alla Resit, quindi, non veicolano i contaminanti e non fanno ammalare le persone. Ciò è suffragato sia da analisi private a cura di imprenditori agricoli, sia dalle campagne di monitoraggio dei prodotti promosse dalla Regione. Questo non vuol dire che le acque inquinate non siano pericolose per il consumo umano, tutt’altro; ma per l’uso irriguo, data la capacità di assorbimento selettivo degli apparati radicali delle piante, possono e vengono attualmente utilizzate in casi determinati sia in Italia che in Europa. Il problema nella nostra legislazione è che il riferimento normativo per la qualità delle acque utilizzate in agricoltura è la legge 152/06 che regola le CSC (concentrazioni soglia di contaminazione, superate le quali per determinati elementi chimici un sito o una falda vengono considerati potenzialmente contaminati) dei suoli a verde pubblico, privati e residenziali. Le CSC per le acque irrigue dovrebbero invece essere calcolate a partire dai valori di fondo presenti nelle matrici ambientali, cosicché, per fare un esempio, una data quantità di rame o stagno non venga considerata di per sé inquinamento, ma solo in relazione alle quantità di rame o stagno già presenti in sito per cause naturali. La validazione dei valori di fondo è di responsabilità delle regioni, e al momento in Campania ne siamo ancora privi. Tale falla ha condotto al sequestro preventivo da parte della magistratura, tramite riferimento alle CSC della legge 152/06, di più di venti terreni adiacenti a pozzi incriminati nell’area caivanese tra il 2013 e il 2014, mandando in rovina diverse aziende agricole i cui prodotti sono poi risultati salubri. Tali sequestri, rivelatisi infondati, hanno amplificato i timori nella popolazione che alimentarsi con i prodotti agricoli della piana campana potesse contribuire all’insorgenza di malattie. E questo mentre programmi televisivi e giornalisti d’assalto già da qualche tempo dipingevano la Campania come “inferno atomico”, dando credito ai vaticini di un pentito, Carmine Schiavone, che sembrava raccogliere più fiducia di gruppi di ricerca scientifica, come il progetto Ecoremed, impegnati a certificare la salubrità dei prodotti agricoli in terra campana e a implementare procedure di bonifica ecologica per i terreni effettivamente contaminati.
E la falda dell’area vasta? Come si configura il disastro? Non sappiamo ancora con quali ragionamenti i giudici del processo Resit hanno accolto le prove di contaminazione della falda e di disastro ambientale, dovremo aspettare le motivazioni della sentenza. Ma sarebbe comunque un errore riportare, come tentano di fare i consulenti tecnici della difesa, la questione dell’avvelenamento causato dalla Resit solo sul piano di disquisizioni tecniche sul grado di permeabilità del tufo e sulla numerologia inerente le soglie di contaminazione, utili in fondo solo a fornire cavilli agli imputati. Il processo Resit ha certificato che dalla metà degli anni Ottanta negli impianti di Chianese sono finiti rifiuti tossico-nocivi in enormi quantità, in assenza di presidi tecnico-ingegneristici che ne prevenissero la diffusione nell’ambiente, generando profitti per lui, per i suoi sodali e per gli imprenditori del nord che potevano smaltire a prezzi stracciati. Rimpinzare di veleni una terra densamente popolata e a vocazione agricola, al di lá di come, quanto e quando questi veleni arriveranno a causare morte e distruzione, è già di per sé un reato (che infatti le norme 439 e 434 del codice penale considerano tale per il potenziale pericolo anche in assenza di legami diretti con la morte di persone). Il pm non ha collegato l’inquinamento della Resit a precisi casi di decesso; ha dimostrato come e quanti veleni sono stati accumulati, configurando disastro e avvelenamento.
Nel merito del processo, le condotte per cui gli imputati sono stati condannati dipingono un quadro che lascia poco spazio ai dubbi. Decine di collaboratori di giustizia avevano raccontato di Chianese come “re delle ecomafie”, soprattutto il pentito Gaetano Vassallo, che con Gaetano Cerci e Francesco Bidognetti formava il gotha degli smaltitori abusivi del casertano. A detta dei suoi ex collaboratori, Chianese fu l’inventore delle tecniche per fluidficare i traffici di rifiuti tossici, colui che trovava sempre un buco utile per la monnezza in Campania. Aveva amici potenti, si confrontava con i camorristi alla pari e sapeva guadagnare dallo smaltimento illecito come dalla collaborazione con le istituzioni governative. Le indagini hanno confermato le deposizioni e hanno aggiunto dell’altro. Chianese aveva le autorizzazioni a ricevere rifiuti speciali nei propri impianti e tramite queste poteva emettere documentazione pulita per far viaggiare legalmente i carichi dal nord alla Campania. I fratelli Roma si occupavano del trasporto e fornivano certificati falsi sulla natura e sull’origine dei rifiuti. Tra il 1987 e il 1994 arrivarono alla Resit le maggiori quantità di rifiuti tossici, tra cui i famigerati fanghi dell’Acna di Cengio, sepolti anche a Pianura, che riempirono ben oltre la capacità gli invasi disponibili. Ma Chianese riusciva a creare “un’infinita capienza delle discariche”, che nella fattispecie vuol dire che scavava altre fosse nei pressi dei suoi impianti o faceva arrivare solo nominalmente i rifiuti alla Resit, inviandoli poi verso siti di smaltimento clandestini. Già dal 1997 riuscì a ricevere i rifiuti urbani che intasavano le città campane nei primi atti della perenne emergenza. Il vero colpo, però, arrivò nel 2001, quando il sub-commissario Giulio Facchi incluse la Resit tra i siti disponibili per conferire i rifiuti urbani in Campania, concedendo un ulteriore venti per cento di capacità (nei fatti inesistente) di accogliere rifiuti speciali. Poco dopo, e fino al 2004, il Consorzio di Bacino Na 3 considerò la Resit adatta allo stoccaggio di ecoballe prodotte dalla Fibe, e le abbancò sulle montagne di veleni.
Le sorti di Chianese e della sua creatura Resit ci raccontano un pezzo importante di quell’affare gigantesco che ha portato milioni di tonnellate di rifiuti tossici in Campania e dell’intreccio con le vicende politiche e gestionali dell’emergenza rifiuti urbani. I lati poco chiari sono numerosi: le condanne esemplari cozzano con le assoluzioni eccellenti (Bassolino era il superiore di Facchi nel periodo dei reati per cui il secondo è stato condannato), e ancora una volta restano fuori dal quadro gli imprenditori di industrie e manifatture che si sono avvalsi dei servizi dell’ecomafia, aumentando così i propri bilanci e forse persino il Pil del paese. Gli studi sui legami tra rifiuti interrati e bruciati, diffusione degli inquinanti e stato di salute della popolazione, per quanto da qualche anno vi siano fondi, leggi dedicate e gruppi di ricerca impegnati, non sono ancora in grado di rassicurare gli abitanti della Campania. Sappiamo con certezza che alle latitudini di Napoli e Caserta si muore di più che nel resto d’Italia per lo smantellamento sistematico del servizio sanitario pubblico. E molti indizi suggeriscono che il degrado ambientale di alcune aree è in rapporto con l’aumento di diverse patologie per chi vive nei pressi. Solo approfonditi studi di micro-aree e campagne di biomonitoraggio individuale potranno chiarire questi legami, revocando definitivamente il sospetto dai prodotti agricoli. Tali incertezze, e gli interventi di poca sostanza delle istituzioni preposte, hanno seminato divisioni tra parti della società civile. Gli agricoltori, dopo gli attacchi mediatici e i sospetti diffusi dagli attivisti meno avvertiti sui loro prodotti, si sono chiusi a riccio, formando le proprie associazioni e i propri gruppi di pressione, senza costruire, a parte rari casi, nuovi legami con i consumatori e i movimenti sociali. Dall’altro lato, la coalizione di comitati popolari che si formò alla vigilia della manifestazione Fiume in piena nel 2013 è ormai un ricordo, e dalla partecipazione di massa si è tornati a piccoli gruppi che conducono vertenze isolate.
Le sfide sono ancora tante. La sentenza Resit segna un punto fondamentale in campo legale: le leggi attuali permettono di condannare gli ecocrminali. In quanto alla giustizia, però, ci sembra che le condanne possano ridursi a mero capro espiatorio se non si cambiano le condizioni alla base delle condotte che causano inquinamento. Le rivendicazioni avanzate in anni di lotte hanno indicato un modello di transizione ecologica e politica rimasto irrealizzato, che è stato cooptato e depotenziato quando i parlamenti non hanno potuto più ignorarlo. Forse bisogna smettere di attendere risoluzioni dai tribunali e dai governi, e iniziare di nuovo a organizzarsi sui territori per cambiare profondamente i rapporti tra città e campagne, tra produttori e consumatori, tra istituzioni e cittadinanza. Cosicché, il prossimo Chianese non trovi né spazio né supporto per realizzare l’ennesimo disastro ambientale. (salvatore de rosa)



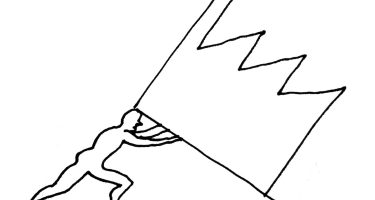

Leave a Reply