
Dal n. 54 di Napoli Monitor
In mezzo alla Trinità – come usa dire chi i Quartieri Spagnoli li vive quotidianamente – c’è una piccola piazzetta, uno di quei rari slarghi che ti permettono di guardare almeno una porzione di cielo e i suoi colori. Dipingevo le mie solite mostruosità su una della porte che affaccia su questa piazza quando Gianni, mio piccolo aiutante, alza di scatto la testa e mi segnala col dito una finestra. Dietro i vetri appannati – poteva essere febbraio – una sagoma sgattaiola veloce. Faccio appena in tempo a vederla che è già sparita. Gianni dice che in quel palazzo ci sono i fantasmi, lo sanno tutti. Io non ci giurerei ma – gli dico – sai che anche in quel palazzo di fronte c’è una strana presenza? Si chiama Enzo Gragnaniello, dicono sia un cantante ma forse gli sta stretto, a me pare piuttosto un poeta. La sua voce dice. Sì, ma cosa dice?, m’interroga Gianni. Cose millenarie gli rispondo, che con il suono ti arrivano dritte al cuore. Prima, molto prima del senso.
«Io sono nato a vico Cerriglio, il vicolo più stretto di Napoli. Sono nato int’a casba proprio, chella là strettissima e quindi c’è stata sempre questa voglia di spazio. Io la casa la devo tenere all’ultimo piano, perché devo salire sul terrazzo e aggia guardà ‘o ciel. Perché sono nato in un vico dove tutta la vita ho tenuto il muro davanti. Sono cresciuto con un muro davanti.
«A quattordici anni stavo a Milano, da solo, stavo coi barboni, facevo una vita libera, nun me ne futtev’ ‘e nient. Sono del ’54. Per cui nel ’68, a quattordici anni, me ne andavo a Milano, mi serviva più spazio. Non mi sentivo oppresso, ma insomma, i problemi, la famiglia, tenevo voglia di vivere senza sentire a nessuno. Per andare in Svizzera serve la tessera valida per l’espatrio e la mia non era valida, più di Milano non potevo. A Milano mi acchiapparono e mi portarono al Beccaria, il carcere minorile, e così mi riportarono a Napoli. Io partii un’altra volta. Non suonavo ancora, ero nu guaglione, ero alla ricerca di qualcosa, volevo essere libero da tutti. Per me la famiglia erano più i barboni, la gente così, ma poi i barboni erano tutti questi capelloni dell’epoca, tutti giovani, ma più grandi di me, che se n’erano andati via anche loro…
«Io sono naïf. Ti dico la verità, non è presunzione. Tutto quello che definisco arte, sin da piccolo mi ha sempre attirato, mi ha sempre affascinato. La strada è stata una grande maestra. A Milano mi sentivo libero… A me da piccolo piaceva da Elvis Presley a finire ad Adriano Celentano. Poi lavoravo in un locale fuori al porto, il River, e stavo sempre con gli americani e sentivo solo la musica americana. Facevo il barista la mattina e la sera andavo facendo ‘e marenne, ‘e colazioni, prendevo le birre, le portavo giù, le mettevo nel frigorifero, insomma ero un ragazzo molto attivo. La mattina vendevo le sigarette negli uffici, portavo il caffè e quindi pure le sigarette, andavo a Forcella e pigliavo gli accendini, vendevo un sacco di roba. Ho vissuto così e la musica l’ho ascoltata assai giù al locale. Sia i complessi che venivano a suonare, sia i juke-box, e il più gettonato per me era Otis Redding, mi piaceva assai la sua voce, mi piaceva sentire le sue canzoni. Ho cominciato a suonare a qualche matrimonio di amici, cose di ragazzi. Poi sono entrato nei disoccupati organizzati dei Banchi Nuovi, negli anni Settanta, quando erano appena nati. Mi piaceva quella realtà, perché avevo l’occasione di conoscere pure altre cose: i ragazzi più preparati, più politicizzati. Mi piaceva confrontarmi con altra gente, perché poi i compagni miei quelli erano – ‘o burdell, ti devi fare il territorio nel linguaggio, devi far capire che tu sei cchiù figl’ e zoccola ‘e iss, pure col suono, con la voce, come i cani che si vogliono fare il territorio, che usano i suoni –, e insomma ero abituato così, invece là sentivo parlare questi ragazzi con un linguaggio più italianizzato, molto educato e intelligente. E io, cazzo, ero affascinato. Pensavo: “Ma questo è il linguaggio che piace a me!”, e così venivo coinvolto. Poi di tendenza ero di sinistra, papà era comunista, lui vendeva i libri con la bancarella, ha faticato nei giornali, portava i giornali. Ha faticato sempre così finché come disoccupato pure lui ebbe il posto nel comune. Però i Banchi Nuovi sono stati importanti. Formammo questo gruppo musicale, era fatto da due disoccupati, che eravamo io e Gennaro De Rosa, un amico mio che il tempo non lo conosceva proprio, non sapeva suonare niente, teneva una tamburella in mano giusto perché tra compagni eravamo così, pe n’o fa piglià collera… Si ruppe pure la mano, e stava con la mano piena di sangue, la tammorra gli ruppe la mano, la tammorra piena di sangue ma lui continuava a suonare, come se stessimo combattendo. Si era ferito, però continuava a combattere. Era così Gennaro, però a me mi faceva venire ‘e cose int’o stommaco, perché non sopportavo il suo fuori tempo, ma non gli dicevo niente e manco i compagni, perché noi eravamo così, non gli volevamo fa’ piglia collera. E poi mi sono messo per fatti miei, ma dopo tanto tempo.
«Là scrivevamo canzoni di lotta, e molti slogan dei disoccupati che ancora oggi si usano sono stati scritti da me. Quelle canzoni non sono mai state incise, non lo so se si sono tramandate, perché questo gruppo poi non esisteva più già negli anni Ottanta. La sede era a vico Banchi Nuovi, mo stanno a San Severino. Poi quando mi staccai vidi che c’era il produttore di Pino Daniele, Claudio Poggi, a cui avevano parlato di questo ragazzo che sapeva cantare bene e scriveva belle cose e mi volle conoscere. Io, in verità, non ci pensavo manco. Noi siamo andati a scuola assieme con Pino Daniele (mostra una foto), alla Oberdan, dietro la Posta, eravamo dello stesso quartiere. Al produttore suo piaceva e quindi là cominciò il rapporto. Il primo disco si chiamava solo con nome e cognome, senza titolo. Poi abbiamo continuato. Mi hanno chiesto di scrivere per altri, io non avevo mai pensato di fare l’autore, mi cercavano una cosa e io scrivevo. A Mia Martini ho scritto “Donna” e poi a Murolo, qualche canzone a Celentano, a Bocelli, l’ultima a Sanremo a Maria Nazionale, ma poche cose, non molte. Comunque è grazie alle canzoni che sono potuto andare avanti, pure economicamente, perché il modo mio di fare la musica non è tanto commerciale, non rientra nelle cose che me putessero dà a campà. E poi non mi espongo molto. Sono molto riservato, non mi piace apparire per forza, fare questo lavoro per forza, come se fosse chissà cosa… Così tieni la possibilità di stare più libero, perché a me interessa la libertà, non ce la faccio a stare legato, per esempio ‘o cuntratt, uà, che palle! Non puoi fare niente, stai bloccato mani e piedi. Queste cose che mi opprimono le ho evitate tutte, tenevo i produttori e se lo vedevano loro. Bisogna fare delle scelte, perché viene prima la libertà, poi tutto il resto.
«Non si può parlare solo del problema del lavoro. È troppo grossa questa città per parlare solo di questo, s’adda arrivà ‘nu poc dopp. Qua assorbiamo sempre, nuje simme spogne, proprio spugne marine. Assorbire e poi farlo filtrare da un sentimento, che è quello che poi appartiene a questo popolo. Un sentimento che si è dimenticato. Bisogna ricordare un’altra volta chi siamo. Perché questo è un popolo di grande creatività. Specialmente nei quartieri popolari. In tutti i quartieri ci stanno i geni, però spesso il loro potenziale, il talento, la loro arte, viene trasformata in negativo, perché non si ricordano più chi sono e si sentono perseguitati dall’umanità: non tengono il lavoro, non tengono una cultura precisa, non hanno strutture che permettono di confrontarti, di rilassarti, di aprirti. Però bisogna lavorare, secondo me la cultura è importante. La cultura per i napoletani sai che r’è? L’emozione. Se tu li fai emozionare, loro cominciano a riconoscere pure la cultura. È come la pianta che viene annaffiata e piglia forma. È un popolo che si deve ricordare che ci vuole un’altra volta la poesia. Le persone più intelligenti devono trasmettere di più, devono sensibilizzare con l’arte, la poesia, la gentilezza. Perché questo è un popolo che può dare molto. Questi hanno sempre creato, hanno sempre vissuto su quello che si sono inventati. E in questo quartiere, che ha anche i palazzi storici, ci sono degli archi, ci sono cose che in un certo senso non ti fanno sentire emarginato, non ti fanno sentire nell’hinterland.
«E ci stanno i fantasmi! Pure questo fa parte della cultura nostra. Ma tu ci pensi se noi recuperassimo un’altra volta tutti i fantasmi che se ne sono andati? Perché noi amma fatt fujì i fantasmi. Una volta questo popolo parlava con gli spiriti e lo spirito ci diceva tutto. Mo se ne sono andati, li abbiamo fatti fuggire. Con chi parliamo noi? Qua si parla sempre di aggiustare le cose, ma poco ci credo che due più due fa quattro, a me fa paura quando una cosa è troppo razionale. Questo è un popolo che è stato “razionalizzato”, dobbiamo cercare un’altra volta l’irrazionalità. Siamo come un pesce fuor d’acqua, noi stavamo bene nell’irrazionale. Tutte le cose dette così, spontanee, senza filtro, non più pensate, quella libertà di pensiero, quella saggezza… Questo per quanto riguarda il lato dei valori. Poi dipende, ‘e che vulimm parlà? Se vogliamo parlare di come vanno le cose sociologicamente, ‘o sapimm tutt quante. Io che ti posso dire? Lo dice stesso la televisione.
«Io vengo visto come un artista serio, uno che scrive belle cose, cioè non sono il neomelodico, ma sono un poeta, che ne saccio, uno che sta là, ma non è che ho questo grande rapporto… Ho il rapporto quotidiano con la gente, però l’importante è che io sono uno di loro, sono una voce di qua che cerca di comunicare qualcosa. Poi loro quando sono pronti capiscono pure uno che ha voluto dire. Adesso sono un popolo disorientato, qua si dice cultura “popolaresca”, perché è una cultura coi codici dei vicoli, non è cultura popolare, è popolana. Però c’è anche la cultura popolare qua, ci sono tante persone che sono napoletane al cento per cento, più inserite, più intellettuali, non è che qua ci stanno solo le persone che non vanno a scuola, ci stanno anche i magistrati, ci sta un sacco di gente, di professionisti. Certo quando uno parla dei Quartieri Spagnoli pensa sempre alla povera gente, pensa sempre ai disagiati. Ma stanno un sacco di loro che vanno a faticà e vonn’ sta quiet’ ‘a matin. Una volta pure se uno andava a rubare e l’altro andava a lavorare erano comunque amici, perché alla base c’era una convivenza, invece mo uno dice: “Ma tu perché nun vaje a faticà?” e chill’at dice: “Ma tu perché nun te faje ‘e cazz tuoje?”.
«Sono successe un sacco di cose, troppe televisioni a colori, al plasma, secche secche e longhe e accussì e accullì. Ci hanno controllato alla grande. E la gente o è di Napoli o è della Sicilia o è di Udine, la gente è la gente, se stanno davanti alla televisione si robotizzano, diventano una cosa sola. L’unità d’Italia coi programmi, questo è successo. Noi che teniamo ancora un minimo di sentimento, io che creo, faccio le cose, cerco sempre, nel mio piccolo, di dare un modo di vedere diversamente. Ma qua come stanno le cose ci vogliono tre-quattrocento esorcisti, tra i più bravi al mondo. Poi ci vogliono millecinquecento sociologi, insieme agli psicologi, ai giovani che si inseriscono all’interno di tutti i quartieri e se mettono a ffà ‘ammor cu’ ‘e guaglione d’o quartiere, ‘e guagliun se mettono cu ‘e psicologhe, bisognerebbe fare un ammiscafrancesca alla grande, dove questi preparati trasmettono.
«Sicuramente la cosa positiva la porteranno gli immigrati, perché le culture loro sono molto più religiose delle nostre, molto più educate, sono persone che hanno vissuto grandi problemi e tengono ancora il sorriso, possono portarci molta energia positiva, ma dobbiamo essere aperti. E quelli che l’hanno capito devono fare in modo di farlo capire pure agli altri, che questi nuovi inquilini, questi nuovi amici, come li vogliamo chiamare, non è un caso che stanno qua, è proprio per farci conoscere il mondo più da vicino, per aprirci, per cominciare a crescere. Perché noi sottovalutiamo il disegno universale, noi stiamo sempre a pensare all’angolino nostro, a Berlusconi, noi dobbiamo uscire fuori, andare oltre il nostro naso, dobbiamo fare Star gate, ti ricordi quel cerchio, quella porta, e trase int’a n’ata dimensione. Noi dobbiamo entrare in un’altra dimensione per ricordarci chi siamo, da dove veniamo, che vogliamo, perché noi siamo temporali, a un certo punto non ci stiamo più. Perché dico la poesia? Perché la poesia racchiude non solo la bella parola, la parola detta, ma anche la stretta di mano, e poi tutto quello che è gentile. Perché lo spirito delle persone, pure quello del più fetente, ne ha bisogno, perché è arido, non vuole essere più indicato col dito, s’è cacat ‘o cazz. Vuole le persone forti vicino. Le persone forti sono gentili. I deboli fanno i forti.
«Dedicai un pezzo ai Quartieri, “La città delle razze”, in un disco che si chiama “Neapolis Mantra”, strumentale, con la voce, come se fosse una preghiera. E poi “Evviva ‘e razze”. Ormai sono anni che vivo da multietnico. Io vedo un bellissimo futuro, nun ‘o ssaccio, ma vedo un bellissimo futuro». (cyop&kaf)


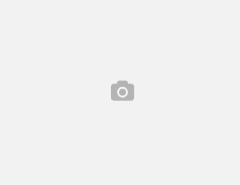


Leave a Reply